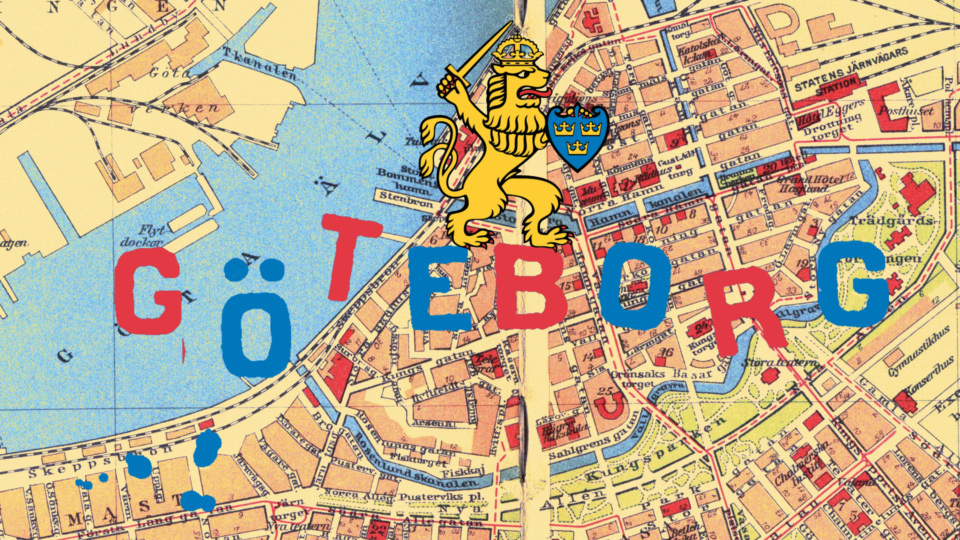Göteborg non è perfetta, ma è reale: qui la modernità non cancella la memoria, il design non sostituisce la comunità e l’innovazione convive con la gentilezza.
Un robusto quarantenne in bretelle rosse, tese su una bianca camicia sudata, sventola felice la mano come a salutare una vecchia amica. Fossimo in una folla, penserei si stia rivolgendo a qualcuno alle mie spalle. Ma nel sonnacchioso paesino di Surte – un piede fuori da Göteborg – sono certa che saluti proprio me: non c’è nessun altro in giro nell’ora di Pan di questo giorno d’aprile in cui, per una volta, anche in Svezia è primavera. Abbiamo 15 gradi (che qui scaldano come 20) e l’uomo ha appena finito di potare i dodici tigli che contornano il giardino dall’altro lato della strada. Sotto il viso paonazzo, la barba fulgida di sudore scende fino al petto e segue vibrante il flusso allegro delle sue parole, volte alla bellezza di quella giornata carezzevole. Sto al gioco: poggiate le mani a pugno sui fianchi, da brava comare, ci scambiamo qualche banalità, salutandoci poi senza approfondire oltre.
Questo cordiale giardiniere è il prototipo del go’ gubbe, “simpatico omino”, che rende Göteborg così speciale e amata in tutta la Svezia: basta un nulla e parte la chiacchiera spontanea con perfetti sconosciuti, condita da qualche battuta rapida e tagliente in pieno sense of humor gossemburghese – curiosamente affine a quello romanesco – proferita in una calata dialettale larga come un’operaia pacca sulla spalla.


Göteborg è una città d’acqua e di vento, con interminabili rovesci, poesia di refoli e schiaffi di tempesta; una città di tramonti indimenticabili e ventosi come Trieste, con cui oltre all’orientamento cardinale condivide il passato di terra contesa e di tante etnie. La multiculturalità di Göteborg è visibile in ogni strada: un terzo dei suoi abitanti è nato fuori dalla Svezia, un terzo dei quali da uno stato europeo. Flussi migratori con corsi e ricorsi: è dal porto di Göteborg che ha lasciato il Paese quel milione di svedesi fuggiti nell’Ottocento a cercar fortuna in America. È su questa città che hanno posato il loro ultimo sguardo.
Nonostante nel corso degli ultimi quarant’anni si siano ingracilite le due gambe su cui si è a lungo poggiata la forza lavoro della città – operai e portuali – Göteborg mantiene una sua essenza proletaria schietta, simpatica e grezza; anche dai più ricchi o famosi si esigono umiltà e piedi per terra – popstar locali comprese. Pur nel benessere economico di oggi, resta nel Dna la vocazione alle lotte dal basso, cominciate negli anni Settanta da cittadini coraggiosi che si sono opposti all’abbattimento dei vecchi quartieri proletari per far posto alla nuova edilizia – aree diventate oggi attrazioni turistiche e culturali senza passare per una radicale gentrificazione; così come restano ancora orgogliosamente in piedi le vestigia dell’industria navale: il rosso ruggine di gru e carroponti taglia l’azzurro della skyline gossemburghese lungo la sponda nord dell’estuario del Göta, il fiume che divide in due la città, confine naturale tra norvegesi e danesi.
Fino al 1621 la Svezia ha solo potuto affacciarsi sul fiume, ma non insediarsi in modo permanente. Proprio nel cuore del paesino in cui abito, qualche chilometro più a nord del centro, una striscia sbieca di sampietrini taglia il marciapiede a ricordo dell’antico confine tra Norvegia e Danimarca, nazioni ora distanti 480 chilometri. Quattro secoli fa, avrei vissuto in Norvegia, entrando in Danimarca ogni volta che facevo la spesa.
È stato solo nel Seicento – durante i cent’anni in cui la Svezia ha avuto il suo periodo di superpotenza con dominî in tutto il Nord Europa fino a Polonia e Germania – che il casato dei Vasa con Gustavo II Adolfo (il padre di Cristina di Svezia, per capirci) si impuntò per tenersi stretto quell’affaccio sul mare e iniziare i commerci fino in Cina senza dover fare tutto il periglioso giro del Baltico. In pochi anni venne costruita una città su progetto olandese, eretta con il sostegno di tedeschi e britannici. Ciascuno la battezzò a modo suo sin dalla nascita: fu Göteborg per gli svedesi, Gotenburg per i tedeschi e Gothenburg per olandesi e britannici. I nederlandesi ci tennero a chiamarla Nuova Amsterdam per un periodo, mentre uno dei vezzeggiativi che ancora perdura è Piccola Londra, dato che inglesi e scozzesi continuarono a mantenere interessi economici in zona fino alla fine dell’Ottocento, lasciando tracce nell’architettura civile e industriale.
Göteborg è una figlia d’Europa: nasce dallo scontro con due nazioni cugine e dall’incontro con tre nazioni nordeuropee. La sua tradizione cosmopolita non è mai appassita: si trova più o meno al centro di un ideale triangolo tra le tre capitali della Scandinavia: Copenaghen, Oslo e Stoccolma – quest’ultima, paradossalmente, la più lontana.
“Göteborg è una città d’acqua e di vento, con interminabili rovesci, poesia di refoli e schiaffi di tempesta; una città di tramonti indimenticabili e ventosi come Trieste, con cui oltre all’orientamento cardinale condivide il passato di terra contesa e di tante etnie”.
Il confronto con la capitale è inevitabile e, nonostante Carl von Linné abbia scritto nel 1746 “Götheborg [sic] è la più bella città del regno”, un secolo e mezzo più tardi August Stringberg, nel romanzo autobiografico Il figlio della serva (Tjänstekvinnans son, 1886), attribuisce al suo alter ego Johan riflessioni poco lusinghiere sull’estetica della città: “Una copia della capitale, ma rimpicciolita”, scrive. Aggiungendo, però: “Ma aveva qualcosa che mancava a Stoccolma. Arrivato al porto Johan vide che le navi avevano quasi tutte destinazioni estere, e che grandi traghetti collegavano la città con il continente. Tanto le genti quanto gli edifici non avevano un aspetto precipuamente svedese, e anche i giornali erano più all’erta sui grandi sommovimenti mondiali. Quant’erano più vicine Copenaghen, Kristiania [Oslo N.d.R.], Londra, Amburgo e Le Havre, qui! Stoccolma sarebbe dovuta sorgere in questa baia sul mare del mondo. […] Il nucleo di un nuovo epicentro era lì, e ora lui capiva che non era più Stoccolma a essere il fulcro del Nord: era Göteborg che lo stava diventando”.
Parole non esenti da iperbole, ma è vero che Göteborg primeggia su Stoccolma – e in generale su tutti i Paesi Nordici – per una serie di attrazioni turistiche e culturali, a cominciare con il Festival del Cinema, il Salone del Libro (Göteborg è anche Città della Letteratura dell’Unesco dal 2021), il rock festival Way Out West e i concerti memorabili allo stadio di Ullevi (frequentatissimo da Bruce Springsteen che lo riempie con date triple), l’enorme parco divertimenti di Liseberg (con attrazioni terrorizzanti), e poi decine di nuove opere di architettura moderna – tanto museale, istituzionale che civile – che spuntano ogni anno a cambiare il panorama della città; tra queste il Karlatornet, grattacielo di 73 piani da cui si vede fino al mare del Nord, dove collidono il salato braccio di mare dello Skagerrak a sud della costa norvegese, con il dolce Kattegatt che lambisce la costa danese, creando turbolenza di correnti che rendono da sempre fatalmente leggendaria la navigazione tra le trentamila isole granitiche della costa occidentale, un sontuoso e incontaminato parco naturale accessibile in mezz’ora al costo di un biglietto d’autobus, dove incontrare animali selvatici di ogni tipo.
Io poi sono particolarmente fortunata: a duecento metri dal mio portone comincia una foresta che prosegue a est per una ventina di chilometri, interrotta solo da laghi e corsi d’acqua immersi tra conifere austere mitigate dalle striature argentee delle betulle. La fauna boschiva è così presente che qualche settimana fa un’alce, seguita dal suo piccolo, mi ha tagliato la strada in pieno giorno, togliendomi il fiato. Lei nobile e dinoccolata mentre lui – ancora incerto sulle zampe ma determinato a non perderla di un passo – le trotterellava dietro senza fare quasi rumore sull’asfalto.

Vivere vicina alla natura ha aumentato il mio senso di meraviglia nei confronti dell’architettura moderna. Ci sono molti edifici sorprendenti a Göteborg, ma uno in particolare mi riempie di gioia: la sede della Facoltà di Tecnologia nel cuore del quartiere hypertech di Lindholmen, sulla riva settentrionale del fiume Göta. È un palazzo a pianta circolare coperto di pannelli colorati che porta il nome di Kuggen, “Ingranaggio”, dato che la circonferenza di ciascun piano aumenta man mano che cresce l’altezza, finendo per somigliare ai pignoni del cambio di una bicicletta. La sua forma non nasce però da un capriccio estetico, quanto dalla necessità di adeguarne la struttura alle soluzioni tecnologiche pensate in funzione del risparmio energetico – sforzo che gli è valso il premio per la sostenibilità del MIPIM di Cannes. (Il suo ideatore, l’archistar locale Gert Wingårdh, ha scoperto la sua vocazione in modo inaspettato: dopo un viaggio a Roma, incantato dal Pantheon, torna a Göteborg e decide di mollare Economia e Commercio e iscriversi alla facoltà di Architettura).
Non mi stanco mai di fotografare il Kuggen, forse per l’implicito dinamismo della sua forma circolare che mi sfida a cogliere al volo una segreta piroetta. Negli ultimi quindici anni è stato affiancato da decine di altri edifici con ambizione estetica che rendono Lindholmen uno dei miei quartieri preferiti. Non ci si inciampa per caso gironzolando per il centro, però, dato che si trova dall’altra parte del fiume, ma arrivarci è di per sé uno dei miei piccoli piaceri: ci sono due traghetti a trazione elettrica che fanno senza sosta la spola tra il centro e Lindholmen trasportando passeggeri e ciclisti. Partono ogni cinque minuti e durante il brevissimo tragitto non riesco mai a trattenermi dallo scattare qualche foto. Che siano le vecchie gru sulla riva settentrionale o il profilo massiccio della chiesa di pietra di Masthugget, arrampicata su una collina verso sud, o la fuga prospettica dell’estuario a occidente, cucita insieme dal ponte di Älvsborg, così elegante nella sua semplicità anni Sessanta. Quanta bellezza.

Ai piedi del Kuggen c’è l’ingresso di un altro mio posto delle fragole con cui incanto chi viene a trovarmi: lo spazio espositivo Älvrummet, dove è allestito un enorme plastico della città. Ha un po’ la funzione di piano regolatore pubblico in 3D: ciascun elemento urbanistico di Göteborg è riportato in scala 1:400, e gli edifici sono rappresentati da piccoli elementi in legno che ne riproducono la forma. Qua e là compaiono altri blocchi ma di colore bianco: sono le strutture architettoniche che ancora non sono state costruite. Man mano che vengono edificate, i blocchi bianchi vengono sostituiti da quelli in legno. Io sono nata e cresciuta a Roma e sono invecchiata insieme alle cianografie dei progetti per la metropolitana. Per me, frequentare dal 2015 la Älvrummet e vedere di volta in volta scomparire un po’ di quel bianco è come un piccolo miracolo, un timelapse che non smette di affascinarmi. Cerco di non pensare al fatto che ogni corona spesa per il miglioramento dell’urbanistica e della mobilità è spesso sottratto alla Sanità Pubblica – che a confronto di quella italiana è un disastro – per godermi il piacere di constatare quanto ogni edificio sia parte di un progetto urbanistico che non nasce da una mera speculazione edilizia o, nel migliore dei casi, dal capriccio di un imprenditore privato che voglia far sfoggio di sé, ma da una pianificazione che, facendo tesoro degli errori del passato, stabilisce per esempio che i palazzi destinati alla proprietà privata siano eretti accanto alle abitazioni destinate agli affitti, anche quelli agevolati o studenteschi, onde evitare di creare aree ricche e aree ghettizzate; e che ogni zona abbia sempre un piano di mobilità pubblica adeguato.
Il modello della città ideale del rinascimento nella sua versione moderna è qui, sotto gli occhi dei cittadini, che in questo raffinato spazio espositivo possono misurare e apprezzare la veridicità delle promesse e il realizzarsi concreto di una visione. Certo, Göteborg è da anni un gigantesco cantiere – e questo richiede una buona dose di pazienza da parte dei suoi abitanti – ma tutto avviene a una tale velocità che pare davvero una città costruita col Lego. Per la mia qualità di vita, è importante poter provare fiducia nella volontà di tutela del bene comune, poter dare per scontato che ci siano ingegneri e architetti che ogni giorno riflettono su come rendere la città più funzionale, pulita, intelligente, bella da vivere e da guardare, e che questo impatti nella mia quotidianità. È così bello che vivo col timore che finisca.
Göteborg ha un’offerta museale ricca e interessante che include molta varietà tematica, non necessariamente collegata all’arte; la lista sarebbe lunga ma mi soffermo solo su un luogo che ha un significato speciale per me, dato che simboleggia quello spirito di rivendicazione popolare che ha reso questa città unica: la Röda Sten Konsthall (Palazzo Espositivo del Masso Rosso). Un enorme dado di cemento tirato da un gigante a un passo dalla riva del fiume Göta, che in quel punto di spalanca in un estuario, e sovrastato dal ponte di Älvsborg a cui accennavo poco fa. Questo cubo costruito nel 1940 era una gigantesca caldaia che riscaldava la vicina – stupenda! – fabbrica di zucchero e di birra, chiusa nel 1957. Persa la sua funzione, il cubo è rimasto lì vuoto e fermo per due decenni ma, a cominciare dagli anni Ottanta, i gossemburghesi hanno iniziato a usarlo come luogo di ritrovo per feste clandestine, rave, performance e esposizioni d’arte spontanea.
“Göteborg è una figlia d’Europa: nasce dallo scontro con due nazioni cugine e dall’incontro con tre nazioni nordeuropee. La sua tradizione cosmopolita non è mai appassita: si trova più o meno al centro di un ideale triangolo tra le tre capitali della Scandinavia: Copenaghen, Oslo e Stoccolma”.
Negli anni Novanta il comune aveva deciso di demolirlo ma grazie a una dirompente protesta popolare, si ottenne di lasciarlo in piedi e trasformarlo dal 1996 in uno spazio per la cultura e le arti. È un luogo magico, bello in quanto brutto, un pezzo di archeologia industriale che conserva ancora tutti gli strati della sua storia, graffiti dell’epoca rave compresi, e che al momento ospita per lo più arte contemporanea concettuale. Arrivarci con i mezzi è un po’ complicato, e in quel punto della città c’è un vento crudele ogni giorno dell’anno. Ma proprio per questo, per la sua posizione aspra e indomita, per la sua resistenza ostinata e la sua storia, amo sedermi al dehors del ristorante a bere qualcosa nelle giornate di sole, abbagliata dai riflessi sull’acqua del fiume Göta che scorre impaziente di tuffarsi finalmente nel mare.
Concludo con un consiglio misterioso, il più secret place dei miei posti delle fragole: quando avrete finito di visitare tutto (comprese le isole e l’enorme orto botanico!) andate al numero 20 della via Köpmansgatan, in pienissimo centro, dove troverete un ufficio comunale. Entrate e voltatevi subito a destra per affacciarvi dalla balaustra sopra il piano sotterraneo: non potrete fare a meno di scendere le scale a passeggiare sopra ogni nuovo ricordo. Potete andare solo se promettete di mantenere poi il segreto.