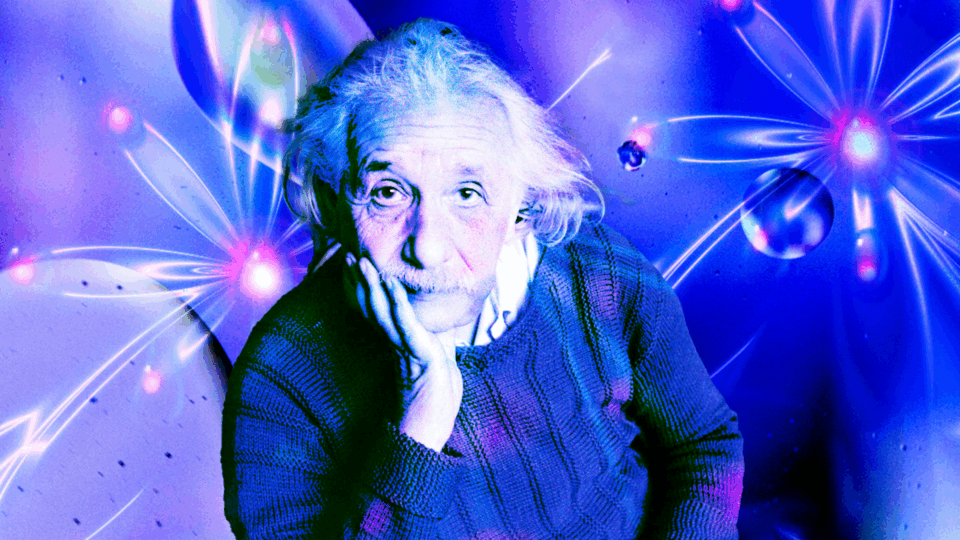Settant'anni fa moriva Albert Einstein, ma le sue idee e la sua disputa intellettuale con Niels Bohr sul determinismo nella meccanica quantistica continuano ancora oggi a plasmare la ricerca scientifica e filosofica.
A settant’anni dalla sua scomparsa, Albert Einstein rimane uno dei pilastri della fisica, paragonabile soltanto ad altri giganti della scienza del livello di Aristotele, Galilei e Newton. Grazie ai suoi contributi alla teoria della relatività e alla fisica quantistica, Einstein ha ridefinito in maniera radicale il nostro modo di concepire lo spazio, il tempo e l’universo.
Il 1905, ricordato come il suo “annus mirabilis”, vide la pubblicazione di almeno tre articoli rivoluzionari: sul cosiddetto effetto fotoelettrico (una delle basi della fisica quantistica, che gli valse il Premio Nobel nel 1921), sulla relatività ristretta e l’elettromagnetismo, e sull’equivalenza tra massa ed energia – con la celebre formula E=mc2. Dieci anni dopo, con la formulazione della relatività generale, Einstein ampliò ulteriormente l’orizzonte scientifico dell’umanità, descrivendo la gravitazione come una curvatura dello spaziotempo. Oltre agli impatti teorici, il suo lavoro influenzò anche l’evoluzione della tecnologia, in particolare nel settore nucleare, e fu sempre accompagnato da un costante impegno civile in favore della pace.
Tuttavia, il suo contributo più complesso, ancora oggi discusso, è forse quello legato all’interpretazione della realtà, soprattutto nell’ambito della fisica quantistica, materia alla quale egli stesso aveva dato un enorme contributo con l’articolo che gli era valso il Nobel. È proprio su questo aspetto che vogliamo concentrare l’attenzione in questo articolo. Tra l’altro proprio quest’anno cade il centenario della formulazione dell’equazione di Schrödinger, che consente di calcolare l’evoluzione di sistemi di particelle in meccanica quantistica, e in considerazione di ciò l’ONU ha designato il 2025 come “International Year of Quantum Science and Technology (IYQ)”. L’IQY è stato inaugurato in una conferenza tenutasi lo scorso febbraio presso la sede dell’UNESCO a Parigi.
“Oltre agli impatti teorici, il suo lavoro influenzò anche l’evoluzione della tecnologia, in particolare nel settore nucleare, e fu sempre accompagnato da un costante impegno civile in favore della pace”
Che cos’hanno da dire i fisici a proposito dell’interpretazione della realtà? La realtà nella fisica classica – precedente alla fisica quantistica – è oggettiva e indipendente dall’osservatore. Le proprietà dei sistemi fisici, ad esempio le posizioni e le velocità dei punti materiali, esistono “in sé”, indipendentemente da noi, e possono essere misurate in modo oggettivo. Questa visione, detta “realismo”, è correlata all’idea che il mondo può essere descritto attraverso leggi matematiche universali. Cioè le variabili fondamentali che descrivono il mondo in mutazione (posizioni e velocità delle singole particelle) sono suscettibili di una definizione oggettiva, e conoscendole a un dato istante di tempo e conoscendo le leggi della fisica permettono di prevedere il futuro. Se ammettiamo l’esistenza di un Dio trascendente, questo Dio potrebbe avere creato l’universo e le leggi della fisica e poi avere smesso di occuparsene: l’universo può andare avanti da solo, con buona pace del ruolo di noi esseri umani e del libero arbitrio.
A differenza della fisica classica, nella meccanica quantistica il ruolo dell’osservatore diventa cruciale. La fisica quantistica non predice con certezza il verificarsi di un dato fenomeno, ma solo la probabilità che esso avvenga. L’atto di misura comporta una scelta casuale fra un insieme di risultati possibili, e di tale scelta casuale l’osservatore è il tramite. Questo pone limiti intrinseci alla conoscenza di variabili osservabili come la posizione e la velocità delle particelle, limiti sanciti dal cosiddetto principio di indeterminazione di Heisenberg. In generale, secondo la visione ortodossa della meccanica quantistica, non è possibile parlare di uno stato fisico definito di un sistema prima di un’osservazione, bensì di una distribuzione di probabilità che si concretizza in un risultato solo al momento della misura. Il risultato finale della misura dipende, oltre che dallo strumento di misura, dal caso, anche se con probabilità ben definite dalle leggi della fisica. Se per i fenomeni macroscopici la probabilità di ottenere il valore misurato è vicina al 100% e quindi non si nota differenza rispetto alla meccanica classica, per i fenomeni su scala microscopica le differenze possono essere rilevanti. L’evoluzione futura del moto di un’automobile è praticamente prevedibile, ma quella del moto di un elettrone di fatto non lo è. E in tutti gli esperimenti effettuati finora la visione quantistica si è dimostrata quella giusta.
Per Einstein, l’idea che la natura fosse governata dalla probabilità appariva insoddisfacente. In una lettera del dicembre 1926 al fisico Max Born (premio Nobel per la fisica nel 1954), affermò che, pur rispettando la meccanica quantistica, sentiva che non potesse essere la teoria definitiva per comprendere l’universo. Il nucleo della sua perplessità era la convinzione che dovesse esistere un livello più profondo di realtà, dotato di leggi deterministiche, attraverso cui diventava possibile prevedere con certezza il comportamento futuro di un sistema di cui si conoscono le condizioni iniziali. A suo avviso, la teoria quantistica poteva essere straordinariamente efficace dal punto di vista fenomenologico e descrittivo, ma restava incompleta: mancava di quelle variabili, forse nascoste, che avrebbero restituito all’universo un carattere di causalità ferrea e intellegibile. In quella lettera a Born, Einstein si espresse con la famosa frase “Dio non gioca a dadi con l’universo”.
“A settant’anni dalla sua scomparsa, Albert Einstein rimane uno dei pilastri della fisica, paragonabile soltanto ad altri giganti della scienza del livello di Aristotele, Galilei e Newton”.
È così che si innescò la rivalità intellettuale con il danese Niels Bohr, premio Nobel per la fisica nel 1922, sul tema del determinismo e dell’indeterminismo in meccanica quantistica. Tale rivalità rappresenta uno dei momenti più alti e avvincenti nella filosofia della natura. Einstein e Bohr divergevano profondamente nell’interpretazione dei risultati forniti dalla nuova teoria quantistica. Einstein, che pure fu tra i fondatori di questa rivoluzione scientifica, manifestò disagio di fronte all’idea che la fisica si ritrovasse intrecciata con il concetto di probabilità, con l’aleatorietà e con la dipendenza da fenomeni non locali. “Subtle is the Lord, but malicious he is not” è un’altra citazione einsteiniana (in originale in tedesco, ma tradotta in inglese da lui stesso; la frase è incisa sulla pietra all’università di Princeton, dove Einstein trascorse i suoi ultimi anni). Bohr, al contrario, era convinto che la meccanica quantistica fosse una teoria corretta e completa, anche se si scontrava con il senso comune e con il desiderio filosofico di un realismo deterministico. Secondo la leggenda, durante il quinto congresso Solvay tenutosi a Bruxelles nel 1927, Bohr pronunciò la frase “Einstein, smettila di dire a Dio cosa deve fare!”
Einstein impiegò molto del suo tempo a cercare di individuare paradossi o esperimenti reali o mentali che potessero mettere in luce i limiti della meccanica quantistica e dimostrare l’esistenza di una forma più profonda di descrizione del mondo, capace di restituire alla realtà fisica un realismo indipendente dall’atto di misurare. Per Einstein la misurazione aveva un ruolo descrittivo, non costitutivo. Nell’interpretazione quantistica di Bohr, invece, il confine tra “osservatore” e “osservato” non esisteva. Secondo Bohr, la meccanica quantistica definiva in modo esauriente i limiti della conoscenza umana a livello microscopico, ridefinendo di fatto il concetto stesso di “realtà fisica”. Per Bohr insomma non aveva senso parlare di proprietà di una particella se non in relazione a un atto di misura ben definito: l’elettrone non “ha” una posizione se non quando l’abbiamo misurata. Non si tratta semplicemente di un limite tecnico, ma di un aspetto ontologico. E soprattutto gli approcci di Einstein e Bohr hanno conseguenze verificabili tramite esperimenti.
Tra gli esperimenti che Einstein propose nel corso degli anni ‘20 e ‘30 del secolo scorso per dimostrare come il formalismo quantistico rischiasse di condurre a conclusioni paradossali o in contraddizione con i principi di realtà locali figura il paradosso EPR (Einstein-Podolsky-Rosen) del 1935. Il paradosso si sostanziava nel fatto che, dato un sistema composto da due particelle in uno stato quantistico legato (o, come si dice in termine tecnico, entangled), la misurazione di una particella sembrava influenzare istantaneamente lo stato dell’altra, a prescindere dalla distanza che le separava. Per Einstein era proprio tale “azione a distanza” a costituire una violazione del cosiddetto principio di località: enti che noi non possiamo osservare possono influenzarci. Questo per Einstein era inaccettabile.
Bohr, nel confutare le argomentazioni di Einstein, insistette sul fatto che il concetto di “realtà fisica” non potesse essere estratto in modo oggettivo senza considerare le modalità con cui le proprietà venivano misurate. Da questa prospettiva, il presunto “effetto istantaneo a distanza” non era una trasmissione di informazione fisica, bensì una modifica della descrizione che abbiamo del sistema alla luce di un nuovo dato di misura. In altre parole, la correlazione quantistica (entanglement) non violava alcuna legge causale, ma mostrava piuttosto che le particelle in stato entangled non potevano essere trattate come entità separate con proprietà definite indipendentemente l’una dall’altra.
“Il confronto tra la visione einsteiniana e l’interpretazione ortodossa dei fenomeni quantistici non ha ancora condotto a un consenso unanime tra gli scienziati, anche se la critica innescata da Einstein ha stimolato un esame approfondito dei fondamenti della fisica, ispirando generazioni di studiosi”.
Negli anni in cui si svolse, il dibattito non ebbe un vincitore. Se dal punto di vista delle previsioni sperimentali la meccanica quantistica si rivelò costantemente in accordo con i risultati di laboratorio, la questione sul significato profondo della teoria rimase aperta. Einstein passò gran parte della sua vita a cercare di “completare” la meccanica quantistica per farla diventare una teoria compatibile con il determinismo classico, ma senza successo. Molto più tardi, a partire dagli anni 1960, il teorema di John Bell e gli esperimenti di Alain Aspect (premio Nobel per la fisica nel 2022) diedero torto ad Einstein, o almeno alla formulazione più semplice del suo pensiero. Ma l’idea di Einstein sopravvive in formulazioni più complesse.
Il confronto tra la visione einsteiniana e l’interpretazione ortodossa dei fenomeni quantistici non ha ancora condotto a un consenso unanime tra gli scienziati, anche se la critica innescata da Einstein ha stimolato un esame approfondito dei fondamenti della fisica, ispirando generazioni di studiosi. La discussione sulle implicazioni filosofiche della teoria quantistica deve molto a questo scontro intellettuale.
La polemica tra Einstein e Bohr sul determinismo e l’indeterminismo in meccanica quantistica occupa un posto d’onore non solo nella storia della fisica, ma anche nella storia del pensiero umano. Se con la sua fiducia in una descrizione oggettiva e causale della realtà Einstein incarnava lo spirito della fisica classica, Bohr rappresentava la nuova visione quantistica, fondata sulla probabilità, sull’incertezza e sul ruolo creativo dell’osservazione, e sull’esistenza del caso. Il lascito di questo confronto è un arricchimento della fisica moderna, che non smette di interrogarsi sulla natura ultima della realtà e sul confine tra ciò che è conoscibile e ciò che sfugge alla nostra comprensione.