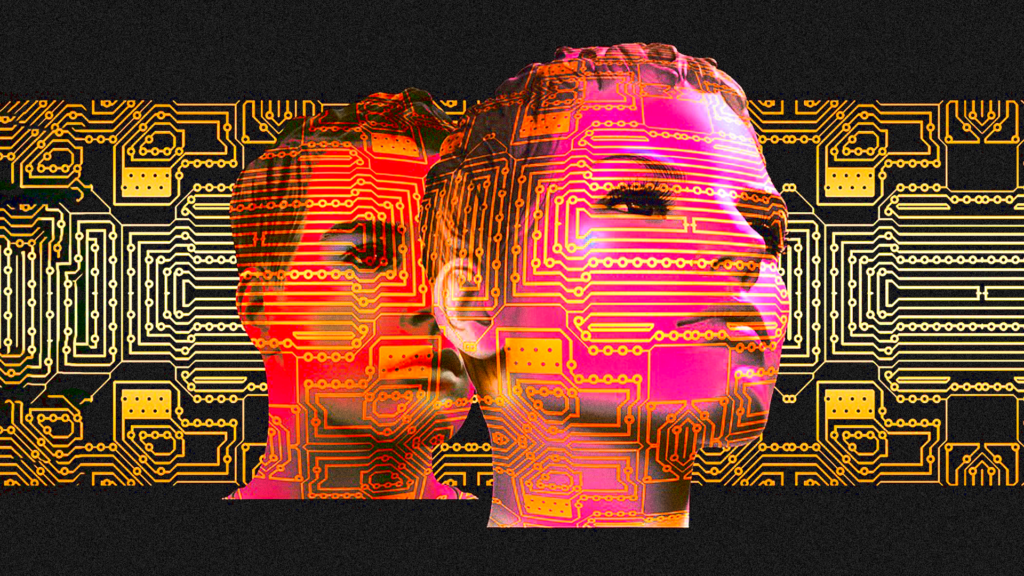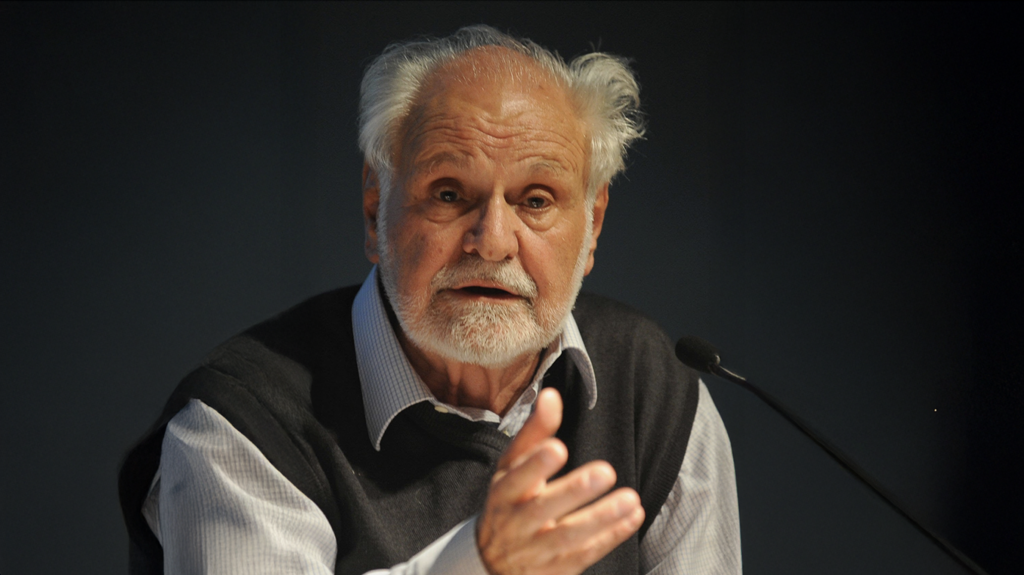Emiliano Ceresi
C’è ancora voglia di Beckett. Intervista a Gabriele Frasca

30 Gennaio 2024
Vincitore del Nobel, fonte di ispirazione per tanti altri autori, Samuel Beckett è stato uno degli scrittori più importanti del Novecento. Eppure, solo oggi si comincia finalmente a dedicargli l’attenzione che merita. Una conversazione – ricca e divagante – con Gabriele Frasca, studioso e curatore del Meridiano dedicato allo scrittore, che arriva alla vigilia dell'uscita del biopic “Prima danza, poi pensa. Alla ricerca di Beckett”.
Mancava al novero dei prestigiosi Meridiani, ed era lacuna di quelle considerevoli, un volume dedicato a Samuel Beckett. Il premio Nobel irlandese è forse stato uno degli scrittori che, avendolo attraversato quasi nella sua interezza, si è più misurato con il Novecento.
Lo ha fatto concependo opere ambiziose perché sperimentali con ogni mezzo, in grado di recepire tutti i dispositivi tecnologici del suo tempo (televisione, radio, teatro, cinema, persino videogiochi) sfruttandoli per congegnare ad arte trappole sempre mutevoli in cui braccare il suo pubblico.
Garbiele Frasca, curatore di questo nuovo Meridiano, studioso, traduttore, poeta, dal suo primo incontro con la pagina di Beckett, non ha mai smesso di cadere nelle trappole tese dall’autore di Murphy. Del resto, il saggio che Frasca gli ha dedicato, Cascando, rende conto con il titolo-gerundivo, di un processo iterativo ancora in corso, un inciampo forse inarrestabile.
Lo raggiungo un pomeriggio via Skype per una conversazione lunga e densa di aneddoti, spesso sorprendenti perché riferiti a un autore enorme con altrettante ombre. La connessione talvolta ha vacillato – a restare fermo c’era però sempre lo sguardo perplesso di Beckett che mi fissava dal ritratto alle spalle di Frasca, sporgendosi da uno scaffale della libreria.
Poche pagine letterarie mi sono parse autenticamente emozionanti come quelle che Alain Badiou dedica al racconto del suo incontro con l’opera di Beckett – quando, scrive, era ancora un “giovane cretino”. Partirei da qui: come è avvenuto il tuo incontro con l’opera di Samuel Beckett?
È stato un libro, e questo ci dà da subito la possibilità di affrontare il rapporto tra Samuel Beckett e l’editoria. Entrai in collisione con Beckett il giorno del mio quindicesimo compleanno quando mi fu regalato un cofanetto di Oscar Mondadori, quindi quei libri che ci possiamo permettere giustamente quando siamo giovani, ideati da Vittorio Sereni, e che per la mia formazione hanno ricoperto una funzione fondamentale.
Il cofanetto era stato pensato per presentare al pubblico italiano le novità che provenivano dal teatro. C’era un volumetto per Ionesco, uno per Beckett e un terzo, non per Pinter come forse era più prevedibile, ma per John Osborne. Io li lessi avidamente tutti, ma a folgorarmi fu Beckett. E infatti la prima cosa che feci fu comprare tutto ciò che di suo trovavo sugli scaffali.
Acquistai subito un altro cofanetto dove c’erano i tre romanzi in francese e poi trovai presto, fortunatamente, il romanzo che segnò il definitivo innamoramento, Watt. A pubblicarlo era stata la SugarCo, meritevole casa editrice milanese che si faceva vanto di proporre Beckett, seppure consapevoli che non sarebbe stato un successo commerciale. Scrivevano in copertina qualcosa come: “Noi sappiamo che non venderà, ma siamo onorati di pubblicare Samuel Beckett”.
Era ben prima che fosse insignito del Nobel. Con grande passione, e soprattutto lungimiranza, le piccole case editrici coglievano quello che si lasciavano sfuggire le grandi. Arriva solo in un secondo momento la grande editrice che sposa Beckett e lo fa un suo autore: Einaudi.
E l’incontro fuori dai libri, invece? C’è una lettera in cui Beckett ti paragona persino a Belacqua, il personaggio del Purgatorio dantesco che ispira la sua visione dello scrittore.
Ho avuto una breve corrispondenza con Beckett, assolutamente casuale. Avvenne in adolescenza quando cominciavo finalmente, come avrebbe detto lo scrittore Antonio Pizzuto, a “toscaneggiare in qualche lingua”, cioè a leggere non soltanto in italiano.
E il mio primo desiderio consisteva nel leggere in inglese Watt – solo che non riuscivo a reperirlo in nessun modo. Non c’erano ancora né Libraccio né Amazon. I libri stranieri o li compravi direttamente sul posto o c’erano delle librerie specializzate in poche città, e con una selezione esigua in lingua originale.
Io poi avevo notizia che Watt non fosse mai più stato ripubblicato da quella prima fatidica uscita per l’Olimpia Press, fra il ʼ54 e ʼ55. Ostinato scrissi all’editore francese di Beckett, Jérôme Lindon, per chiedergli se mi sapeva dare qualche dritta su dove reperirlo. Senonché a rispondermi fu Beckett in persona che mi fece spedire il libro, che aveva ripubblicato da poco per sua volontà.
Questo il mio ricordo di Beckett: quello di una persona di una gentilezza stratosferica. Arriva ‘sto ragazzino, perché tale ero all’epoca, senza arte né parte, che semplicemente scrive dall’Italia perché non trova un libro – e in cambio gli arriva una copia con tanto di cartoncino firmato da Beckett che addirittura lo ringrazia per l’interesse.
Da quel momento inizia un piccolo carteggio tra di noi, ma io ero ben consapevole di quanto fosse impegnato Beckett e, soprattutto, mi premeva molto più che continuasse a scrivere le sue opere più che al mio indirizzo. Si tratta di non più di un paio di lettere all’anno che vertevano perlopiù sul mio lavoro su di lui che nel frattempo cominciava a prendere forma (saggi accademici, soprattutto). Ha fatto persino in tempo a vedere la mia prima monografia a lui dedicata (Cascando, nel lontanissimo ’88).
Ma in quell’occasione non fu lui a rispondermi, ma Lindon che mi scrisse Beckett era molto malato, che si scusava, e che gli aveva chiesto a sua volta (una persona di una cortesia infinita!) di rispondere che era molto contento del lavoro che portavo avanti su di lui.
Conservo il ricordo di una persona di un’enorme generosità, che si è presa anche la briga di leggersi qualcosa di mio – gli mandai anche il mio primo libro di versi – povero disgraziato si dovette subire pure questo! (ride). E mi rispose non per cortesia ma perché l’italiano lo leggeva, anzi, più lo stanavi sull’italiano e più lo rendevi felice. Col francese era gioco fatto. Col tedesco pure.
Ma Beckett avrebbe rivisto pure le traduzioni italiane, se solo Einaudi gliele avesse sottoposte. Einaudi non ebbe questa idea. È un peccato. Le prime traduzioni di Fruttero & Lucentini avrebbero avuto così la sua approvazione – e non sarebbe stato male anche perché lui se ne lamentava un po’. Certo, era ancora un signor nessuno, non era solo colpa di Einaudi. Col Nobel, magari, ci avrebbero rivolto un pensierino.
Da quello che ricordi mi pare che tu abbia conosciuto il Beckett che, come scrive in una sua lettera, decise di aprirsi agli altri dopo la crisi della giovinezza.
Beckett non era un uomo chiuso in sé. Era uno che si sottraeva ai giornalisti, questo sì. Era un uomo molto compagnevole, per usare una delle sue parole. Di lui sua moglie diceva che “generava amici come le cagne generano cuccioli”. Faceva amicizia in continuazione. E li vedeva tutti. Aveva amici americani, tedeschi, francesi, irlandesi. Li incontrava di continuo. Se qualcuno di loro passava a Parigi e gli mandava un bigliettino faceva in modo di incontrarlo, qualsiasi fosse la mole dei suoi impegni.
Mangiava in maniera frugale, abitudine che gli era rimasta dalla guerra, ma gli piaceva parecchio bere. E specie con gli amici irlandesi, che lui adorava, e che mantenevano un tasso alcolemico notevole, McGreevey su tutti.
Ecco, con questi signori andava nelle sue brasserie preferite e tornava a notte fonda. Non dico a quattro zampe come Dylan Thomas, ma quasi…
Compagnevole con gli amici ma anche agguerrito con gli avversari. Di T.S. Eliot in una lettera a McGreevey nota che, letto al contrario, il suo cognome diventa “Toilet”. Bertold Brecht addirittura avrebbe voluto scrivere un anti-Aspettando Godot per sfidarlo…
Compagnevole nel senso che frequentava le persone care e che molte persone gli erano care. I giornalisti li evitava come la peste. Ma per esempio un suo amico, Peter Lennon che era redattore al «Guardian», l’ha frequentato tutta la vita. E solo alla sua morte Lennon ha scritto un libro ricordando gli anni a Parigi, Paris in the Sixties.
Non è che odiasse i giornalisti. Detestava apparire sui giornali, le interviste, le incombenze promozionali. Mentre amava frequentare le persone. Aveva anche presente quali erano i suoi nemici, certo. Eliot gli stava antipatico: lo sentiva troppo professorale. In parte, forse, qualcosa dell’Eliot-chierico sapienziale l’aveva intesa. Altri li amava alla follia. Basti pensare all’amicizia che ha avuto con Harold Pinter, che considerava quasi un figlio.
C’è una bellissima lettera su Salinger…
Lo amava. E aveva simpatia, anche se non esce fuori, per Anthony Burgess. Di queste cose non si si sa molto perché conosciamo pochissimo dell’epistolario con Barbara Bray.
Dal momento che la questione è spinosa per ragioni intime, purtroppo, abbiamo solo poche lettere della loro corrispondenza. E Bray era un’intellettuale che aveva rapporti notevoli, per esempio con Joseph Losey, con cui collaborava. O con i cineasti francesi. C’è un intero emisfero che non conosciamo del mondo-Beckett: siamo lontani dall’aver risolto l’enigma. Sappiamo troppo poco anche dei suoi amici francesi. Possibile che Beckett e Deleuze, che pubblicavano per lo stesso editore non si siano mai incontrati? Con il filosofo che per giunta lo venerava? Eppure, nella biografia di Knowlson, Deleuze non appare.
“Era un uomo molto compagnevole, per usare una delle sue parole. Di lui sua moglie diceva che ‘generava amici come le cagne generano cuccioli’. Faceva amicizia in continuazione”.
Knowlson fa trapelare anche che i rapporti con Adorno non fossero armonici…
Dissento. Erano caldissimi. Basta leggere i diari di Adorno e le lettere che Beckett spediva ai filosofi. E Barbara Bray, interpellata sulla questione, affermava: “leggeva Adorno e lo ammirava”. Restano diversi strati che non conosciamo.
Tra questi, particolarmente caro gli era l’amico-maestro James Joyce, che condiziona il suo esordio. Nell’introduzione al Meridiano scrivi che le prime opere di Beckett addirittura “puzzano di Joyce”. Finisce poi per superarlo, a “rivoltarlo come un guanto”, con la televisione e andando oltre la letteratura. Eppure Joyce torna sul finale, col Finnegans Wake. Non è mai davvero riuscito a liberarsi da quell’influenza?
Io presumo che lui non volesse liberarsene. Voleva distinguersi da Joyce, ma liberarsene no, perché adorava Joyce. Gli voleva bene come autore e ancora di più come uomo. Si scambiavano persino i cappotti.
Quello straziante rappresentazione dell’Ohio Impromptu dove ci sono quei due: uno che legge, l’altro che ascolta.
Ha avuto un’ossessione per una vita per Joyce al punto tale che, se è vera la notizia che ci riporta Jack MacGowran, Beckett è stato tentato di non andare a ritirare il Nobel, nel suo caso non per affatto i motivi politici, come invece Sartre. Per lui era inconcepibile che Joyce non lo avesse vinto. Di sé davvero pensava: “Chi sono io per ritirarlo se Joyce non ne è stato insignito?”
Provava sentimenti enormi per Joyce – fino all’ultimo dei suoi giorni. Quando era in casa di riposo e Knowlson, andava a intervistarlo, continuava a rivedere i suoi capolavori. Beckett doveva tutto a Joyce: se non lo avesse incontrato sarebbe stato un accademico. Grazie a lui capì che se impiegava la stessa capacità che aveva nello studio per scrivere sarebbe potuto diventare invece un autore della sua grandezza.
E d’altronde è Beckett è uno di quegli scrittori che studiano di continuo, si aggiornano, si documentano…
Si è sempre documentato. Non è di quelli che scriveva sorgivo perché ha il romanzetto che gli deve uscire “dal petto,” come recitava un vecchio titolo di un guitto. E tantomeno avvertiva la letteratura come una specie di ispirazione che proviene dall’interno, come fosse una gastrite. Beckett era consapevole che per poter scrivere occorre studiare. E che anzi, fare letteratura è più complesso o richiede più impegno, di un saggio.
E perché, nonostante questo affetto di cui sono persuaso, i due si chiamavano per cognome nelle lettere? Era un gioco ironico? O una reciproca misura di rispetto?
Attenzione, non si sono mai chiamati Mr. Beckett e Mr. Joyce. Si sono chiamati Beckett e Joyce come si chiamavano, all’epoca, i compagni di scuola. Anche a me mi chiamavano Frasca alle elementari: pochi amici arrivavano alla confidenza di un Gabriele (ride). Abbiamo dimenticato questo aspetto delle nostre vite. C’era una differenza d’età che impediva forse di chiamarsi Jim e Sam, ma ci sarebbero arrivati. Joyce non chiamava nessuno per cognome: diceva sempre Mr. o Miss. qualcosa. Nel caso di Beckett lo chiamava Beckett e si faceva dare del Joyce: non è poco.
È vero, la sua non è una scrittura sorgiva, ma c’è un periodo, che in una lettera descrive come di “chiusura nella stanza”, in cui l’opera di Beckett erompe, ti cito, come “una colata” – scrittura e temperatura sono notevolissime, e su più tavoli mediali.
Giusto, ma le due cose a ben vedere non sono in contraddizione. Il lavoro va fatto prima. Da poco sono stati pubblicati gli appunti che Beckett ha preso sulla filosofia soprattutto in gioventù ed è un volume monstre, di pagine e pagine fittissime. Esiste un volume analogo, al momento inedito, sulla psicanalisi. Beckett prendeva appunti febbrili, su tutto. Uno potrebbe dire: e che se ne faceva della filosofia? E della psicanalisi? Apparentemente nulla. Nulla?
I libri escono con furia dalla sua penna uno in fila all’altro, come giustamente ricordi, ma sono intrisi degli umori dei suoi studi. Beckett non ha bisogno di leggere perché lo ha già fatto. E ha continuato, nel corso della sua vita, a leggere tantissimo. Come continuamente compulsava i suoi grandi autori: Dante, Shakespeare, Goethe. Oltre a essere curioso di tutto. Si incuriosì persino della genetica e iniziò una corrispondenza con uno scienziato.
La grandezza di uno scrittore consiste nel non far avvertire tutta questa fatica: non è che quando ti metti all’opera mostri i muscoli. O meglio: lo fai quando sei giovane. Se uno legge Murphy si rende conto che ogni tanto il giovane Beckett, in effetti, lo flette il braccio.
Ma da un certo punto in poi smette. Già Watt, che è il romanzo successivo, ed è l’opera di un positivista logico (ambito su cui Beckett conosceva tutta la sterminata letteratura pubblicata) sembrerebbe un romanzo apparentemente privo di citazioni. Invece ne è pieno.
Adorno, in quel dibattito televisivo su Beckett che hai ripubblicato nel Nulla positivo, afferma che nelle opere d’arte che sono tali c’è una sola interpretazione errata, quella univoca. Se bastasse, come in un gioco indiziario, riconoscerne gli intertesti o tradurne le allegorie, Beckett non sarebbe del resto il grande autore che invece è.
Perché secondo te, come Franz Kafka per certi versi, Beckett è uno scrittore che piace ai filosofi? Adorno, ma anche Deleuze che citavi prima, e che per primo forse coglie il notevole rilievo che spetta alla televisione nell’opera beckettiana. Mi permetto di aggiungere che questo rilievo spicca nel tuo Meridiano.
Tutti i filosofi che citi sono, tra l’altro, decisamente particolari, pensatori obliqui. Adorno si sporca con la sociologia ed è vicino alle interpretazioni mediologiche; la stessa cosa fa Deleuze, che era appena reduce da quei due straordinari volumi sul cinema dove Beckett, non a caso, è continuamente evocato. Deleuze introduce poi una raccolta di opere televisive che gli offre la scorta per scrivere uno straordinario saggio beckettiano, L’épuisé.
Poi tu hai iniziato citando Badiou – ed è un altro pensatore molto interessante, insomma.
Si capisce, Beckett riesce a toccare la fantasia di chi è incline alla speculazione. Detto questo, può essere apprezzato da qualsiasi lettore. Se il lettore comprende che da Beckett gli viene chiesto di interpretare quell’opera: di vestirne i panni, di interagire: gode con lui molto più che con qualsiasi altro scrittore. Deve accorgersi però che il personaggio nasce a metà dall’autore ma, per l’altra parte, serve il suo apporto.
“Provava sentimenti enormi per Joyce – fino all’ultimo dei suoi giorni. Quando era in casa di riposo e Knowlson, andava a intervistarlo, continuava a rivedere i suoi capolavori”.
Intorno all’idea di tirare il pubblico all’interno, nell’introduzione osservi che per Beckett la televisione è come Videodrome di Cronemberg, un mezzo insieme elettrico e organico da cui lo spettatore rischia di essere risucchiato. Pochi giorni fa, Andrea Cortellessa ipotizzava come Beckett potesse aver influenzato certa imagery cronemberghiana: siamo davvero alla letteratura del “reticolo mediale”, per citarti…
Gli spettatori e i lettori di Beckett non hanno angolo di immunità. Quello stesso angolo di immunità cui anela Buster Keaton inseguito dalla telecamera, che altro non è che l’occhio persecutorio di Beckett.
Telecamera che è lo sguardo dello spettatore: siamo noi a inseguirlo.
Giusto. Non c’è scampo e quindi meglio finirci dentro: almeno sei consapevole che devi essere tu a interpretare, o magari a inseguire. Anche da spettatori si è in scena. E come gli attori di Beckett sanno, una volta che hai addosso il personaggio di Beckett, è come se ti si incistasse nella pelle. Lo hanno ammesso tutti i suoi attori: da Bille Whitelaw a Jack McGowan. Ogni attore beckettiano sa che non puoi interpretare una sua opera senza restarne infettato. Lo stesso vale per lo spettatore e per il lettore. Lo spettatore crede di essere al sicuro sulla poltrona. Non lo è per niente.
Pensiamo al Trio degli spiriti (Ghost trio). Si comincia con una voce-off, acusmatica, che bisbiglia dallo schermo “questa è una voce bassa” – in un’epoca in cui non esisteva il telecomando. Lo spettatore faceva per alzarsi, verso la manopola del televisore, e si sentiva intimare di là dallo schermo: “Ma non alzare il volume!”. È stanare lo spettatore televisivo, questo. A me pare incredibile. Non conosco altri che sono stati in grado di fare operazioni simili.

Giorgio Manganelli, che è stato molto influenzato dall’opera di Beckett, scriveva, recensendone le poesie che “Beckett ha qualcosa da dire: inizio rovinoso per uno scrittore”. È però arduo comprendere “cosa abbia da dire Beckett” visto che, giustamente, ha rifuggito qualsiasi interpretazione che di lui veniva avanzata…
Ritengo che Manganelli, paradossalmente, avesse ragione. Manganelli, che aveva molte meno cose da dire di Beckett, ha riconosciuto in Beckett un’urgenza. E del resto per me Beckett è il contrario del gioco. Perec è agli antipodi. L’OuLiPo? È il nemico.
Dunque anche la combinatoria manganelliana e i racconti potenziali di Centuria non le avrebbe gradite…
Ogni gioco formalista. Beckett è contenuto puro. Anche se da regista consumato sa benissimo che il romanzo si veicola con la forma. Pensiamo al lavoro che fa per Com’è. La prima cosa che si chiede è: “Come lo metto in forma?” Aveva iniziato a scriverlo in maniera tradizionale poi ha iniziato a spezzettarlo, ricomporlo, ricongegnarlo: a mettere a punto, cioè, una macchina che potesse intrappolare il suo bravo lettore.
Ma Beckett vuole acchiapparlo perché ha qualcosa da dirgli. Altrimenti, Aspettando Godot non avrebbe avuto quella fortuna che così tanto gli ha arriso. La fortuna è che quell’opera parla a tutti. E infatti tutti ci hanno visto un motivo dell’attesa. La comprensione, del dettato beckettiano, in fondo, è immediata, semplice. I suoi contenuti arrivano per questo. Sul livello dell’interpretazione possiamo restare in bilico – e per questo legittimamente affermava di non volere interpretazioni. Per lui contava il significato letterale. Consapevole che poi il significato letterale, almeno apparentemente, è univoco.
Nel ritratto, incastonato in Ritratti e immagini, che di lui fa Alberto Arbasino, Beckett è un autore completamente concentrato sul lavoro con gli attori, sui sospiri, i movimenti, al punto da non curarsi dello scrittore che gli siede accanto.
Nell’introduzione riporti un episodio quasi kubrickiano in cui Beckett costringe la sua troupe a una performance oltremodo dolorosa…
Quel ritratto risponde perfettamente al suo livello di immersione nel lavoro. In Eh Joe, il primo dei suoi videodrammi, per venticinque minuti di performance Beckett li costringeva a battere le ciglia il minor numero di volte possibile. Impossibile che il pensiero non corra ad Arancia Meccanica e alla “cura Ludovico”.
In un’altra occasione Billie Whitelaw, siccome Beckett gli chiese una prestazione analoga, per quanto fosse piccola gli chiese sarcastica: “Sam, ma hai scritto qualcosa per gli attori che non li facesse soffrire?” Naturalmente Beckett chiedeva l’impossibile.
Immagina cosa doveva essere recitare per un’intera pièce seppelliti sotto una montagnola. Uno potrebbe dar di matto per molto meno. Solo questo sforzo è già terribile. Tra l’altro la stessa pièce prevede che la luce sia a giorno – e dunque tutti i riflettori sono orientati sulla povera attrice che, intanto, si scioglie. È chiaro che per ottenere un tale impatto sugli spettatori erano necessari anche questo genere di pensate. Lo spettatore che è andato a vedere Giorni Felici, immaginando di vedere una commedia borghese, torna a casa con gli occhi sgranati. Ha visto un’opera di luce stordente puntata su una povera crista (quasi) seppellita viva.
Questo è il suo versante avanguardista, sembra quasi teatro della crudeltà à la Artaud…
Il palcoscenico nelle opere beckettiane ha la sensibilità di una pianta carnivora. Ti ingloba. Quella sofferenza imposta all’attore è il modo di far uscire il personaggio – ecco perché i suoi personaggi sono così vividi. L’attore, tormentato e torturato, si incarna nel personaggio.
Beckett in effetti ha fatto in tempo a incontrare Artaud e a sapere cos’era davvero il teatro dell’epoca. Il primo regista che ha lavorato con Beckett, ovvero Roger Blain, era anche grande amico di Artaud: lo ha frequentato fino agli ultimi giorni di vita, in manicomio. Qualcosa di quel teatro estremo che pretendeva tanto, troppo, persino la vita stessa dagli attori, era finito anche in Beckett.
“Immagina cosa doveva essere recitare per un’intera pièce seppelliti sotto una montagnola. Uno potrebbe dar di matto per molto meno”.
Accanto a questo, l’attore per Beckett era anche Buster Keaton un mimo, una performer da gag – una presenza forse più dinamica di quanto si è soliti pensare. Gianni Celati, in Finzioni occidentali coglieva proprio questo del comico di Beckett – e la prima produzione di Celati, di fatto, si muove attorno a questo tipo di figure espulse che vagano solitarie per la città. Non solo attese immobili e purgatoriali, insomma.
Sono completamente d’accordo sul dinamismo, davvero decisivo per Beckett. Nel 1936 quando tutti gli editori gli rifiutavano Murphy, Beckett vagheggia di fuggirsene a Mosca per diventare assistente alla regia di Eisenstein.
Nel frattempo, non ha fatto altro che leggere i saggi di Eisenstein e studiare le avanguardie, libri sul cinema sovietico.
Anche nel corso degli anni, non ha mai smesso di andare al cinema, una passione totale per la slapstick-comedy, Chaplin, Keaton, I Fratelli Marx. Stanlio e Ollio è una pseudo-coppia archetipica a cui guardava spesso per i suoi personaggi.
Ma oltre a questo cinema americano comico, lui amava moltissimo il cinema d’autore. In prima fila i sovietici che hanno girato forse negli anni Trenta il cinema più interessante, come pure si è nutrito dell’espressionismo tedesco, dello sperimentalismo francese.
Quando vola a New York per aiutare Schneider a dirigere Film e scopre che il fotografo di scena è nientemeno che Boris Kaufman, che era stato da poco insignito dell’Oscar per Fronte del porto, scrive immediatamente a Barbara Bray con tono incredulo: “Non hai idea chi abbiamo con noi!”. Le ricorda che era stato il direttore della fotografia di Jean Vigo (L’Atalante; Zero in condotta). Poi Kaufman l’Oscar l’ha vinto per Fronte del porto, ma Beckett impazziva per l’esordio di Sidney Lumet, La parola ai giurati: un bianco e nero spettacolare. Senza contare il fatto che Kaufman era il fratello di Mikhail Kaufman, che Bray conosceva.
Beckett aveva una conoscenza di prima mano di queste cose. Per me è impossibile pensare che non abbia intercettato i maggiori registi di stanza in Inghilterra. È per questo che mi continuo a dannare della poca conoscenza che abbiamo delle lettere con Barbara Bray.
Bray, che collaborava con Losey, grande regista americano che era finito in Inghilterra a causa della caccia alle streghe; Losey che faceva cose con Pinter, con cui Beckett aveva un intenso rapporto.
Bray va verso Losey; Pinter va verso Losey – possibile che Beckett non lo conoscesse?
Patrick Magee, grande attore irlandese amato da Beckett è quello che in Arancia meccanica interpreta lo scrittore sulla sedia a rotelle. È sempre lui che in Barry Lindon veste i panni di Chevalier de Balibari: possibile che quando andava a Londra Beckett non abbia mai incontrato Kubrick? Non credo.
La passione per il cinema e le trame relazionali ci danno la possibilità di ipotizzare incontri straordinari. Se verrà finalmente pubblicato il carteggio con Bray, forse troppo pruriginoso, ne vedremo di belle.
La tua introduzione si apre con un’interpretazione che mi ha toccato e che non ho visto altrove, ovvero l’idea che già nel ’35 Beckett avesse in qualche modo profetizzato il suo futuro attraverso un personaggio minore che appare in Murphy e sembra somigliargli molto. I grandi scrittori sono anche profetici?
Nel Meridiano ho dovuto operare una dolorosa selezione perché mi è stata negata la possibilità di curare l’opera omnia in due volumi.
Il 1936 e il 1989 sono gli anni d’oro di questo ciarlatano che scrive l’oroscopo per Murphy e il personaggio vaticina cose che suonano incredibilmente beckettiane: l’evitare l’esaurimento da troppo parole (Beckett è sempre stato uno di poche parole); il nativo potrebbe soffrire particolarmente la fama – e anche qui c’è tutto il rifiuto Beckett.
Ma poi questo fatto che gli anni a lui favorevoli erano tra il ʼ36 e lʼ89, cioè gli anni di apertura e chiusura del mio Meridiano – da lì mi è venuta l’idea di aprire con la sua descrizione.
Può succedere che un autore possa risultare profetico? forse è facile. Beckett non fa altro che prestare a Murphy alcuni aspetti della sua personalità. Quando scrive che il nativo potrebbe soffrire il successo ci si ricorda il famoso quelle catastrophe con cui fu accolta la notizia del Nobel: è chiaro il cortocircuito. Ma è una facile profezia perché Beckett non fa altro che mettere in risalto le caratteristiche di un personaggio che non è altri che sé stesso…
Va detto però che ci sono stati anche molti sospetti verso la ritrosia di Beckett. Aldo Busi, tra i tanti, sosteneva che questo isolamento non era poi così diverso, in termini strategici, da chi come lui si esponeva magari in televisione, anzi, lo trovava solo più ipocrita.
Eppure Beckett fa delle scelte indiscutibilmente contro il mercato: penso alla stessa opzione per il francese quando l’inglese gli avrebbe garantito, senza dubbio, una più ampia diffusione.
Certo, perché sono due tipologie di scrittori-personaggi completamente diversi. Beckett lo dobbiamo paragonare agli altri grandi ritrosi che conosciamo. E avvertiamo che è diverso persino da loro.
Da Salinger, che a un certo punto si è ritirato completamente e si è rintanato in un mondo in cui però ha continuato a scrivere. Mi pare abbia messo 50 anni di tempo tra la sua morte e la pubblicazione delle opere successive. Io purtroppo non le vedrò, ma ti auguro di leggerle.
Pynchon ha semplicemente evitato che la sua immagine apparisse. Eppure Pynchon lo ripete continuamente: “Ragazzi, io non faccio una vita ritirata. Quando ero giovane andavo a prendere mio figlio a scuola”. Pynchon si è nascosto in quel pagliaio che è l’America: vallo a trovare a New York un uomo di cui non hai nemmeno una fotografia recente. E se hai l’accortezza di sposare la tua agente, come ha fatto lui, te la cavi anche se vai doppiare te stesso nei Simpson.
C’è chi sostiene si sia nascosto nel penultimo film di Paul Thomas Anderson…
Io ci credo. Beckett non è che si sottraeva. Beckett non reggeva da un punto di vista emotivo. Non ce la faceva nemmeno a presenziare alle prime: era troppo teso. Costringe la moglie, Suzanne Dechevaux, ad andare al posto suo. Beckett, anche quando non dirigeva lui, stava sempre con la compagnia, seguiva il regista ovunque. Li abbandonava soltanto al momento della prima. Scompariva.
Ma ripeto: Non era timido con gli amici, tutt’altro. Sappiamo anche quanto fosse generoso: ha prestato e donato un sacco di soldi ai suoi amici. La moglie si lamentava del fatto che erano troppi, d’altronde.
La biografia di Knowlson presenta episodi divertenti in proposito…
Il mio preferito è quello dell’incontro con gli operai irlandesi in gita che gli chiedono un’informazione. Lui subito ne riconosce l’accento e li accompagna per due giorni in giro per Parigi.
Loro nemmeno sapevano chi era la loro guida. Giravano con “Sam”. Solo anni dopo hanno scoperto che si trattava di Beckett.
Non è che si sottraeva alle persone, ma a quei lati del successo che ad alcuni piacciono. Ci sono autori che amano comparire in televisione, rilasciare interviste. E altri che non ci riescono. Ma questo non vuol dire che siano contrari. Non amano quel mezzo, o meglio, preferiscono farlo piuttosto che subirlo.
A proposito di mezzi che vengono straniati, tu ipotizzi che tra le influenze di Beckett potrebbero esserci i primi videogiochi.
Ne sono convinto. La prima volta che vidi Watt con quella strana danza accelerata pensai subito a Pac-Man. Immediatamente. Lo stesso colore e gli stessi suoni del videogioco. E Beckett non aveva mai fatto muovere i personaggi in sincro con dei suoni nelle opere precedenti. In questa, ogni ballerino aveva invece la propria percussione. Come, d’altra parte, ogni fantasmino di Pac-Man ha le sue sonorità. Del resto, cos’è quell’inseguirsi senza raggiungersi mai? Cosa vuole rappresentare? Una videobolgia, forse. Tu come lo immagini l’inferno?
Forse un combinato di tutti gli autori che ci hanno scritto di catabasi?
Io, sulla scorta di Beckett, me lo figuro come uno spot della Mulino Bianco ripetuto per l’eternità. Immagina di essere dentro a questo spot e di dover mettere in bocca il biscottino con espressione ebete in un loop senza fine.

Adorno non dice una cosa poi così diversa quando sostiene che la distopia di Beckett consiste nell’avere personaggi che non riescono a morire, o a interrompere lo spot, potremmo aggiungere noi.
Proprio perché tutti siamo destinati a morire i personaggi di Beckett invece non muoiono. Sono immortali in quanto riproducibili tecnicamente. Neppure chi si fa i selfie muore. E anche se morirà avrà lasciato una tale quantità di autoritratti nel mondo che la sua morte non sarà mai del tutto certa. L’idea geniale di Beckett consiste nel fatto che, è vero, c’è l’eterno ritorno ad assicurare la pena, ma a questo si somma sempre l’entropia. Si torna ciclicamente e va sempre un po’ peggio di prima. Tra l’altro, è anche un paradosso fisico: la teoria dei molti mondi.
Harold Bloom mette Beckett a chiusura del suo libro sul Canone occidentale, nel capitolo che si apre con Freud. Beckett è l’ultimo rappresentante di un certo tipo di letteratura?
Io penso sia il primo. Il trasbordo intermediale, il suo passare da un mezzo all’altro, fa di Beckett un autore unico. Persino rispetto ai modernisti, come Proust, che lui amava, e da cui trae linfa in giovinezza.
Eppure, anche rispetto a questi scrittori modernisti che già erano molto interessati alle tecniche, ed erano incredibilmente oltranzisti nel superare i margini della pagina scritta, Beckett si è spinto oltre.
“Oltre la letteratura”, come scriveva Maurice Blanchot.
Per davvero. Io non amo il termine letteratura: è una parola che nasce nel ʼ700 in Inghilterra. Non lo si dovrebbe estendere a fasi che non pertengono il XVIII secolo inglese. A mio parere già Joyce non fa letteratura.
Come si fa a dire che è letteratura? Il fatto stesso che i nostri romanzieri borghesi citino Joyce, ma si guardano bene dal seguirlo, mi pare istruttivo. Lo considerano in realtà, un nemico – sono consapevoli che è ben al di là del loro orizzonte ristretto.
In effetti esiste la letteratura: è quella che oggi affolla le librerie con le copertine cangianti e la data di scadenza visto che, dopo poche settimane, vanno nel pattume.
Ma, per fortuna, Joyce è uscito dalla letteratura. E Beckett si è trovato a operare già all’esterno di quelle maglie. Si è fatto guidare oltre dal maestro, che però ha rivoltato come un guanto.
Beckett potremmo definirlo più che un letterato un maestro nell‘arte del discorso che è l’unica definizione che adopero per raccogliere gli altri a lui affini: Dante, Flaubert, Sterne, Stendhal.
Ultimamente mi sto occupando di Dylan Thomas, che in questo è identico a Beckett. L’ultima opera di Thomas, la più bella e importante, che è un meraviglioso radiodramma, e che sto ora ritraducendo col titolo di Sotto la selva lattea, è un’opera per la radio che Thomas ha messo in scena con degli attori e poi voleva farne un libro, un film, chissà cos’altro.
Sono opere immense e ibride: perché non nascono necessariamente tra le strettoie di un unico medium.
“La prima volta che vidi Watt con quella strana danza accelerata pensai subito a Pac-Man. Immediatamente. Lo stesso colore e gli stessi suoni del videogioco”.
Visto che hai toccato i radiodrammi non posso non chiederti se, per via del volume unico, non hai sofferto a dover escludere parecchi testi per la radio di Beckett.
Molto. Ma ho in mente di farli. Già le poesie che ho tradotto riappariranno molto probabilmente presto – e così sarà per i testi per la radio. Mi è dispiaciuto ma sono consapevole che se il Meridiano avesse riscontrato ampia risonanza, e la sta avendo fortunatamente, avrei potuto riproporli. Lo dicevo a Mondadori: “Guardate che c’è interesse per Beckett: il problema è che non si trova”. Mi hanno sempre risposto: “non vende, non vende” – invece sta andando bene.
La cosa che mi sta a cuore non è poi il Meridiano in sé, che certo è una cosa bellissima, prestigiosa. Ma di più il fatto che la Mondadori continua ad avere una grande politica del libro economico e, di norma, quando esce un Meridiano poi seguono gli Oscar. Il che vuol dire che i ragazzi, che hanno pochi soldi in tasca e vogliono leggerselo, presto potranno farlo.
Potrebbe aiutare anche il fatto che Beckett è intriso di letteratura italiana. Nell’introduzione scrivi che “come nessuno ha metabolizzato Dante”– e c’è anche un tuo saggio importante a riguardo. Gli ultimi drammi hanno fondali trapuntati di elementi caravaggeschi: c’è tutto un immaginario che lo spettatore nostrano, anche per via osmotica, già conosce. Tra l’altro avrebbe potuto insegnare proprio questa letteratura italiana all’Università…
Sì, perché il docente che insegnava al Trinity College lo faceva per spirito di servizio, ma non era un italianista – per niente. Dal momento che Beckett si era molto appassionato a questa lingua e sembrava essere molto più versato di quanto non lo fosse il suo docente, gli era stata proposta la cattedra.
Dante attraversa l’intera l’opera di Beckett sin dalla prima riga. Persino l’ultima opera, What is the Word, c’è quello strano avverbio che conia Beckett a un certo punto, afaint – ed è precipuamente l’aggettivo con cui riteneva che si potesse tradurre il “fioco” del I canto della Commedia (“chi per lungo silenzio parea fioco”).
E quel di quel fioco, nello stesso quaderno su cui stava componendo Whats is the Word, c’è un appunto in cui c’è scritto il verso dantesco con vicino “afaint?”: aveva trovato come tradurlo!
L’immaginario di Beckett è totalmente dantesco. Pensiamo a un’opera come Lo spopolatore o a Com’è, vere e proprie descrizioni di bolge. Per non dire dei testi teatrali, poi. Come definire Play con i tre personaggi incapsulati nell’urna che sono costretti da un proiettore a raccontare per l’eternità la loro storia? È Dante. Tutti si sono accorti che Dante è l’autore di Beckett – e un lettore italiano lo coglie subito.
E Caravaggio, o meglio, i caravaggeschi?
Lui amava moltissimo la pittura contemporanea, come sappiamo. Per non dire dell’astrattismo. Andando indietro nei secoli adorava i tedeschi e fiamminghi quelli che, Roberto Longhi lo sapeva bene, devono tutto Caravaggio.
E infatti Caravaggio lo adorava come si vede in Not I, che ha la Decollazione di San Giovanni Battista come ipotesto. È intriso di cultura italiana. Ruby Cohn, una delle sue prime critiche, grande studiosa americana, che era andata a trovare Beckett che dirigeva Aspettando Godot a Berlino, racconta che mentre stavano passeggiando qualcuno gli aveva rivolto una domanda e Beckett aveva risposto in fluente tedesco. Ruby Cohen si complimentò: “Cavolo, che tedesco!”. E Beckett, che non era solito vantarsi, voltandosi verso di lei “e non hai sentito il mio italiano”.
Come ci ricorda Knowlson, fra i pochissimi libri che si era portato in casa di riposo, oltre ad alcuni libri di Kafka e la biografia di Nora Joyce, c’era l’edizione della Commedia su cui aveva letto per la prima volta Dante in italiano. Sulla sua vecchia edizione Salani con all’interno, per segnalibro, la cartolina che gli aveva scritto la sua insegnante di italiano Bianca Esposito, in italiano, augurandogli una pronta guarigione visto che stava studiando la letteratura italiana, aveva vent’anni – e si era preso una brutta influenza.
Alfano ha scritto un saggio su parola “disfazione”, parola che non sono sicuro rientri tra le competenze di tutti gli italiani. Un termine che, tra l’altro appare citato in italiano nella monografia che Beckett dedica a Proust. Lo stesso saggio in cui Beckett riporta, e in italiano, il Leopardi di A sé stesso.
“Come definire Play con i tre personaggi incapsulati nell’urna che sono costretti da un proiettore a raccontare per l’eternità la loro storia? È Dante. Tutti si sono accorti che Dante è l’autore di Beckett – e un lettore italiano lo coglie subito”.
Giancarlo Alfano ha tra l’altro curato, insieme con Andrea Cortellessa, un volume che si interroga sul lascito della funzione-Beckett nella letteratura italiana. A dare conto di un’opera sterminata ci sono spinte centrifughe ed esiti diversissimi: autori come Malerba, o poeti come Giuliano Mesa.
Ha influenzato davvero molti scrittori, spesso sideralmente lontani tra loro. Mi viene in mente l’ultimo Italo Calvino che, poverino, fa la corsa dietro a Beckett – e arranca un po’. Calvino, certamente, non ha il respiro dell’irlandese, ma gli deve molto. Mi rendo conto che sto toccando il totem nazionale ma prima o poi dovremmo riportare Calvino a una dimensione più realistica.
Un altro che è stato fortemente toccato da Beckett, anche se ha sempre negato e lo ha ammesso solo alla fine, è Edoardo Sanguineti col suo teatro.
La ricaduta fu immediata: non sono pochi quelli colpiti. Persino l’ultimo Landolfi deve qualcosa a Beckett, a mio parere.
Beckett arrivava sempre di più in Italia, e contagiava sempre più la fantasia dei lettori. Einaudi, prima che fosse sussunta da Mondadori e smettesse di essere indipendente, non c’era testo beckettiano che non traducesse. Lasciamo stare il fatto che non ripubblicava più, classici a parte. Einaudi non si è fatta sfuggire nessuna opera di Beckett.

Nell’introduzione adoperi il termine “equilinguismo” per descrivere il trapasso dall’inglese al francese che Beckett opera nelle sue traduzioni. Lo scrittore provava però spesso una tensione molto forte verso la sua lingua: la definisce “orribile”.
Beckett non rinuncia all’inglese per scrivere senza stile, come lui stesso ha dichiarato più volte. Come è stato notato da chi invece si è sporcato le mani col francese, occorre ammettere una triste verità: Beckett è finito impropriamente in mano agli anglisti.
Eppure si racconta un aneddoto su di lui parecchio significativo circa la sua appartenenza a questa lingua. Pare che una volta, a Parigi, sentendolo parlare, lui che aveva un marcatissimo accento irlandese, una signora gli chiese se per caso non fosse inglese e lui sibilino “au contraire!”, che è a mio avviso una meravigliosa autodefinizione.
Il contrario dell’inglese. Ogni irlandese muove da questa condizione. Beckett che era poi addirittura irlandese di origini ugonotte, dunque protestante, non poteva avvertire neppure il gaelico come la propria lingua.
In realtà, Beckett è un po’ come se una lingua non l’abbia mai avuta. Come tutti gli scrittori irlandesi ha un conto aperto con l’inglese.
L’inglese che voleva cancellare è quello ufficiale, pulito, terso, formale. Tanto è vero che quando scrive in inglese aggredisce, come gli insegna Joyce. Maltratta quella lingua fino a trasformarla in qualcos’altro.
Questo era diventato per lui gesto automatico: non riusciva più a scrivere una storia perché appena si metteva alla macchina la parola inglese subito si trasformava in un gioco linguistico particolare, un rimando, una forzatura. Beckett non ha voluto scrivere “senza stile,” bensì in una lingua che conosceva meno.
Il francese parlato a Parigi aveva per lui un ritmo oraleggiante, formulaico. Col francese Beckett sfrutta nessi che periodicamente tornano, come in una melodia. Ecco perché L’innominabile è un romanzo che può essere seguito meglio all’ascolto.
Se uno legge ad alta voce L’innominabile non solo si diverte come un pazzo, perché c’è da divertirsi, ma lo comprende meglio. Lo stesso con quell’altro romanzo pazzesco che è Com’è, che se uno lo legge dentro di sé, come ci hanno abituati, non ne capisce una parola. Com’è è un romanzo che ha attraversato il teatro: non lo si comprende se non si parte da questa presa di coscienza.
Il problema della comprensione si pone sempre con Beckett – lo stesso Adorno scrive, con titolo modesto, il suo “tentativo” di comprendere Finale di partita.
La lettura ad alta voce facilita. Non solo perché fa ridere da pazzi, ma perché sono scritti come spartiti.
“Beckett non è che si sottraeva. Beckett non reggeva da un punto di vista emotivo. Non ce la faceva nemmeno a presenziare alle prime: era troppo teso. Costringe la moglie, Suzanne Dechevaux, ad andare al posto suo”.
C’è poi il continuo ricorso al basso corporale, la deiezione, la coprolalia, anche nelle lettere…
Tipico dell’umorismo irlandese. Mi sono proprio divertito a fare il Meridiano – e per una ragione anche di vera utilità del lavoro. Gli inglesi se devono citare En attendant Godot lo citano in inglese. Ma è una traduzione. E lo stesso errore fanno i francesi, con le opere in inglese. Fortunatamente uno che non è né inglese né francese è più lucido dei francesisti e degli anglisti che si contendono le spoglie.
Stai dicendo che siamo noi italiani il vero pubblico di Beckett?
Sono convinto che i lettori della terza lingua siano i suoi reali destinatari. Dal momento che lui traducendo innova, chi legge Beckett in francese si perde tutte le innovazioni. Chi legge in italiano, grazie al fatto che ho messo un sacco di note di servizio, sa benissimo che cosa combina Beckett nelle varie stesure. E così, consultando gli apparati, il lettore italiano si trova nella condizione di studiare Beckett meglio del lettore inglese e del francese.
Oltre, lo speriamo, al carteggio con Bray cosa c’è nel futuro di Beckett?
Purtroppo quello temo non uscirà mai. So che Barbara Bray aveva tentato anche di pubblicare le sue memorie – peccato perché ha una penna felicissima. Ha tradotto Marguerite Duras, che in Inghilterra ha la sua voce, La vita di Jacques Lacan, eppure non ci è riuscita. Forse in futuro trascriveranno anche il faldone di appunti sulla psicanalisi. A breve pubblicheranno i famosi diari tedeschi, quelli del periodo berlinese: sono stati annunciati da un bel po’, e ci diranno finalmente qualcosa su quei soggiorni.
Woody Allen in Io e Annie dice di Beckett: “Io ne ammiro la tecnica ma non mi colpisce mai a livello viscerale”. È questa la ragione dell’uscita tardiva del Meridiano?
Sin da quando ero ragazzo ho invece pensato che Beckett fosse viscerale, anche solo per la coprolalia di cui dicevamo (ride). Mi commuovo con Beckett: ci sono cose che rileggo senza riescire a trattenere le lacrime. Dettagli che apparentemente non dovrebbero emozionare e che per me diventano trascinanti. Mi dispiace perché sia Woody Allen che il suo doppiatore avevano una rapidità di lettura perfetta per l’Innominabile: ci avrebbero fatto sghignazzare.
Questo contenuto è stato realizzato in collaborazione con BiM Distribuzione, che distribuisce in Italia Prima danza, poi pensa. Alla ricerca di Beckett, di James Marsh, al cinema dal 1° febbraio.
newsletter
Le vite degli altri
Le vite degli altri è una newsletter che racconta di vite che non sono la nostra: vite straordinarie, bizzarre o comunque interessanti.
La scriviamo noi della redazione di Lucy e arriva nella tua mail la domenica, prima di pranzo o dopo il secondo caffè – dipende dalle tue abitudini.
Contenuti correlati