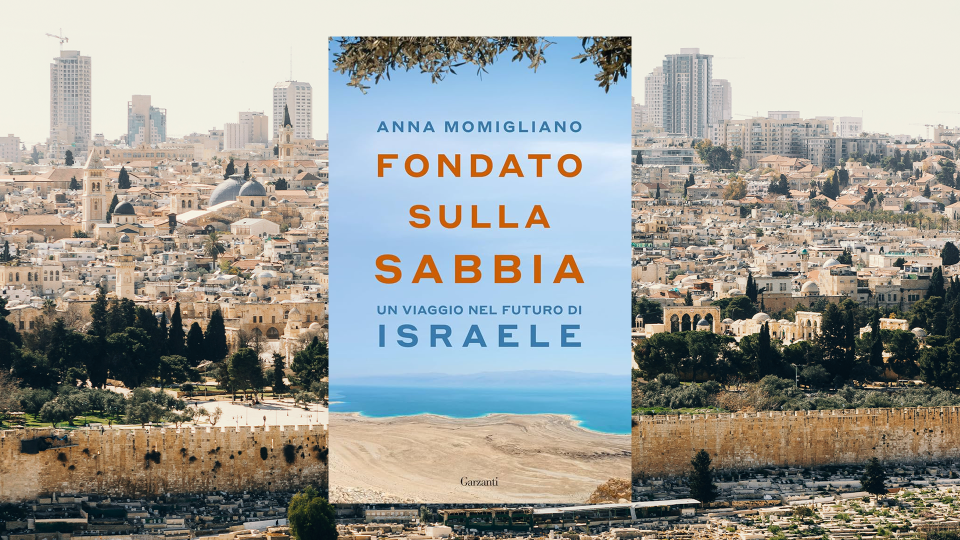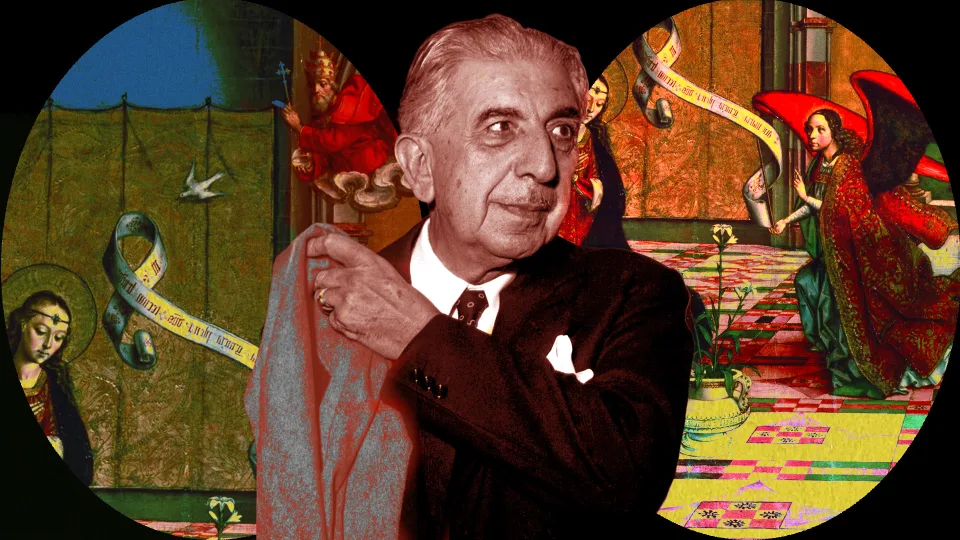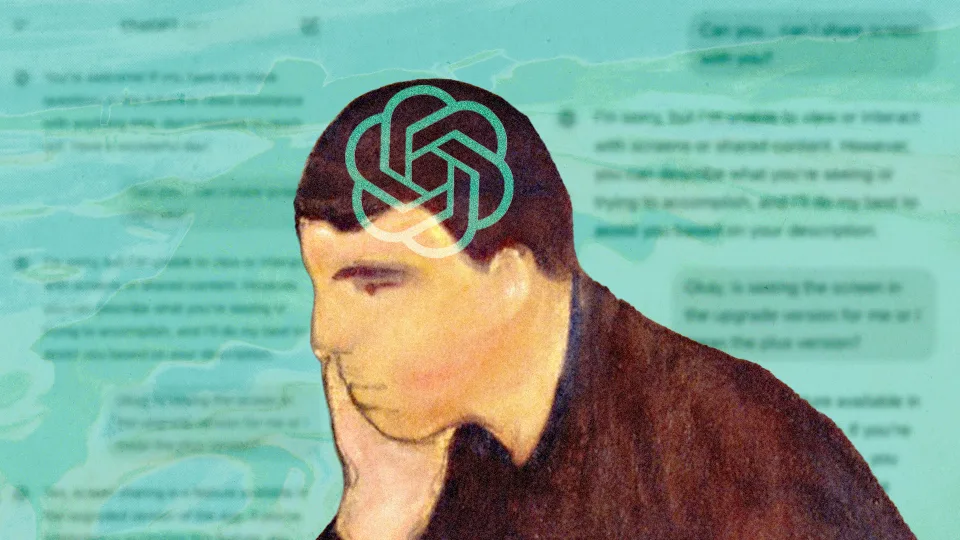Scissi tra due culture, due lingue e due stati, i palestinesi di Israele e gli arabi di Israele si trovano in una situazione complicata. La racconta bene il libro Fondato sulla sabbia, che tenta di ricostruire la storia recente di Israele e dei suoi abitanti, per capire come si è arrivati a questo punto.
Pubblichiamo un estratto dal libro Fondato sulla sabbia di Anna Momigliano, pubblicato da Garzanti. Ci è sembrato un libro importante, che fa capire meglio cosa è successo in Israele negli ultimi anni, e come si è potuti arrivare a ciò a cui stiamo assistendo oggi. In particolare abbiamo scelto il capitolo che tratta dei “palestinesi di Israele” e degli “arabi di Israele”, che racconta di una fetta di popolazione israeliana che raramente viene presa in considerazione, e che pure è interessante e si trova nella drammatica situazione di trovarsi scissa tra due culture, due lingue, due stati.
Ci eravamo lasciati con Elik nato dal mare. Ora vorrei cominciare con un’altra storia di un bambino ebreo in riva al mare, un passaggio da Il pessottimista, breve romanzo storico di Emile Habibi. Racconta Saeed, il pessottimista del titolo e l’io narrante, di essersi seduto in spiaggia per piangere il figlio morto, mormorando fra sé e sé un richiamo vano, come se il ragazzo potesse rispondere dalle onde. A un certo punto, Saeed si accorge che seduto accanto a lui c’è un bambino ebreo, e quel bambino gli domanda con chi sta parlando. Con i pesci, risponde Saeed. In che lingua? In arabo. I pesci parlano arabo? Solo i pesci più vecchi, quelli che erano qui da prima, spiega Saeed al bambino, i pesci più giovani parlano l’ebraico come te, e parlano anche l’arabo, perché i pesci sanno tutte le lingue del mondo, il mare non ha confini e c’è spazio per tutti. Non ci girerò intorno: Il pessottimista è un romanzo che parla soprattutto della Nakba, la cacciata di 750.000 palestinesi all’indomani della dichiarazione di indipendenza di Israele e dell’invasione da parte dei paesi arabi vicini. La Nakba è un fatto storico, su questo non ci piove, anche se in certi ambienti filo-israeliani fa comodo pensare che non sia mai esistita. Ne scrisse persino Yitzhak Rabin nella sua autobiografia, pubblicata nel 1979. In un passaggio Rabin, da ex combattente, raccontò candidamente di come le unità dell’esercito sotto il suo comando forzarono gli abitanti di due cittadine palestinesi, Ramle e Lod, a lasciare le loro case. Il pessottimista parla della Nakba, “la catastrofe”: il figlio di Saeed è stato ucciso dai soldati israeliani. Ambientato tra il 1948, con la nascita dello Stato di Israele, e il 1967, anno della guerra dei Sei Giorni – che portò all’occupazione militare di Gaza e della Cisgiordania –, questo breve romanzo include, con pazienza dolorosa, i nomi dei villaggi distrutti, svuotati o trasformati in insediamenti israeliani: Tantura, al-Tira, Kafr Lam, Ayn Ghazal, Ijzim, Khirbat Al-Burj. Eppure, nonostante tutto, offre anche uno spiraglio di riconciliazione: vedi, bambino, una volta qui c’eravamo noi, ora siamo rimasti in pochi perché ci avete cacciati, oggi però tu e io siamo qui insieme, come i pesci che parlano arabo ed ebraico e sanno tutte le lingue del mondo. In Italia è stato pubblicato, tanti anni fa, con il sottotitolo Un arabo d’Israele. E questo era, in effetti, Emile Habibi, così come lo era il suo alter ego Saeed: un cittadino arabo dello Stato di Israele. Arabi israeliani, come li chiama qualcuno, anche se da un po’ di tempo molti di loro, specie tra le generazioni più giovani, preferiscono definirsi “palestinesi israeliani” o, in alternativa, “palestinesi del 1948”. Gli arabi in Israele sono quasi due milioni, poco più del 20 per cento della popolazione locale. La cifra però include anche alcune categorie di persone, come i residenti di Gerusalemme Est e alcuni abitanti delle alture del Golan, che non sono cittadini: se riduciamo il campo agli arabi con cittadinanza israeliana il numero scende a un milione e mezzo, circa il 17 per cento. Qui dico “arabi” e non “palestinesi” perché, per essere precisi, non tutti gli arabi israeliani sono palestinesi: ci sono anche i drusi, una comunità etnico-religiosa che si trova anche in Siria e in Libano, e i circassi, una popolazione originaria del Caucaso, giunta in Palestina alla fine dell’Ottocento dalla Russia zarista. Minoranze nella minoranza, drusi e circassi rappresentano due gruppi a parte, separati e distinti dai palestinesi d’Israele, anche se ne condividono la lingua. A voler complicare ulteriormente le cose, ci sarebbero anche i beduini, pure loro una minoranza nella minoranza, che però sono anche palestinesi; insomma, un sottogruppo. Tornando a drusi e circassi, si tratta di due comunità piccole – la prima conta circa 150.000 individui, la seconda poche migliaia –, ma era giusto ricordarle, un po’ per rendere l’idea della complessità della società israeliana, e un po’ per mettere le mani avanti e avvertire il lettore: le rilevazioni ufficiali sugli arabi israeliani si riferiscono a tutti i cittadini israeliani di lingua araba, indipendentemente dall’etnia; dunque, quando tra poco vedremo qualche dato sulla qualità della vita dei palestinesi israeliani, bisognerà tenere conto di questo fattore statistico. I palestinesi israeliani, si diceva, rappresentano la stragrande maggioranza degli arabi israeliani. Sono, nonostante il nome possa sembrare un ossimoro, cittadini israeliani tanto quanto gli ebrei e godono, ufficialmente, degli stessi diritti. La dichiarazione di indipendenza del 1948 assicura “completa uguaglianza di diritti sociali e politici a tutti i suoi abitanti senza distinzione di religione, razza o sesso” e garantisce “libertà di religione, coscienza, lingua, istruzione e cultura”. Israele non ha una costituzione, ma le Leggi Fondamentali, che stabiliscono che Israele è “uno stato ebraico e democratico” dove dignità e diritti sono garantiti a “tutte le persone”. Voci critiche hanno fatto notare che nelle Leggi Fondamentali manca il riferimento esplicito al principio di uguaglianza che si trovava invece nella dichiarazione di indipendenza: è una critica sensata, ma che rischia di far perdere di vista il punto principale, e cioè che la discriminazione dei palestinesi israeliani esiste soprattutto nella pratica, non sulla carta. Prendiamo l’economia. L’incidenza della povertà è più del doppio tra i palestinesi israeliani rispetto agli ebrei: il 45 per cento delle famiglie arabe vive sotto la soglia di povertà, contro il 13 per cento delle famiglie ebraiche. Poi c’è l’istruzione: soltanto il 15 per cento degli arabi di Israele ha una laurea, mentre per gli ebrei questa percentuale sale al 33. C’è poi un dato, in particolare, che lascia atterriti: di tutti gli omicidi registrati sul territorio israeliano tra il 2020 e il 2021, otto su dieci sono avvenuti all’interno della comunità araba. Insomma, stiamo parlando di una minoranza che, demograficamente, rappresenta appena il 20 per cento del paese, ma che è coinvolta nel 70 per cento degli omicidi: nella quasi totalità dei casi, sia la vittima sia l’assassino sono arabi – nel freddo linguaggio statistico-giudiziario, questi sono crimini intracomunitari. Il tasso di criminalità all’interno della comunità araba, di cui gli omicidi sono solo la punta dell’iceberg, è un problema che allarma parecchio la stampa israeliana ed è in costante crescita: nel 2011, per fare un paragone, “soltanto” il 40 per cento degli omicidi riguardava gli arabi. È, soprattutto, lo specchio di una comunità che sta vivendo una situazione di profondo disagio, socio-economico, certo, ma anche politico: l’impressione generale è che i palestinesi di Israele siano sempre più lasciati a loro stessi. La situazione è grave, ma non priva di un barlume di speranza. Il livello dell’istruzione femminile, per esempio, sta crescendo. Non mancano i casi di arabi in posizioni di prestigio. I palestinesi israeliani sono visibilmente sovrarappresentati nelle professioni sanitarie altamente qualificate: sono arabi il 60 per cento dei farmacisti e il 25 per cento dei medici. E si tratta di percentuali destinate a crescere: nelle facoltà di medicina i palestinesi sono il 63 per cento degli studenti, in quelle di farmacia l’84. Quella del palestinese col camice bianco è una figura così diffusa, ormai quasi uno stereotipo, che ha ispirato il personaggio di “Salma la farmacista” della celebre trasmissione televisiva satirica Eretz Nehederet. Due dei giornalisti più famosi del paese, Suleiman Maswadeh e Lucy Aharish, sono palestinesi, come pure la rettrice dell’Università di Haifa, Mouna Maroun. In tutta la storia dei governi israeliani, però, ci sono stati solo tre ministri arabi: Salah Tarif (2001-2002), Galeb Magadla (2007-2009) e Issawi Frej (2021-2022). Per alcuni versi gli arabi israeliani, che siano palestinesi, drusi o circassi, vivono in un sistema separato. Hanno scuole diverse, dove la lingua d’insegnamento è l’arabo e l’ebraico si studia obbligatoriamente come seconda lingua insieme all’inglese – dettaglio non da poco: per gli ebrei, che studiano in lingua ebraica, l’apprendimento dell’arabo è invece del tutto facoltativo. Il risultato è che in genere gli ebrei israeliani non parlano arabo, e quando lo parlano è a un livello elementare, mentre gli arabi israeliani parlano in genere un ebraico discreto, specie quelli con una buona istruzione. Alcuni vivono nelle cosiddette “città miste”, come Haifa, Gerusalemme, Lod e Ramle, molti altri in città e villaggi arabi, come per esempio Nazareth. Questa separazione, va detto, non è obbligatoria per legge: Sayed Kashua, scrittore e autore televisivo, mandava il figlio in una scuola ebraica per il semplice fatto che abitava in un quartiere di Gerusalemme a maggioranza ebraica, e finì per soprannominare il bambino, scherzosamente, “il piccolo Sion” perché tornava a casa cantando canzoni in ebraico. La separazione, poi, non è totale: spesso chi abita in città arabe lavora in città ebraiche, e alcuni luoghi di lavoro, soprattutto gli ospedali, sono decisamente misti. Nelle università ebrei e palestinesi israeliani studiano insieme. Per molti di loro è la prima volta. Così è stato anche per Rula Daoud, un’attivista palestinese israeliana, copresidente di Standing Together, un gruppo pacifista e contrario all’occupazione, molto attivo nell’abbattere i muri tra arabi ed ebrei all’interno della società israeliana. Ci siamo conosciute perché seguivo la sua attività politica, che ammiro molto, ma trovo che anche la sua storia personale aiuti a inquadrare certe contraddizioni della società israeliana. Rula, che ha trentotto anni e oggi vive a Jaffa, vicino a Tel Aviv, è nata e cresciuta a Kafr Yasif, un villaggio arabo della Galilea, nel Nord del paese. Per i suoi primi diciotto anni di vita non ha conosciuto ebrei: “Ogni tanto mi capitava di incrociarne qualcuno, per esempio se andavo a comprare qualcosa in una città vicina o se andavo al centro commerciale, ma nella mia vita quotidiana non c’era interazione”, mi ha raccontato. Poi, dopo il liceo, si è trasferita a Tel Aviv per studiare pedagogia: “L’università è stata il primo posto dove ho cominciato a interagire con gli ebrei su base quotidiana. Ed è stato anche il momento in cui ho capito di essere parte di una minoranza in questo paese”. È una dinamica che ho avuto occasione di osservare, nel mio piccolo, in prima persona, quando frequentavo l’Università ebraica di Gerusalemme. Nel programma che seguivo c’erano diversi ragazzi palestinesi, soprattutto di Gerusalemme Est, dunque non cittadini di Israele: erano gli anni del processo di pace, quando il clima era disteso, eppure era evidente che molti di loro non erano abituati a interagire con gli ebrei israeliani. C’era una certa distanza – non ostilità, per fortuna – tra i due gruppi: da un lato i ragazzi ebrei, dall’altro gli arabi, e ognuno si faceva i fatti propri. Per un certo periodo, a dire il vero, presi l’abitudine di trascorrere la pausa pranzo con una studentessa palestinese, molto simpatica e intelligente, di qualche anno più grande di me: eravamo entrambe ghiotte dei toast al formaggio che vendeva un certo bar, ed eravamo entrambe due chiacchierone. Quando ha scoperto che ero ebrea, però, è rimasta stupita: visto che ero italiana, e il mio ebraico era incerto tanto quanto il suo, era convintissima che fossi cattolica! La rivelazione non ha affatto incrinato la nostra abitudine di pranzare insieme, però a volte mi chiedo se sarebbe iniziata, senza quella piccola omissione: che ci piacesse o no, studiavamo in un’università dove palestinesi ed ebrei erano vicini, ma lontani. Per Rula il trasferimento da un villaggio arabo a una città ebraica non è stata un’esperienza positiva: “Se sei un palestinese che vive in una grande città come Tel Aviv, ti scontri tutti i giorni con piccoli atti di razzismo, di discriminazione. Per esempio, molti proprietari di casa non vogliono affittare il loro appartamento a un arabo. Alla stazione dei treni ti chiedono spesso di mostrare i documenti, cosa che non fanno con i ragazzi ebrei, specialmente in tempo di guerra. E purtroppo in questo paese ne abbiamo tante di guerre”. Per capire come siamo arrivati a questo punto, è il caso di ripassare un po’ di storia. Il piano onu del 1947 prevedeva la partizione della Palestina, allora sotto il mandato britannico, in due, anzi, tre parti: uno stato ebraico, in una zona pari al 56 per cento del territorio totale ma che includeva un’ampia area desertica, con una popolazione di 500.000 ebrei e 400.000 palestinesi; uno stato arabo-palestinese, in una zona pari al 43 per cento del territorio totale, con una popolazione di 800.000 palestinesi e 10.000 ebrei; infine la zona di Gerusalemme, il restante 1 per cento, sotto giurisdizione internazionale. Mentre all’onu passava questa risoluzione, la Palestina mandataria si trovava nel caos più totale: una guerra civile, arabi contro ebrei contro gli inglesi, tutti contro tutti. Il piano in ogni caso non divenne mai realtà, perché l’anno successivo, quando si concluse il mandato britannico, i paesi arabi confinanti invasero sia il neonato Stato di Israele sia quello che sarebbe dovuto diventare uno stato palestinese. La guerra del 1948 si concluse con la vittoria di Israele ma anche, per paradosso, con l’espansione territoriale di Egitto e Giordania: si produsse così una situazione in cui lo stato ebraico era più grande di quanto previsto dal piano onu, la Giordania inglobava quella che oggi chiamiamo Cisgiordania e l’Egitto occupava la Striscia di Gaza. Di uno stato palestinese neanche l’ombra. La guerra del 1948, insieme alla guerra civile che la precedette, comportò l’espulsione forzata di 750.000 palestinesi dalle loro case e lo spopolamento di almeno 400 villaggi: si tratta della Nakba, o Naqba, a seconda della traslitterazione dall’arabo. Molti fuggirono a Gaza e in Cisgiordania, molti altri nei paesi arabi vicini. Alcuni dei palestinesi in fuga dai loro villaggi si spostarono a Nazareth, considerata un luogo più sicuro in quanto grande città a netta maggioranza araba. Alcuni di quelli che fuggirono all’estero riuscirono poi a rientrare in Israele, anche se le autorità cercarono di impedirglielo: Israele li definiva mistanenim, “infiltrati”. Mahmoud Darwish, il grande poeta nazionale palestinese nato in Galilea nel 1941, era uno di loro. Fuggì in Libano nel 1948: “Quando tornammo, dopo circa due anni, entrammo come infiltrati. Arrivammo a Deir Al-Sad e ogni volta che veniva la polizia ci nascondevamo”. Dopo la guerra d’indipendenza erano presenti nel territorio israeliano 160.000 palestinesi. Poi, nel 1967, con la guerra dei Sei Giorni, Israele ha conquistato anche Gaza e Cisgiordania, quelli che oggi chiamiamo “territori occupati”, senza però annetterli, e invece ha pienamente annesso Gerusalemme Est. Il risultato è che il popolo palestinese è ora diviso in quattro gruppi: i palestinesi israeliani, cittadini di Israele, o, come li chiama qualcuno, i “palestinesi del 1948”; i palestinesi dei territori occupati, detti anche “palestinesi del 1967”; i palestinesi della diaspora, presenti soprattutto in Giordania, Siria e Libano, ma anche al di fuori della regione mediorientale; e infine i palestinesi di Gerusalemme Est, che hanno la residenza ufficiale in Israele ma non sono, per lo più, cittadini. L’excursus storico non era fine a sé stesso: i fatti del passato influenzano il presente e, soprattutto, i palestinesi sono un unico popolo anche se la storia li ha portati a essere cittadini di nazioni diverse; questo è il punto di partenza per capire come vivono la loro identità. I palestinesi israeliani sono diventati cittadini nel 1952. Come mai nel 1952 e non sin dalla fondazione dello stato, nel 1948? La verità è che nessuno, tecnicamente, era cittadino israeliano prima del 1952, perché la giovane nazione non aveva ancora varato una legge della cittadinanza. Dunque, gli arabi diventarono cittadini quando lo diventarono gli ebrei; tuttavia, per più di un decennio, molti furono costretti a vivere sotto la legge militare: imposta a numerosi villaggi e cittadine arabe, su base territoriale, la legge marziale imponeva limitazioni alla libertà di movimento, coprifuochi, censure a giornali e altri organi di stampa, restrizioni sulla libertà di aggregazione. Il paradosso, come riassume la studiosa israeliana Dahlia Scheindlin, era che i palestinesi potevano votare ma, in quanto palestinesi, la loro partecipazione elettorale “non aveva alcune delle libertà civili associate a un processo giusto e libero”. Le leggi militari sono state revocate nel 1966, un anno prima della guerra dei Sei Giorni che avrebbe portato, come abbiamo già visto, all’occupazione. Dunque, in un breve lasso di tempo i palestinesi di Israele hanno ottenuto, finalmente, e per lo meno sulla carta, gli stessi diritti dei loro concittadini ebrei, e i palestinesi di Gaza e Cisgiordania si sono ritrovati sotto l’occupazione militare israeliana. Il risultato è stato ciò che l’intellettuale israeliano palestinese Mohammad Darawshe ha definito la contemporanea “israelianizzazione e la ripalestinizzazione” della comunità araba in Israele: a partire dalla fine degli anni Sessanta, da un lato gli arabi israeliani hanno cominciato a essere parte integrante del tessuto sociale nazionale, pur con tutte le divisioni e le discriminazioni descritte sopra; dall’altro sono venuti “a contatto con il resto del mondo arabo attraverso i Palestinesi di Gaza e della Cisgiordania”. In altre parole, i palestinesi sul territorio israeliano sono tornati a sentirsi vicini ai palestinesi oltreconfine, proprio mentre hanno cominciato a vivere come cittadini di Israele. Secondo Darawshe è una contraddizione solo apparente. In tempi più recenti, questa ripalestinizzazione è avvenuta anche su un piano linguistico: è la ragione per cui oggi, per lo meno in ambienti progressisti, è considerato più corretto dire “palestinesi israeliani”, o “palestinesi del 1948”, anziché “arabi israeliani”. Non è sempre stato così: in una delle sue poesie più famose, Carta di identità, Mahmoud Darwish scriveva: “Prendi nota / sono arabo”, e nessuno si sarebbe sognato di accusarlo di collaborazionismo, però oggi la definizione “arabo israeliano” è spesso percepita come un tentativo di annacquare l’identità dei palestinesi israeliani. Rula Daoud, l’attivista di Standing Together di cui parlavo prima, me l’ha spiegata in questi termini: “Ci tengo a definirmi palestinese israeliana, anziché semplicemente araba israeliana, perché voglio far sapere alle persone qual è la mia identità. Quando il governo usa l’espressione ‘arabi israeliani’ è perché vuole negare la nozione che i palestinesi siano un popolo, che io sia parte di un popolo più grande. Però noi siamo un popolo eccome, anche se alcuni di noi stanno qui, altri in Cisgiordania, a Gaza o nella diaspora”. Questo, bene inteso, non significa che Rula non si senta anche israeliana; infatti, è una dei leader di un gruppo che si batte per la convivenza tra arabi ed ebrei all’interno dello Stato di Israele: “Il punto è che questa è l’identità con cui sono nata, l’identità che mi appartiene e non dovrebbe fare paura alle persone”. Questo modo di identificarsi è particolarmente diffuso tra i giovani con una forte coscienza politica. Lo ha spiegato Sheren Falah Saab, giornalista del quotidiano progressista «Haaretz», in una puntata del podcast settimanale del suo giornale: “C’è chi preferisce enfatizzare l’identità palestinese, che è parte della storia delle loro famiglie, dei loro villaggi, delle generazioni precedenti. Storie che dimostrano che la Nakba non è stata dimenticata. Per questo le generazioni più giovani preferiscono definirsi palestinesi israeliane”. Definirsi palestinesi israeliani, in altre parole, significa rivendicare sia una vicinanza ai palestinesi dei territori occupati e della diaspora, sia il proprio legame famigliare con la Nakba, un evento che ha riguardato anche le famiglie che sono rimaste in Israele, vuoi perché sfollate internamente, vuoi perché discendenti di retournée, vuoi perché divise dai parenti. In tutto questo, bisogna riconoscere che si tratta di un’evoluzione relativamente recente. Come ha sostenuto Hanin Majadli, un’altra giornalista di «Haaretz», in uno dei suoi editoriali: “Fino all’inizio degli anni Duemila, il nostro mondo concettuale e, la terminologia che usavamo erano diversi. Per esempio, era normale dire ‘sono un arabo israeliano’. Mentre oggi è praticamente un insulto”. E, in tutto questo, bisogna riconoscere anche che non tutti la pensano così. L’ultimo sondaggio sul tema, che però non è recente, perché risale al 2017, rilevava che la metà dei cittadini israeliani che parlano arabo si considera prima di tutto “araba israeliana” (40,8 per cento) o prima di tutto “araba” (8,7 per cento). Circa un quarto incentrava la sua identità attorno al popolo palestinese: nello specifico, il 15,4 per cento si considerava prima di tutto “palestinese” e l’8,9 prima di tutto “palestinese israeliano”. Infine, una minoranza piccola ma non trascurabile, l’11,4 per cento, si considerava prima di tutto “israeliana”. Ayman Oded, un parlamentare del partito comunista israeliano, ha trovato parole lucide per cristallizzare il sentire di molti palestinesi israeliani davanti a questa duplice identità. In un discorso divenuto celebre ha affrontato la tensione tra appartenenza civica (ezrahut, in ebraico) e appartenenza nazionale (leumiut), due concetti separati, anche se a volte sovrapponibili, che, specie in tempo di guerra, a possono produrre una pressione schiacciante sui palestinesi di Israele. Il 13 marzo 2024, mentre la guerra di Gaza infuriava, Oded ha parlato alla Knesset, il parlamento unicamerale di Gerusalemme: “Noi siamo i palestinesi cittadini di Israele, cittadini di un paese che occupa il nostro popolo”, ha detto, riferendosi all’occupazione dei territori palestinesi. “C’è forse una situazione più difficile della nostra, quando l’appartenenza civica [ezrahut] si contrappone all’appartenenza nazionale [leumiut]? Anche qui davanti a voi, mentre parlo, cammino su un filo sottile. Cerco di mantenere un equilibrio davanti all’abisso in cui ci troviamo”, Oded riconosce che, in questa tensione tra identità civica e identità nazionale, trovare un equilibrio perfetto è impossibile: “Camminare per tutta la vita su una corda sottile non è facile. Talvolta perdo l’equilibrio e cado un po’ verso il lato della cittadinanza e allora la cosa non piace alla società palestinese. E a volte perdo l’equilibrio e cado un po’ verso il lato della nazionalità, allora la cosa non piace alla società ebraica. E ogni tanto il filo diventa stretto in modo quasi impossibile, come sta accadendo in questi ultimi mesi”. Oded ha utilizzato due categorie analitiche: da un lato un’appartenenza nazionale che, parafrasando lo storico valdostano Federico Chabod, potremmo definire una “vicinanza spirituale”, oltre che di sangue, ai palestinesi di Gaza e della Cisgiordania; dall’altro un’appartenenza civica che rimanda a un universalismo realista, coi piedi ben piantati per terra – il “da dove vieni” in contrapposizione al “dove sei ora”, la comunità di origine in contrapposizione alla comunità di cui la storia ti ha reso parte. Eppure, la sua non era un’analisi fine a sé stessa. Nella sua visione questa duplice appartenenza mette i palestinesi in una posizione unica: “Una delle cose che mi ha stupito negli ultimi tempi è la quasi totale mancanza di empatia dimostrata sia dai palestinesi sia dagli ebrei. Dopo il 7 ottobre gran parte della società palestinese ha festeggiato. E negli ultimi mesi gran parte della società ebraica si è completamente disinteressata della morte di decine di migliaia di palestinesi, tra cui i bambini sotto i dieci anni si contano a migliaia, cosa che dovrebbe fare soffrire qualsiasi essere umano degno di questo nome. Invece i cittadini palestinesi dello Stato di Israele sono quasi gli unici che guardano la televisione israeliana e Al-Jazeera, sono gli unici che hanno visto i bambini uccisi da entrambe le parti, sono gli unici che hanno visto le madri ebree e le madri palestinesi piangere e che hanno pianto insieme a loro. Sono gli unici ad avere sentito le storie da entrambe le parti. Sono gli unici che parlano l’ebraico e l’arabo, che conoscono le due culture”. A questo punto avrete capito che la storia di Israele è in realtà composta da due storie. Da un lato quella degli ebrei israeliani, che non hanno un’altra terra, dall’altro quella dei palestinesi cacciati da quella terra. Già Edward Said aveva capito che queste due storie erano entrambe vere e valide, che erano legate a doppio filo l’una all’altra e che non c’era alternativa se non riconoscerle entrambe: “Non riesco a concepire in alcun modo di a) non immaginare gli ebrei di Israele come l’esito decisivo e davvero definitivo dell’Olocausto e b) non esigere da loro il riconoscimento di ciò che hanno fatto ai palestinesi durante e dopo il 1948”. Quello di cui Edward Said, che non era un palestinese di Israele ma un palestinese americano nato a Gerusalemme e cresciuto in Egitto, forse non aveva tenuto conto è che però in Israele esiste anche una terza storia. Negli ultimi anni si è sviluppata in molti giovani intellettuali e attivisti palestinesi israeliani la consapevolezza che la loro esperienza ed esistenza rappresentano, appunto, una terza storia, altrettanto valida e reale rispetto a quella degli ebrei israeliani e dei palestinesi della diaspora e dei territori occupati. Nell’ottobre del 2023, all’indomani del brutale attacco terroristico di Hamas contro i kibbutz e le città del Sud del paese, due ragazzi palestinesi israeliani, Amira Mohammed e Ibrahim Abu Ahmad, hanno ideato un podcast. L’hanno chiamato Unapologetic: The Third Narrative e hanno scelto di parlare in inglese per farsi capire da tutti – arabi, israeliani e quanti all’estero seguono le vicende della regione. “Proprio perché siamo palestinesi e cittadini israeliani siamo in una posizione privilegiata. Siamo gli unici che hanno la capacità di vedere le cose da due prospettive diverse, dal punto di vista israeliano e dal punto di vista palestinese”, ha spiegato nella prima puntata Ibrahim, ventiquattro anni. Amira e Ibrahim hanno due esperienze molto diverse, così come è diverso il loro rapporto con la cultura ebraico-israeliana, che rappresenta la maggioranza del paese in cui vivono. Lei, nata a Gerusalemme Est e cresciuta senza parlare una parola di ebraico, ha ottenuto la cittadinanza solo in età adulta e ha frequentato l’università a Ramallah, in Cisgiordania, facendo esperienza dell’occupazione in tutta la sua brutalità. Lui, nato e cresciuto a Nazareth, ha imparato l’ebraico da piccolo, guardando i cartoni animati e parlando con i cugini che abitano in una città a maggioranza ebraica, e ha provato a frequentare l’università al Cairo, ma poi ha dovuto lasciare l’Egitto perché lì lo vedevano come un nemico, in quanto israeliano. Eppure, entrambi si battono per lo stesso obiettivo: “Promuovere una società condivisa”, un’idea di Israele che sia una casa per tutti i suoi cittadini. “In Occidente si è diffusa l’idea che qui sia tutto bianco o nero, che esistano solo due narrazioni, che uno può essere solo pro-israeliano o pro-palestinese. Ma noi vogliamo creare una terza narrazione”. A qualcuno potrà sembrare un punto di vista pilatesco, un’equidistanza artificiosa. Ma per molti palestinesi israeliani è qualcosa di reale e difficile, l’unica identità possibile. È una terza storia, che è anche un ponte tra due storie inconciliabili.