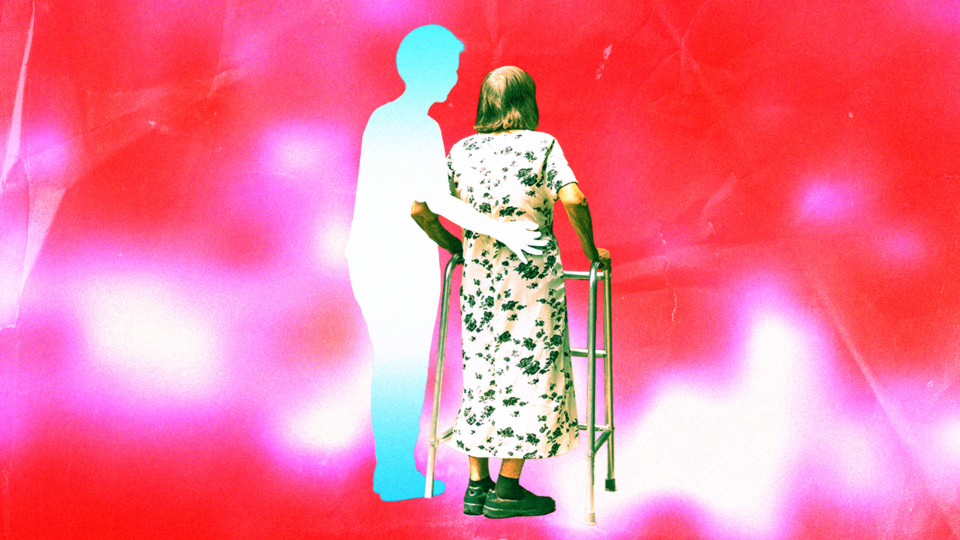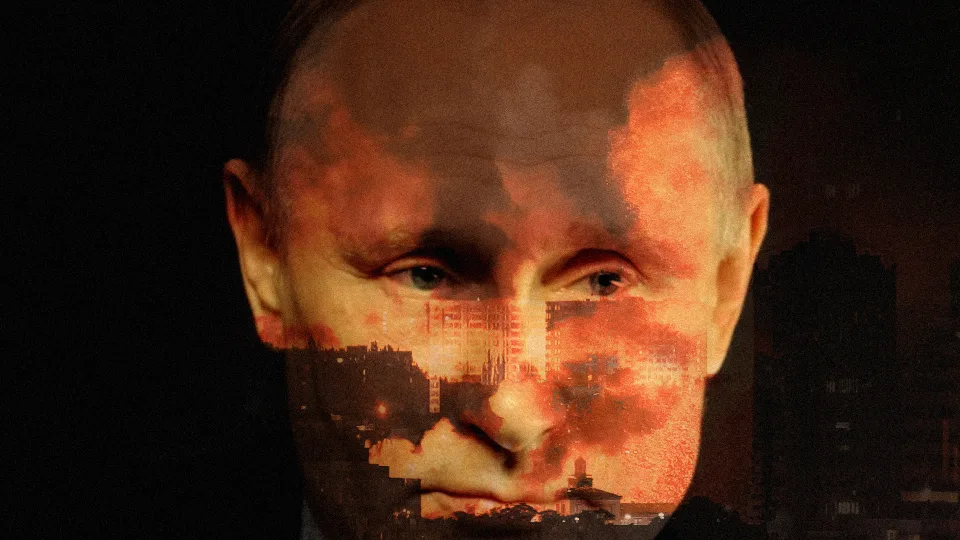In Italia la cura degli anziani è delegata alle cosiddette badanti, donne che per motivi economici migrano in solitudine, costrette a lasciare i propri figli nel Paese d’origine
Essere costrette a lasciare che altri crescano i propri figli per accudire i genitori anziani di sconosciuti, lontane migliaia di chilometri da tutto ciò che considerano “casa”. È il paradosso in cui vivono le badanti che lavorano in Italia. Di loro, a cui affidiamo i nostri familiari, spesso sappiamo poco. Delle vite che hanno lasciato venendo qui, ancora meno. Nonostante il loro lavoro sia prezioso e insostituibile in un Paese dove la popolazione è sempre più vecchia, sono “donne invisibili”. Assenti per i loro bambini, che diventano grandi senza madre, e “trasparenti” ai nostri occhi, che le vedono solo come straniere relegate a questo preciso ruolo. Com’è vivere immerse in vite che non sono la propria, tormentate da sensi di colpa e nostalgia?
Un lavoro senza tutele
“Un primo problema per queste persone è il fatto che non staccano mai del tutto dal lavoro, perché in molti casi convivono giorno e notte con gli anziani che assistono”, spiega Giamaica Puntillo, presidente di Acli Colf. “Se nessuno gli dà il cambio, capita persino che facciano fatica a uscire di casa”. Questo isolamento forzato, unito alla privazione del sonno e a condizioni di lavoro durissime, produce una forte alienazione. Quello delle assistenti familiari è inoltre un settore poco tutelato, visto che ancora oggi una parte del lavoro è “nero”, e, soprattutto, “grigio”. Se nel 2023 l’Inps registrava quasi 834mila lavoratori domestici regolarmente assunti, di cui 414mila proprio come badanti, i sindacati stimano che gli irregolari potrebbero essere circa 2 milioni, provenienti soprattutto dall’Europa dell’est. “Per pagare meno contributi, non riuscendo a sostenere i costi, le famiglie fanno contratti da 25 ore settimanali, quando quelle effettive sono più del doppio; in questo modo però al momento di andare in pensione, queste donne hanno un monteore insufficiente”, continua Puntillo. “Nell’ambito domestico, una lavoratrice su due è irregolare, una situazione che noi abbiamo denunciato più volte”, evidenzia Silvia Dumitrache, presidente di A.D.R.I (Associazione donne romene in Italia). “Il lavoro delle badanti è fondamentale per il Paese, ma non viene considerato dalla politica italiana, che lascia il welfare sulle spalle delle famiglie”. Anche per chi ha un contratto, avere la malattia quando si sta male può essere un problema e il preavviso dovuto in caso di licenziamento è di soli 8 o 15 giorni, a seconda del numero di ore lavorate (sono 30 giorni solo per chi ha maturato più di 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro).
Queste donne si trovano anche in uno stato di precarietà cronica, dovuta al fatto che quando le persone che assistono, molto anziane e malate, muoiono, oltre a perdere il lavoro, si ritrovano senza casa, dovendo ricominciare tutto da capo. Ci sono poi le difficoltà legate alla lingua, la cui scarsa conoscenza non fa che complicare le relazioni, alle diversità culturali e alla mancanza di preparazione professionale, visto che la maggior parte delle badanti si improvvisa tale.
“La mancanza di strumenti per fronteggiare alcuni tipi di malattie, su tutte l’Alzheimer, può generare situazioni veramente pesanti”, spiega Rosetta Battista, responsabile del circolo Acli Colf Milano. “Alcune donne arrivano qui dicendo che non ce la fanno più e vogliono licenziarsi. Noi cerchiamo di aiutarle attraverso la formazione”. E ancora, le badanti sono in balia dei loro datori di lavoro, cioè di famiglie che hanno proprie abitudini, dinamiche e regole, a cui si trovano a dover sottostare. In questo contesto possono verificarsi anche maltrattamenti e abusi, sia psicologici che fisici. “Ci hanno riferito casi di anziani che alzano le mani o commettono violenze sessuali”, affermano da Acli Colf. Spinte dal bisogno economico, alcune donne non riescono a lasciare il posto di lavoro nemmeno dopo episodi così gravi.
Madri a distanza
Al disagio per le condizioni in cui le badanti vivono e lavorano in Italia, che a volte rasentano uno stato di schiavitù, si aggiunge il dolore per la distanza dai propri affetti più cari. “Sentono i figli al telefono ogni sera, ma è chiaro che quella creata dalla tecnologia è una vicinanza falsata”, prosegue Battista. “Poi, da una parte, loro non riescono a raccontare la propria fatica, e dall’altra, i figli non arrivano a esprimere il dolore causato dalla loro assenza. Entrambi non sono del tutto sinceri per paura di ferirsi e perché sanno che le cose difficilmente cambieranno”. Di questo aspetto ci parla anche Lucia, che da 20 anni lavora come badante in un paesino della Puglia, e si commuove mentre ricorda la reazione di sua figlia quando lasciò Strâmtura, in Romania. “Mamma, proprio quando ho più bisogno di te, mi lasci”, si era sentita dire dalla ragazza, che all’epoca stava per affrontare l’esame di maturità. Come molte sue connazionali, questa signora ha deciso di venire in Italia per permettere ai suoi figli di studiare. Nel suo Paese lavorava come impiegata in Comune, ma lo stipendio, che si aggirava intorno all’equivalente di circa 200 euro, non bastava, anche perché suo marito era disoccupato. “È stata una mia cugina a trovarmi lavoro in Italia. Ma i miei figli, tre maschi e tre femmine, erano molto dispiaciuti che me ne andassi”, ci dice. Ora quattro di loro sono laureati e tre vivono all’estero. Tra non molto Lucia vorrebbe andare in pensione e tornare in Romania per godersi la vecchiaia e i suoi nove nipoti. Quattro anni fa, però, suo marito è mancato mentre lei si trovava qui, una circostanza che la addolora particolarmente. Nel caso di questa signora la forte nostalgia di casa è stata alleviata da esperienze positive con le famiglie italiane, dalla vocazione che sente per l’accudimento (“mi piace prendermi cura delle persone, che siano bambini o persone grandi”, dice) e dalla convinzione che il suo sacrificio fosse comunque riconosciuto e apprezzato dai suoi figli (già almeno preadolescenti quando lei è emigrata).
Ma non per tutte le badanti è così e, in particolare, l’assenza di reti sociali e nuovi legami possono pesare molto negativamente. “Con l’isolamento, vissuti di profonda tristezza a volte possono sfociare in trascuratezza nella cura di se stesse e veri tratti depressivi”, spiega Lilli Brancasi, psicologa e psicoterapeuta che tiene corsi di formazione per badanti in provincia di Roma e Brindisi. “Come in tutte le professioni di aiuto c’è poi il rischio di burnout”. Mentre queste donne lottano contro disturbi come l’insonnia e l’ansia, i loro figli, che vengono chiamati “orfani bianchi”, si trovano a fare i conti con la rabbia per l’abbandono subìto in età infantile. Sofia (nome di fantasia, come quelli che seguono), che ha dovuto lasciare i suoi bambini in Ucraina quando avevano 5 e 7 anni, ci racconta come la figlia Luba le rimproverasse la sua scelta di emigrare. “Quando prendeva un bel voto a scuola, voleva tornare a casa a raccontarmelo, ma io non c’ero”, dice. “Lo stesso per ogni volta in cui è stata male e mi voleva accanto”. Come Lucia, anche lei è arrivata in Italia grazie a una parente che lavorava già qui. A 30 anni era rimasta disoccupata dopo che la fabbrica di zucchero dove lavorava aveva chiuso. “Quando mia zia mi diceva questo termine, ‘badante’, io non sapevo nemmeno cosa volesse dire”, ricorda.
“Essere costrette a lasciare che altri crescano i propri figli per accudire i genitori anziani di sconosciuti, lontane migliaia di chilometri da tutto ciò che considerano ‘casa’. È il paradosso in cui vivono le badanti che lavorano in Italia”.
All’inizio non era per nulla convinta di volere partire, ma poi aveva desistito davanti alla prospettiva che, altrimenti, non sarebbe riuscita a pagare nemmeno cose essenziali, come le medicine e i libri di scuola per i suoi figli. Per quattro anni, mentre aspettava di potersi mettere in regola grazie a una sanatoria, non ha più fatto ritorno nel suo paesino, che si trova vicino al confine con la Romania. “È una cosa vergognosa non tornare dai propri cari così a lungo”, si autoaccusa. Per Sofia lo scoppio della guerra in Ucraina, nel 2021, ha rappresentato un punto di svolta. All’epoca ha trovato la solidarietà di amici e datori di lavoro. “La signora da cui lavoravo in quel momento sapeva cos’è la guerra, perché l’aveva vissuta”, racconta. “Mi ha subito detto che avrebbe accolto i miei figli nella sua casa”. Sofia ha provato a far sì che entrambi potessero venire in Italia, ma suo figlio, come prevede la legge ucraina, non può ancora lasciare il Paese, dovendo rimanere disponibile a un’eventuale chiamata al fronte (anche se per il momento per lui, che ha meno di 25 anni, la leva non è obbligatoria). Sua figlia Luba, invece, dopo aver fatto uno zaino con appena due cambi, ha preso un autobus per Verona, dove la madre l’aspettava. Si sono riviste per la prima volta dopo tre anni e hanno dovuto recuperare un rapporto complicato dalla distanza. Dopo che l’ultima anziana che ha accudito è morta, Sofia ha deciso di non volere più lavorare come badante. Oggi fa la cameriera in un ristorante e vive in un appartamento con Luba. Sua madre però a volte al telefono le chiede come mai non torni a fare quel mestiere che le garantiva vitto e alloggio gratis. “Lei non capisce cosa ho subito in questi 15 anni”, si sfoga. “Tutte le notti in cui non ho dormito. Le volte in cui anche se ero malata, dovevo lavorare. I momenti in cui io, che sono una persona calma, ho perso completamente la pazienza. Una volta sono finita in ospedale per una forte tachicardia, stavo veramente male. Noi badanti dovremmo avere uno psicologo”.
Sindrome Italia
Con il termine Sindrome Italia, già a partire dai primi anni del 2000, si definisce un insieme di sintomi riscontrati nelle donne tornate a casa dopo aver lavorato come badanti nel nostro Paese per molti anni. Il termine, coniato dai due psichiatri ucraini Andriy Kiselyov e Anatoliy Faifrych, include disturbi che vanno dalla depressione all’ansia e all’insonnia, passando, nei casi più gravi, per allucinazioni e comportamenti suicidari. Il disagio si manifesta quando il tanto atteso ritorno nei Paesi di origine fa emergere le conseguenze della prolungata assenza. La realtà che queste donne hanno lasciato, e che nella loro mente è rimasta congelata, non c’è più, perché ovviamente tutto, dalla politica alle amicizie, è cambiato. Oltretutto i loro stessi figli, cresciuti mentre non c’erano, ne disconoscono il ruolo genitoriale. Questo choc provoca una profonda crisi identitaria che travolge anche il senso di maternità. “Noi diciamo che stiamo facendo questi sacrifici per i nostri bambini, ma la verità è che noi stiamo invecchiando e ci ammaliamo a livello mentale e anche i nostri bambini si sono ammalati accanto a noi”, dice una donna romena nel documentario Sindrome Italia, di Ettore Mengozzi.
Alcune badanti si rendono conto di aver bisogno di aiuto già mentre sono in Italia. A Milano, ad esempio, si rivolgono allo sportello di consulenze psicologiche del Naga, associazione che offre cure gratuite agli stranieri senza documenti. “Vengono da noi per sintomatologie ansiose, depressione, attacchi di panico e disturbi somatoformi, spesso concomitanti con altre patologie”, afferma Sara Spluga, psicoterapeuta che collabora con l’associazione come volontaria. “Queste donne soffrono per la separazione come se si trattasse di un lutto non elaborato e hanno una forte problematica di rabbia inespressa, un’emozione che non ti puoi permettere se sei donna, svantaggiata e magari senza documenti”. Il malessere psicologico è aggravato dalla forzata distanza dai figli. “Quanta più consapevolezza c’è di questo legame, tanto più lo si tiene in considerazione quotidianamente, avvertendo emozioni come senso di colpa e nostalgia”, continua Spluga. “Il fatto che quella di abbandonare la famiglia sia stata una scelta obbligata non lenisce la tristezza e la sensazione di essere sbagliate nell’averla compiuta. Del resto siamo fatti di legami e se questi sono stiracchiati per migliaia di chilometri, non possiamo pensare di stare bene”. Tra i casi che ha trattato il Naga con alcuni colloqui di sostegno, c’è anche quello del figlio di una badante, che, arrivato in Italia appena maggiorenne, si era ricongiunto con la madre dopo più di dieci anni. Poco tempo dopo, però, a lei era stata diagnosticata una malattia terminale. “Ci raccontò come la mamma rimpiangesse di non avere abbastanza tempo per recuperare tutto quello in cui era stata lontana da lui”, ricorda la psicoterapeuta.
“Alcune badanti si rendono conto di aver bisogno di aiuto già mentre sono in Italia. A Milano, ad esempio, si rivolgono allo sportello di consulenze psicologiche del Naga, associazione che offre cure gratuite agli stranieri senza documenti”.
Lottare contro l’invisibilità
Secondo i sindacati di settore, il disagio delle badanti dovrebbe essere combattuto partendo dalle condizioni in cui lavorano. Contributi mirati e misure di defiscalizzazione a favore delle famiglie che decidono di metterle in regola permetterebbero di sottrarle al lavoro nero e grigio e quindi di garantirgli diritti e tutele. Ancora più risolutive sarebbero poi politiche migratorie atte a favorire l’arrivo in Italia di interi nuclei familiari, piuttosto che di singoli individui completamente sradicati, anche agli affetti. L’alto numero di richieste che arrivano allo sportello del Naga dimostra inoltre come offrire assistenza psicologica gratuita possa essere a volte cruciale per evitare che i disturbi mentali lamentati dalle badanti si aggravino. Una delle donne che si era rivolta a questo servizio, una signora sudamericana che chiameremo Maria José, grazie a un lungo percorso di terapia è riuscita a ritrovarsi, superando ansia e depressione e vedendosi in modo diverso anche come madre. “Alla fine non era più solo la madre che aveva abbandonato la figlia quindicenne, ma anche quella che era riuscita a farla studiare, aveva mantenuto una relazione viva con lei e l’aveva incoraggiata a venirla a trovare a Milano”, dice Spluga. Per migliorare i rapporti all’interno delle famiglie transnazionali (cioè quelle in cui uno o entrambi i genitori e i figli si trovano in diverse parti del mondo) esistono anche progetti che puntano a rafforzare l’importanza e la qualità delle comunicazioni. “Purtroppo, molte madri non hanno altra scelta che partire, noi stiamo provando ad avviare un corso pilota a sostegno della loro genitorialità a distanza”, racconta Dumitrache di A.D.R.I.. “Nel frattempo la politica italiana rimane indifferente di fronte al loro dolore, nonostante sia noto e documentato”. Rispetto ad altri migranti, quella delle badanti è infatti una categoria particolarmente invisibile, proprio a causa delle caratteristiche del loro lavoro di accudimento, che le vede per la maggior parte del tempo tra le mura domestiche. “Queste donne non possono scendere in piazza per rivendicare i propri diritti, ma se un giorno scioperassero tutte, paralizzerebbero la vita del Paese, perché sono insostituibili”, continua Dumitrache. “Nonostante questo, non hanno alcun peso, anche perché, in quanto straniere, non votano; così continuano a essere sfruttate e trattate come cittadine di serie b, nel più totale disinteresse”. Ci si augura, allora, che per far cadere il velo di invisibilità che le avvolge, le nostre badanti ci costringano presto a guardarle.