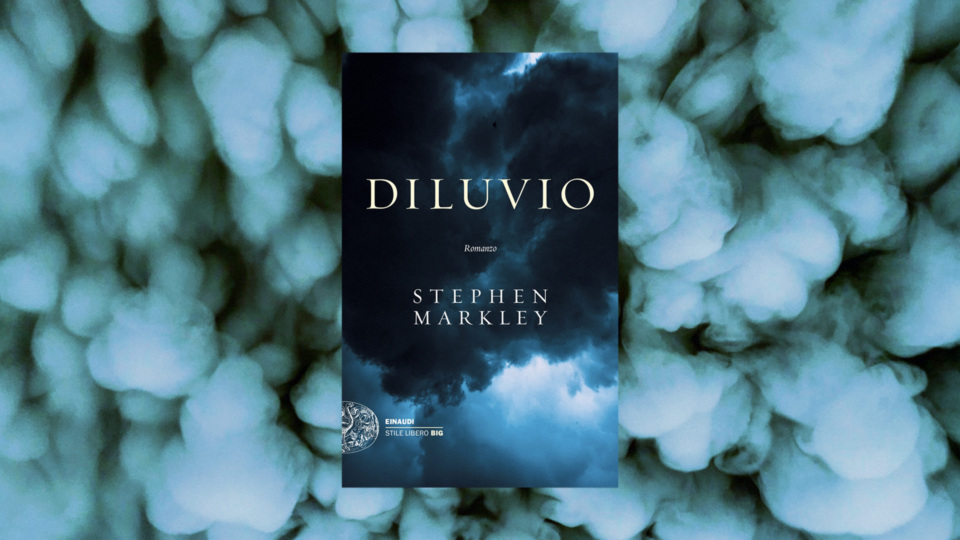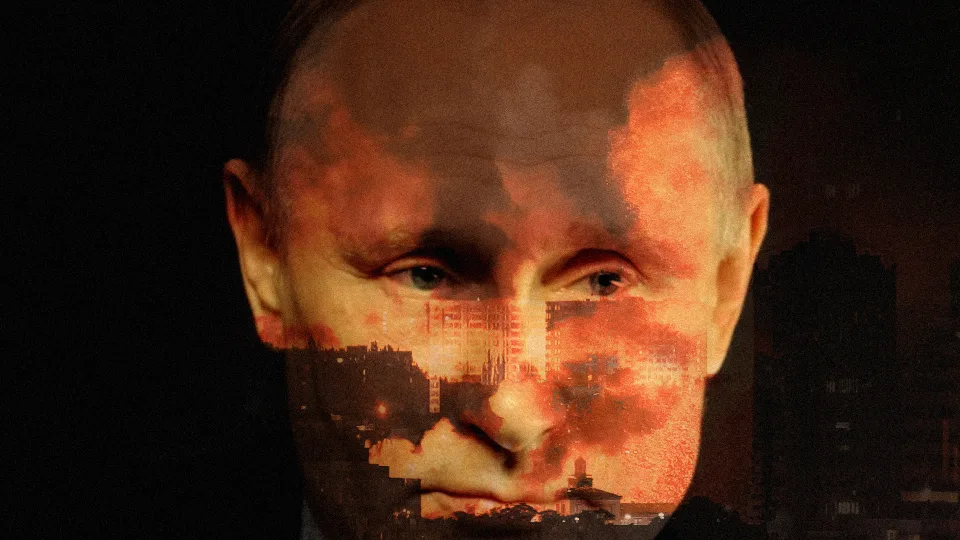Nel suo nuovo, ambizioso romanzo, lo scrittore americano non voleva fare altro che raccontare “ciò che tutti stiamo per vivere”. E in qualche caso, ha anticipato di pochissimo la Storia.
Ho comprato Diluvio di Stephen Markley a Siena, in una giornata troppo calda per essere di novembre. Ho continuato a leggerlo a Parigi, l’ho finito in Puglia, e dovunque mi trovassi mi sembrava che questo libro parlasse anche di me, dei posti in cui ero e del loro futuro. Nell’epoca della crisi climatica, del resto, al detto per cui tutto il mondo è paese bisogna forse aggiungerne un altro, contrario e complementare, per cui ogni paese è mondo, nel senso che gli stessi problemi si ripresentano (e ripresenteranno) dovunque, come effetti sfaccettati di una stessa causa. Finora non avevo mai letto un romanzo altrettanto pregnante sull’emergenza ambientale, che sapesse darmi così tante informazioni, anche tecniche, senza mai compromettere il piacere di una lettura vorace, e che avesse su di me un impatto emotivo e simbolico così forte. Rivolgendomi alla letteratura per riflettere sulla crisi climatica avevo bisogno di tragedia e di avventura, di realismo e di speranza: in Diluvio ho trovato tutte queste cose, e il godimento puramente estetico che ho provato nel leggerlo è pari soltanto alla tensione etica che continua a suscitarmi.
Pubblicato in Italia da Einaudi Stile Libero nel 2024, nella traduzione di Manuela Francescon e Cristiana Mennella, Diluvio è ambientato tra l’inizio degli anni Dieci e la fine degli anni Trenta, perlopiù negli Stati Uniti: comincia con Obama e Trump, con le proteste di Standing Rock del 2016, e finisce in un futuro non distopico ma più che probabile, tra eventi metereologici estremi che si stanno già verificando (Markley ha raccontato gli incendi di Los Angeles, ambientandoli però nel 2031) e una congerie di movimenti sociali e politici, battaglie diplomatiche, azioni terroristiche e mobilitazioni di massa nei quali possiamo sia riconoscerci che cercare un’ispirazione per il futuro. È un romanzo immediato ma non semplice. È immediata l’urgenza con cui risponde negativamente a una domanda fondamentale – “l’umanità è fottuta?” –, ma è complessa la finezza con cui poi racconta le strade da cui potrà derivare un cambiamento, tra vissuti umani e psicologici diversi e conflittuali e circostanze politiche tristemente note eppure sempre nuove.
Sarà strano rileggere Diluvio nei prossimi anni, e confrontare le sue pagine con la cronaca a venire. Intanto, in questa conversazione, ho chiesto a Stephen Markley qualcosa sul suo percorso e qualcosa sul suo futuro, qualcosa sul nostro tempo, qualcosa su Diluvio.
Sei laureato in scrittura creativa preso l’Iowa Writers’ Workshop. Quanto sono stati importanti per te questi studi?
Sono stati di vitale importanza. Sono entrato nel workshop quando avevo già qualche riconoscimento come scrittore, e certamente all’epoca avevo tanta energia e un talento naturale, ma avere quegli anni per concentrarmi su quasi nulla a parte la mia scrittura è stato molto importante. Dopo il college ero stato uno scrittore freelance e avevo cambiato molti lavori, sempre a basso salario. Ero esausto a livello mentale. All’Iowa Writers’ Worshop iniziarono a versarmi un piccolo stipendio per insegnare, e questo mi diede quel po’ di respiro di cui avevo bisogno. Ho anche incontrato un certo numero di insegnanti e colleghi incredibili, persone che mi hanno incoraggiato e reso migliore. È stata un’esperienza dal valore inestimabile: mentre ero lì ho scritto la prima stesura di Ohio (2018) e un terzo o forse metà di Diluvio.
Hai lavorato a Diluvio per molti anni, e Stephen King ha detto che si tratta di “un classico moderno”. Qual è stato il tuo metodo di composizione?
Ho iniziato nel 2010 e ci ho lavorato capitolo per capitolo fino a quando ho dovuto concentrarmi sugli sforzi necessari per pubblicare Ohio, che intanto era entrato in una tumultuosa fase di editing. Nel 2017, quando ho ripreso in mano Diluvio, molti dei terribili riferimenti reali a cui mi ispiravo nella prima stesura di questo libro erano già accaduti, così ho dovuto ripensare ogni cosa su una scala più grande. L’ultima stesura era lunga 1.500 pagine e l’ho finita nel marzo del 2020. Nei successivi tre anni l’ho modificata fino alla sua forma definitiva.

In un certo senso, più che inventare qualcosa, in Diluvio hai raccontato le “profezie” della scienza come fossero già accadute. Qual è il valore etico e civile di questa scelta narrativa?
La mia unica intenzione era descrivere ciò che tutti stiamo per vivere. Che ci si creda o no, che ci si presti o no attenzione, che la si abbia a cuore o meno, la crisi climatica è qui e cambierà tutto. Volevo che le persone sentissero questa cosa su un piano emotivo, così da dargli occasione di capire cosa c’è in gioco e, spero, fargli cambiare posizione rispetto a questo problema, farle diventare attive e appassionate e consapevoli. Uno desidera che il proprio romanzo apra le persone in due, e senza dubbio scrivere questo libro ha aperto me. Ma ciò che ho fatto è tutto qui: ho guardato a ciò che la scienza ci stava dicendo e ho scritto il futuro di conseguenza. Mi dà fastidio quando la gente descrive Diluvio come “distopico” o “apocalittico”. Questo è un romanzo realistico su ciò che vivremo, su ciò che in grandissima parte è già qui, e molto in anticipo sul programma.
Molti tuoi personaggi, anche i più umili e sprovveduti, sembrano scelti e raccontati in ragione della loro capacità di influenzare il destino del pianeta e della società su larghissima scala: l’esempio più lampante è quello di Kate Morris, giovane attivista per la giustizia climatica che riesce a mobilitare centinaia di migliaia di persone. Qual è, in Diluvio, il rapporto tra iniziativa privata e sorti collettive?
Per gran parte del romanzo Kate Morris non fa che fallire. Malgrado tutti i suoi sforzi, la sua passione e la sua energia non riescono mai davvero a fomentare il cambiamento di massa che desidera così fortemente. Sono semmai le fondamenta che ha gettato, insieme alla convergenza di altri fattori, che alla fine risultano fruttuosi (purtroppo è molto difficile parlarne senza spoilerare momenti importanti della trama, cosa che preferirei non fare). Questa credo sia una lezione importante, perché davanti alla crisi climatica ci sentiamo tutti impotenti, come se semplicemente non fosse possibile fare abbastanza, eppure ogni giorno, per tutto il giorno, ce ne facciamo carico sulle nostre spalle. Io so di farlo.
Il libro, comunque, si concentra su personaggi dotati di una forte determinazione. Personaggi che si mettono a testa bassa e si dicono che, nonostante le scarse probabilità di riuscita, devono continuare a combattere, continuare a lavorare, continuare a sognare, continuare a cambiare tattica, e mai tirarsi indietro, mai lasciar perdere, mai credere che sia troppo tardi per cambiare il mondo in modo radicale. Questo è l’atteggiamento che tutti dovremmo fare nostro, anche se sembra completamente ingenuo, ridicolo, folle, ecc. L’azione collettiva non ha alcuna possibilità di successo a meno che l’individuo non diventi parte del movimento collettivo, e questo oggi può accadere in molti modi, in così tanti e vari ambiti, molti dei quali non sono neanche mostrati nel libro.
I tuoi personaggi appartengono a classi sociali, etnie, generi sessuali e ambiti professionali molto diversi tra loro: le tue voci sono varie quanto è varia la società, e mi sembra che in quanto romanziere tu senta il bisogno di parlare anche dal punto di vista di gruppi sociali a cui non appartieni. Quanto è rischiosa questa operazione, e quanto è necessaria?
Nel tempo che mi ci è voluto per scrivere il libro mi sembra che questa tattica sia diventata molto più rischiosa. Oggi tanti autori scrivono con la grave paura di essere intrappolati dall’algoritmo sbagliato e affrontare un’ondata di rabbia, di critiche o come vogliamo chiamarle. Ripeto, ho iniziato a scrivere Diluvio nel 2010, e all’epoca gli estremismi delle politiche identitarie non erano ancora esplosi con tanta furia negli ambiti della letteratura, della cultura, della politica e dell’università. Quando ho iniziato a concepire il libro, invece, era il 2007, e allora il mio punto di vista (forse ingenuo, visto che ero poco più che un bambino) era che ogni opera sulla crisi climatica avrebbe dovuto avere quella varietà di voci, quel coro di umanità, perché alla fine le persone che dovranno affrontare questo problema sono proprio loro: tutti noi. Ci siamo dentro insieme. La gente sembra non apprezzare più questa idea, ma così contribuisce a mettere in pericolo l’umanità e la nostra casa condivisa. Sono d’accordo con molte delle critiche che vengono rivolte alla storia della nostra società ingiusta, estrattiva e razzista, ma questo concetto rimane vero. Ci siamo dentro tutti insieme, e nessuno di noi ha una sola possibilità se non all’interno di un movimento di massa sensibile alle ragioni della solidarietà e della comprensione. Quindi sono felice di essere rimasto ingenuo, e continuerò a esplorare la scrittura da punti di vista che sfidano la mia personale percezione del mondo.
La varietà dei tuoi personaggi fa sì che in Diluvio ci siano molte informazioni e gerghi tecnici legati a discipline non umanistiche (demografia, oceanografia, macroeconomia, nozioni sulle armi…). Quanto credi sia importante, per un romanziere contemporaneo, padroneggiare i linguaggi tecnici della scienza e inventare modi accattivanti per includerli nelle proprie storie?
Tutto dipende da che storia stai raccontando. Non voglio parlare a nome di nessun altro autore, è solo che lo trovo affascinante, e credo che una delle mie abilità fondamentali stia proprio nel restituire quella roba complessa e settoriale in una narrazione che può essere non solo interessante, ma addirittura elettrica. Uno dei capitoli che più mi è piaciuto scrivere – e magari si vede, dato che è lungo cinquanta pagine – è quello in cui Ash al-Hasan espone con semplicità ciò che è necessario fare davanti alla crisi climatica. Accompagnare il lettore passo dopo passo in questa spiegazione è stata forse una delle parti più interessanti nella scrittura del libro, e penso che molti lettori apprezzino quel tipo di acuta rappresentazione della politica e della scienza.
Diluvio ha l’urgenza e la solidità argomentativa di un pamphlet, eppure il suo linguaggio è estremamente letterario. Qual è il rapporto tra complessità della forma e urgenza del messaggio?
La complessità della forma proviene dai classici, dai romanzi epistolari, aggiornati però all’era dei social media e delle discussioni, argomentazioni e cacofonie onnipresenti. La voce di ciascun personaggio è leggermente diversa dalle altre, e questo pian piano allena il lettore a riconoscere il protagonista di ciascun capitolo lanciando un’occhiata alla prima frase. Visto che si tratta di un romanzo così lungo, poi, questa differenziazione delle voci dà al lettore una sorta di piccolo regalo all’inizio di ogni capitolo: “Con chi ci troviamo adesso?”, “Cosa avrà fatto questo personaggio in tutti questi anni?”, “Quando ci sarà il prossimo plot-twist?”. È tipo una botta di cocaina narrativa all’inizio di ogni capitolo. E sono convinto che alla fine del romanzo, nella quinta sezione intitolata La lunga strada verso casa, il lettore si sia ormai abituato a questa struttura, e penso anzi che smani per vedere cosa succederà dopo: nella lettura stessa viene a crearsi un senso di urgenza commisurato allo svolgimento degli eventi.
Diluvio mi sembra piuttosto vicino alla tradizione letteraria dell’Ottocento: c’è un’attenzione meticolosa verso la società nel suo insieme, una serietà non moralistica, una rinnovata fiducia nell’autosufficienza delle storie, generi commerciali trattati con rispetto, ecc. Leggendoti ho avuto la sensazione che per te un romanziere non possa più lasciarsi ingabbiare dalle paranoie novecentesche sul dominio dell’irrealtà, ma debba in qualche modo riguadagnarsi una lingua e un’immaginazione capaci di nominare il mondo storico e intersoggettivo.
Sono molto d’accordo, anche se non ho alcuna scommessa o interesse su ciò che è o non è popolare o alla moda, su quali sono le tendenze letterarie del presente. Quella era la storia che avevo in testa e che morivo dalla voglia di raccontare, e questo è come è venuta fuori. Ora, mi sono rifatto a classici come Guerra e pace? Senz’altro. Capisco anche che devo pur aver preso da qualche parte il gusto per una certa forma, ma, quando sono con un romanzo in mezzo alla guerra e le pallottole fischiano, non allungo mai il collo per dare un’occhiata a cosa stanno facendo gli altri autori contemporanei. Per me c’è solo il fuoco, solo l’urgenza della storia che ho per le mani, niente di più. E, per le stesse ragioni, non potrei mai dire a qualcuno di scrivere in un modo diverso da quello in cui scrive.
L’emergenza climatica riguarda tutto il pianeta e, come scrivi, può essere “il nostro annientamento o la nostra resurrezione”. Da lettore italiano ed europeo, tuttavia, c’è un aspetto del tuo libro che mi ha molto colpito: l’idea, riproposta da diversi personaggi, che gli Stati Uniti possano usare la propria potenza imperialistica (o ciò che ne resta) per costringere le altre nazioni a prendere le misure necessarie per far fronte al cambiamento climatico. Si tratta di una posizione molto distante, per esempio, da quella espressa da uno scrittore indiano come Amitav Ghosh, che in La grande cecità (2016) sostiene che l’imperialismo non può rimediare alle stesse ingiustizie che ha causato, e che la “resurrezione” passa anche dall’immaginazione di un nuovo cosmopolitismo. Qual è la tua posizione su questo argomento, e in che modo l’hai rappresentata in Diluvio?
Mi pare, anzitutto, che solo un personaggio pronunci precisamente quelle frasi, che comunque non vogliono essere intese come un’approvazione di quel concetto ma solo come l’espressione dell’opinione di quel personaggio (nelle mie intenzioni, per spingere il lettore a porsi quelle domande). Se dovessi riassumere ciò in cui crede quel personaggio, direi: ciò di cui abbiamo bisogno è una mobilitazione planetaria da tempo di guerra per de-carbonizzare l’economia e abbassare il più in fretta possibile il livello di CO2. Le modalità con cui questo programma sarà eseguito avranno un’importanza enorme per il futuro di ogni persona sul pianeta e dei nostri discendenti fino alla fine dei tempi. Credo che presto avremo a che fare con questi problemi, perché i costi della crisi climatica diventeranno troppo pesanti per l’attuale ordine mondiale. Quando quel tempo arriverà, le politiche che sarà necessario attuare danneggeranno molte industrie, da quella delle piantagioni di palma da olio in Indonesia all’allevamento del bestiame in Brasile, e queste politiche saranno denunciate come “imperialismo” da chi ha interessi economici in quei Paesi e dagli ordinamenti politici conniventi.
“Ho comprato ‘Diluvio’ di Stephen Markley a Siena, in una giornata troppo calda per essere di novembre. Ho continuato a leggerlo a Parigi, l’ho finito in Puglia, e dovunque mi trovassi mi sembrava che questo libro parlasse anche di me, dei posti in cui ero e del loro futuro”.
E gli Stati Uniti? L’Occidente?
Credo che gli Stati Uniti non possano dire agli altri Paesi come de-carbonizzarsi se essi stessi, intanto, falliscono in quello stesso obiettivo. Qualsiasi sforzo efficace per mitigare la crisi, alla fine, dovrà per forza includere perdite e danni per l’Occidente, e anche scambi tecnologici con il Sud globale. È l’unico modo per andare avanti. Dirò anche che, quando si fanno questi discorsi, talvolta si ignora la matematica pura e semplice, la quale dice che le emissioni del Nord globale hanno già raggiunto il picco, che quelle della Cina potrebbero presto raggiungerlo, e che è dunque il resto del mondo in via di sviluppo a dover assolutamente evitare i combustibili fossili affinché tutti noi possiamo almeno sperare che le cose vadano a buon fine. Quasi tutte le emissioni future proverranno dei paesi in via di sviluppo, e l’atmosfera non si preoccupa delle ingiustizie della Storia e della provenienza di una libbra di CO2. Nel libro, credo che il personaggio parli soprattutto del “collare shock”, che è fondamentalmente un prezzo globale del carbonio, perché ogni Paese che non includa il prezzo del carbonio nella sua economia ne soffrirà le conseguenze. Continuo a credere che questa sia una politica assolutamente imperativa, per varie ragioni, malgrado ci siano grandi ostacoli politici. Per esempio: quando l’Unione Europea ha annunciato che avrebbe imposto una tariffa di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM, Carbon Border Adjustement Mechanism), l’India non l’ha apprezzato, ma ha cambiato la linea di alcune sue politiche interne. Ora, c’è molto da fare nelle relazioni tra l’Europa e l’India, ma questo non significa che quella politica non fosse giusta. Lo è, e anche altri Paesi dovrebbero adottarla rapidamente.
Ciò che dici è estremamente attuale, e credo riguardi anche altri settori dell’economia.
Infatti. Vale anche per la questione dell’estrazione mineraria, in particolare dei minerali delle terre rare, e per la corsa all’esaurimento di queste risorse per le batterie e i pannelli solari. Non dovremmo ignorare, ovviamente, l’affermazione per cui intorno a queste risorse si creeranno relazioni neocoloniali, e la pressione andrebbe indirizzata verso le aziende e i governi affinché estraggano questi materiali in modi etici, dei quali possano beneficiare gli esseri umani reali nei Paesi che posseggono quelle risorse. Sono però convinto che la retorica intorno a questo problema, per moltissimi aspetti, faccia il gioco di chi ha interessi nei combustibili fossili e attualmente è responsabile di tutto lo sfruttamento estrattivo, mentre il peso minerario dei combustibili fossili rispetto a quello di tutti questi minerali è quello di un elefante rispetto a una formica. La brutalità con cui agisce l’industria dei combustibili fossili, dall’Ecuador alla Nigeria, dalle sabbie bituminose del Canada ai giacimenti petroliferi di Baku, non può essere sopravvalutata.
C’è un’alternativa?
L’elettrificazione e le energie rinnovabili possono offrire enormi benefici ai Paesi con reti elettriche insufficienti e un cattivo accesso all’energia. Guarda cosa sta succedendo in Pakistan, dove un boom nel mercato dei pannelli solari minaccia i principali produttori di energia a combustibili fossili e consegna i risultati alle persone sul campo. Questo è il potenziale della rivoluzione delle energie pulite, e ogni politica che ne ritarda l’attuazione è una mini-tragedia.
Dopo aver scritto della crisi climatica, di cosa senti ancora il bisogno di parlare?
Oh, c’è moltissimo di cui parlare. A un certo punto potrei anche scrivere, che ne so, un romanzo sul basket. Anche se questa potrebbe essere la più grande crisi mai affrontata dall’umanità, penso che sarebbe controproducente comportarsi come se si volesse sgridare chiunque non sta affrontando il problema. Gli artisti e gli scrittori si concentrano su ciò che li preoccupa, e quasi tutte le preoccupazioni possono avere valore, soprattutto nelle mani di un individuo o di un collettivo talentuoso. La mia unica preoccupazione è sempre stata che l’arte, la letteratura e il cinema stessero ignorando largamente la crisi climatica, mentre questa intanto si stava metastatizzando. Oggi non penso che sia ancora così, anche se la portata e le dimensioni di ciò che sta accadendo sono difficili da restituire. Sto scrivendo queste frasi proprio in seguito agli incendi di Los Angeles, con gli equipaggi che ancora cercano di combattere le fiamme, e tutto quello a cui posso pensare è che, nonostante la devastazione praticamente impensabile (anch’io sto faticando a concepirla), ciò che è successo è quasi niente rispetto a ciò che arriverà. Questi incendi, nel tempo delle nostre vite, saranno una nota a piè di pagina rispetto a ciò che dovremo affrontare.