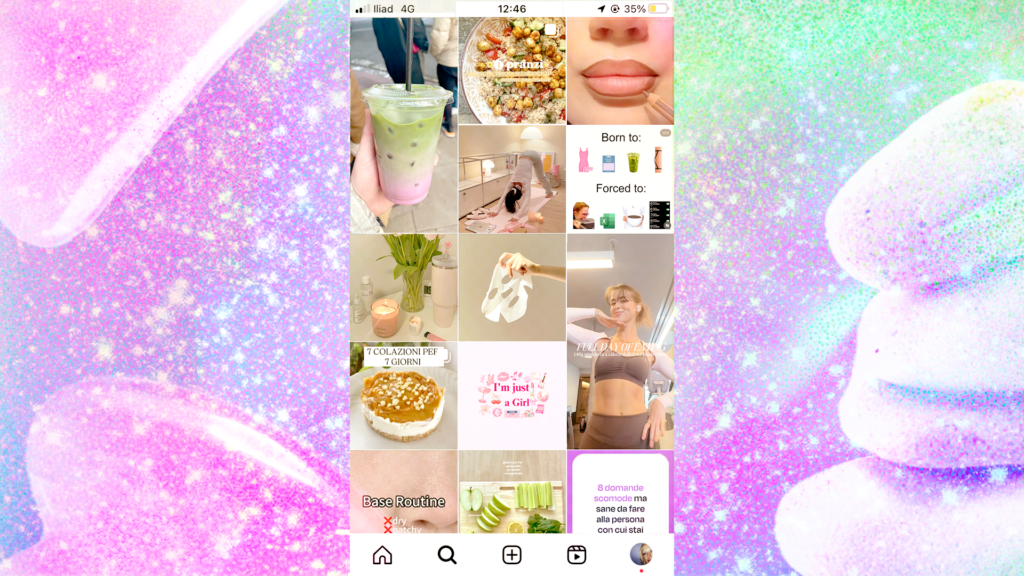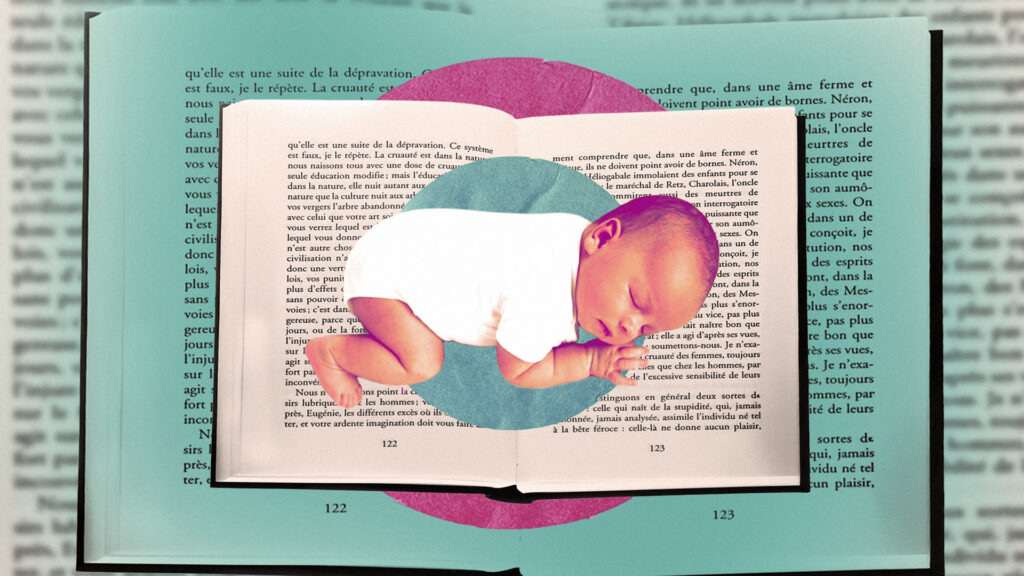Irene Graziosi
Dimmi la verità: perché siamo ossessionati dall’autofiction?

Il successo di questo genere letterario ci interroga sulla natura del romanzo e, soprattutto, sulla nostra natura di lettori.
Irene Graziosi
Irene Graziosi è scrittrice. Il suo ultimo romanzo è Il profilo dell’altra (Edizioni E/O, 2022).
newsletter
Le vite degli altri
Le vite degli altri è una newsletter che racconta di vite che non sono la nostra: vite straordinarie, bizzarre o comunque interessanti.
La scriviamo noi della redazione di Lucy e arriva nella tua mail la domenica, prima di pranzo o dopo il secondo caffè – dipende dalle tue abitudini.
Contenuti correlati