Il girl group britannico che ha resistito al crollo dell’industria discografica, all’assalto dei talent show, alla tirannia di social network e algoritmi, torna oggi in concerto con la sua formazione originale al Fabrique di Milano
Le Sugababes escono con il loro singolo di debutto, Overload, l’11 settembre del 2000. I dodici mesi che portano al catastrofico 11 settembre dell’anno successivo sono stati caotici non solo per loro (lo vedremo) ma anche per la discografia in generale.
Il pop uscito in quell’anno sembra danzare sull’orlo dell’abisso: la musica digitale è già ovunque ma i discografici, ancora ubriacati dalle speculazioni degli anni ottanta e novanta, fanno finta di non accorgersene. Napster e Kazaa, le due principali piattaforme peer to peer per scaricare (illegalmente) musica in formato mp3, diventano sempre più popolari e la Apple, il primo gennaio del 2001, lancia il suo media player iTunes per poi uscire a novembre con il primo iPod.
Nella discografia ci sono ancora molti soldi che vengono investiti nello sviluppo di produzioni pop innovative e dal sapore coraggiosamente underground: Music, scritta e prodotta dal dj franco-marocchino Mirwais Ahmadzaï, esce nell’agosto del 2000 e rilancia Madonna, che allora ha già vent’anni di carriera, come popstar contemporanea e ancora rilevante. Il suo ex produttore, il musicista elettronico William Orbit, regala al girl group britannico All Saints uno dei pezzi pop più futuribili e coinvolgenti di quell’anno, Pure shores. Il rapper e produttore Timbaland produce per la giovane cantante Aalyiah, Try again, che esce nel marzo del 2000. È un classico brano rnb nella linea vocale e nelle armonizzazioni che però a ben guardare incorpora molti elementi di elettronica e dance. Il ritornello, in particolare, è campionato, manipolato e ripetuto ipnoticamente in loop. Una soluzione radicale che una star di quegli anni, una Whitney Houston o una Toni Braxton, non avrebbe mai accettato. Timabaland e Aalyiah invece osano e saldano l’hip hop più innovativo con l’elettronica e la pop dance.
Il 2001 è poi l’anno di due makover che hanno fatto scuola: con I’m a Slave 4 U (una produzione di Pharrell Williams con più di un prestito da Prince) Britney Spears si trasforma da Lolitacon tanto d’ uniforme scolastica in moderna diva pop-porno e Pink, con l’aiuto della cantautrice Linda Perry, abbandona un rnb che non la portava da nessuna parte per un powerpop caciarone e vagamente femminista. Il pop internazionale dei dodici mesi a cavallo tra 2000 e 2001 è vitale, innovativo e ancora generosamente annaffiato di denaro: la discografia balla sul ponte di un Titanic che sta per affondare ma lo fa con una pop music croccante e ottimista che guarda con fiducia a un futuro di nuove, fichissime tecnologie, di pace e di prosperità. Niente di più falso: il punto di fuga di quei dodici mesi è riassunto in un’immagine dell’11 settembre del 2001: un enorme billboard che reclamizza Glitter, nuovo film e nuovo album della superstar Mariah Carey, si staglia davanti alle torri gemelle in fiamme. Insieme al World Trade Center si sbriciola anche la carriera di Carey. Glitter (la cui disgraziata data di uscita era stata fissata proprio per l’11 settembre) viene massacrato dalla critica e ignorato dal pubblico. Il 25 agosto, appena una manciata di giorni prima, Aalyiah era morta in un incidente aereo.
In questo lasso di tempo, a Londra, tre ragazzine di nome Siobhán Donaghy, Mutya Buena e Keisha Buchanan danno vita al girl group di “manufactured pop” – ovvero di pop progettato a tavolino – più imprevedibile, spigoloso, ruvido e geniale di sempre: le Sugababes.
Il termine manufactured pop è spesso usato in modo dispregiativo per indicare una musica fatta da artisti di scarso talento pilotati da produttori di mezza età pelati e senza scrupoli, canzoni senz’anima pensate per le classifiche o per poster e gadget che saranno dimenticati nel giro di una stagione. Il fenomeno Spice Girls che durò all’incirca dal 1996 al 2000, con il suo fall-out di carriere soliste più o meno durature, non aveva precedenti soprattutto in ragione della sua scala globale. Tutto il pop (inglese e non solo) degli anni a cavallo tra il 2000 e il 2001 è un tentativo di ripetere quella formula, formula in cui la personalità è tutto e il talento e il suono sono variabili volatili. Produttori, autori e manager cercano personaggi (possibilmente molto giovani e pronti a essere trattati come vuoti a perdere) più che artisti, La cultura dei reality e dei talent show che sarebbe diventata egemone di lì a poco, del resto, non avrebbe fatto che ulteriormente rafforzare questa tendenza.
Le Sugababes sono nate a fine anni novanta in un’ ecosistema in fibrillazione, dunque. Schiacciate tra l’industria del pop inglese e un underground brulicante e vitale fatto di jungle, dub e 2 step. Mutya Buena, londinese di origini filippine, è compagna di classe di Siobhán Donaghy, rossa di capelli e irlandese: entrambe ad appena 13 anni firmano un contratto con Ron Tom, il manager delle All Saints che dopo aver provato a farne due artiste soliste comincia a farle cantare insieme. Un giorno viene a trovarle alle prove un’altra amica, Keisha Buchanan (londinese di origine giamaicana) e il trio viene formato. Appunto a tavolino. La variabile impazzita nella formula delle Sugababes è Cameron McVey, marito e produttore di Neneh Cherry e già collaboratore dei Massive Attack. McVey capisce che le Sugababes hanno una loro acerba autenticità e che non vanno trattate come un normale prodotto pop. L’esperienza precedente delle All Saints gli aveva insegnato che le componenti di un girl group potevano, anzi dovevano, essere in qualche modo autrici dei loro pezzi. “Io non sono una ragazzina”, spiega, citato in Reach for the stars, un libro di Michael Cragg dedicato al pop dei primi anni 2000, “non posso neanche provare a scrivere una canzone dal punto di vista di una quattordicenne di oggi”. Quindi decide di dare alle tre ragazze delle cassette con delle tracce e di scriverci sopra dei testi, anche solo idee abbozzate, parole sparse. Siobhán ricorda che quella notte non dormì per l’agitazione: va bene cantare, provare con le altre e trovare il tempo per andare a scuola ma ora anche scrivere? E proprio Siobhán arriva con il testo di Overload, la loro prima hit.
“l termine ‘manufactured pop’ è spesso usato in modo dispregiativo per indicare una musica fatta da artisti di scarso talento pilotati da produttori di mezza età pelati e senza scrupoli, canzoni senz’anima pensate per le classifiche o per poster e gadget che saranno dimenticati nel giro di una stagione”.
Overload ha una qualità sfuggente che il manufactured pop di rado riesce ad avere: è cool. E lo è in modo distaccato e non calcolato, Overload non sgomita per farsi notare, ha qualcosa di indolente ma irresistibile. Quando viene prodotta in studio tutto è avvolto in una fitta nebbia da fumo di ganja (lo ricordano sia le Sugababes sia i produttori nel libro di Cragg) e l’atmosfera è decisamente rilassata. McVey è il cervello musicale dell’operazione, ma accanto a lui c’è Jony Rockstar (in futuro collaboratore di Amy Winehouse): è lui che smonta e rimonta le basi. In studio nessuno canta o suona isolato in una cabina, tutto avviene nella stessa stanza e Mutya ricorda che, essendo ancora il 1999, il processo non è completamente digitale: c’erano i nastri e le lamette per tagliarli. “In Overload, quando arrivi al middle-eight”, dice Cameron McVie, “si sente una specie di tonfo: c’era stato un calo di corrente, quindi anche nel mix finale si sente quel vuoto e io che velocemente rimetto in moto tutto”. Sembra un dettaglio ma è un piccolo glitch che sporca ad arte il suono di un girl group che, pur essendo creato a tavolino, conserva qualcosa di ruvido e working class. L’accento delle ragazze non è certo quello un po’ artefatto di Posh spice e il loro mix etnico riflette la diversità delle case popolari e dei club di Londra. Le Sugababes sono più personaggi da Irvine Welsh che modelle da United Colors of Benetton.
Quando arriva il momento di portare Overload alla storica trasmissione tv Top of the pops le Sugababes, come si dice in gergo, “servono”. Immobili sui loro sgabelli, cantano come in trance, come controvoglia, e basano tutto su un misterioso gioco di sguardi. La verità, si è saputo dopo, è che erano pietrificate dal terrore: i loro manager hanno capito che la cosa migliore era tenerle immobili su quegli sgabelli.
Le Sugababes tengono gli occhi bassi, se li alzano per incrociare lo sguardo di un adulto lo fanno per sfidarlo. Soprattutto non sono lì per divertirsi e tantomeno per divertire gli altri: sono lì e basta. Sono lì perché sono speciali, sono delle star e con i loro sguardi di sbieco sembrano dire a chi le guarda alla tv: potrebbe succedere anche a te ma non succederà. Ogni loro minimo movimento è salutato da un applauso del pubblico e quando parte un assolo di chitarra le tre finalmente scendono dai loro sgabelli e accennano una minimale, quasi demenziale coreografia.
Ma le Sugababes hanno un’altra qualità squisitamente musicale: le loro voci sono diverse (un contralto sporco Mutya, vocalmente la più interessante del trio, un solido mezzosoprano Keisha e un soprano leggero Siobhán) armonizzano perfettamente. La loro scuola sono le All Saints (ovviamente) e tutto l’rnb americano (da Brandy e Monica alle Destiny’s Child). Essendo state coinvolte nel processo creativo fin dall’inizio le Sugababes hanno la capacità di coalizzarsi contro ai produttori se propongono loro qualcosa di troppo cringe. Da vere teenager sanno cosa è cool e cosa non lo è: il 2 step che sentono nei club che frequentano di nascosto dopo le prove è cool, il pop da classifica non lo è. L’unica ad avere una certa apertura verso il pop è Keisha che ammette di adorare gli A1 e i 5ive. Mutya in particolare è una purista: solo rap, rnb e 2 step. Le dinamiche tra loro sono autentiche e proprio per questo presto la situazione diventa esplosiva.
One touch, il loro album di debutto, esce il 27 novembre del 2000 e contiene almeno un altro singolo epocale che purtroppo viene ignorato dalle classifiche: Run for cover. Su una base jungle con archi e tastieroni che ricordano certe produzioni dance degli Everything but the girl, le Sugababes danno voce al teen drama più paranoico e oscuro che sia mai stato messo in musica pop dai tempi di Leader of the pack delle Shangri-Las (1965). Quando si è adolescenti tutto è dramma e tutto è caos: soprattutto l’amore. l’unica risposta possibile sembra quella di isolarsi in un ermetico mutismo: “tendo a tagliarmi fuori dalle cose da cui so che non dovrei scappare” canta Mutya nel primo verso. Run for cover è una canzone sull’isolamento, sull’insicurezza, sulle aspettative e su quelle ferite interiori chegli adulti sono incapaci di vedere. Non è certo una canzone consolatoria ma ha un’urgenza che manca a tanto pop autofictional e vittimista di oggi.
One touch non vende abbastanza e l’etichetta, la London Records, nel 2001 minaccia di staccare la spina al progetto. Le Sugababes sono appena maggiorenni e impegnate in un calendario promozionale senza sosta. Reach for the stars di Michael Cragg racconta nel dettaglio come quasi tutte le storie del manufactured pop di quegli anni finissero con un burnout, con una dipendenza o con una gravidanza indesiderata. A volte tutte e tre le cose insieme. Quando le Sugababes sono pronte per partire per un tour promozionale in Giappone, Siobhán non si presenta all’aeroporto e di fatto lascia la band. Di lì a poco l’etichetta non rinnova il loro contratto per un secondo album. La storia viene raccontata alla stampa in maniera confusa: si parla di bullismo da parte di Keisha e Mutya contro Siobhán (una lettura vagamente razzista), di continui battibecchi, zuffe e gelosie tra ragazze (una lettura vagamente misogina) e di incapacità del management di tenere insieme quelle tre scalmanate (una lettura vagamente paternalistica).
La verità come al solito sta nel mezzo: le Sugababes lavoravano ininterrottamente da quando avevano 13 anni e sono arrivate a un umanissimo punto di rottura, ma è in quel momento che si crea la leggenda da tabloid delle Sugababes raccontate sempre come delle divette tamarre, capricciose e ingestibili. Una narrazione che a misoginia, razzismo e paternalismo aggiunge anche quel pizzico di classismo che tanto piace agli inglesi.
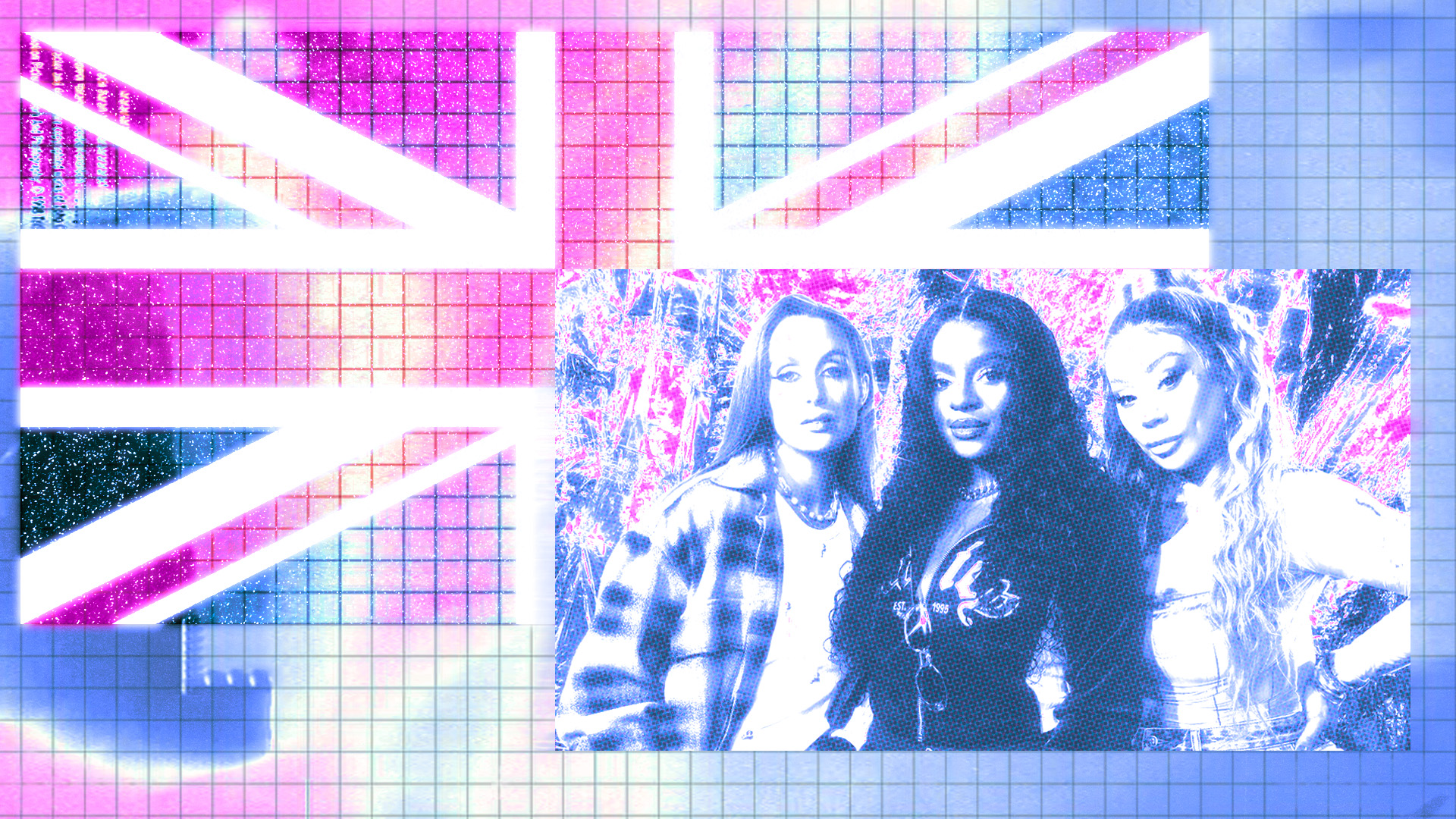
Foto di Jess Hand.
I manager cercano di salvare il salvabile e trovano un rimpiazzo per Siobhán: la bionda Heidi Range che sembra uscita dalla pubblicità di uno sciampo ma che appena apre la bocca svela la sua provenienza: Liverpool. Heidi era brevemente transitata per un altro girl group di successo, le Atomic Kitten, sa cantare e armonizza a meraviglia con Mutya e Keisha. Sembra più grande e più posata delle compagne ma non importa. A quel punto però avviene il miracolo, quel glitch che salva le Sugababes dall’estinzione e le trasforma in un girl group di vero successo. Quel miracolo, ancora una volta, lo fanno i produttori che scovano il mashup tra un vecchio pezzo house (Freak like me di Adina Howard) e Are Friends Electric?, un pezzo synth pop di Gary Numan del 1979. Il responsabile di quell’ibrido tra house e new wave era l’allora sconosciuto Richard X che era noto nei club per I wanna dance with numbers, un suo mix che univa a I wanna dance with somebody (who loves me) di Whitney Houston a Numbers dei Kraftwerk. Di lì a poco Richard X avrebbe collaborato con Kelis, Goldfrapp e Pet Shop Boys ma le Sugababes sono state la sua prima sortita nel mondo pop. Il mashup, una pratica pirata e vagamente punk, è entrata definitivamente nel mainstream ai Brit Awards del 2001 quando Kylie Minogue si esibì con la sua hit Can’t get you out of my head montata sopra la bassline inconfondibile di Blue Monday dei New Order. Le Sugababes però ci erano arrivate prima.
Come tutte le operazioni di mashup Freak like me era un bootleg che veniva suonato esclusivamente nei club e c’erano una serie di campionamenti da sbloccare. Le Sugababes buttano giù in fretta le loro armonie vocali (ormai sono delle veterane) e incidono il pezzo direttamente a casa di Richard X che le accompagna con una vecchia tastiera Casio scassata. Nel frattempo un’altra etichetta s’interessa a loro e il secondo album delle Sugababes, Angels with dirty faces, esce nel 2002 per la Island e tra i produttori, oltre a Richard X, compaiono Xenomania e Bloodshy & Avant. I primi avrebbero poi lavorato con Cher, Kylie Minogue e i Pet Shop Boys, i secondi avrebbero prodotto qualche anno dopo uno dei singoli pop più innovativi del nuovo millennio: Toxic di Britney Spears. Le Sugababes, anche in questo caso, ci erano arrivate prima.
Nonostante due singoli al numero uno (Freak like me e Round Round) e uno al numero sette (Stronger), la vita continua a essere incasinata per le Sugababes. La prossima a lasciare il gruppo è Mutya e anche lei lo fa in un momento delicato: la promozione del loro quarto album Taller in more ways. Anche Mutya viene sostituita al volo: a prendere il suo posto c’è la anglo-marocchina Amelle Berrabah che rincide la parte vocale di un paio di singoli. Da quel momento in poi tutto quello che c’era di originale nelle Sugababes scompare e quell’equilibrio delicatissimo tra manufactured e cool crolla. Anche se le hit rimangono: Push the button (con ancora la voce di Mutya) finisce al numero uno in Gran Bretagna, Nuova Zelanda, Austria e Irlanda. Con Mutya Buena, che nel frattempo ha avuto un figlio e soffre di depressione post parto e burnout.
Le Sugababes intanto perdono la loro anima musical: da band si trasformano in brand. Mutya viene incolpata di ogni nefandezza da fan e stampa: la newsletter Popbitch (una fonte preziosa di gossip musicali dei primi anni 2000 gestita da insiders all’epoca anonimi) è arrivata a creare il tormentone (i meme non esistevano ancora) “Blame it on Mutya”, in cui la Sugababe traditrice veniva incolpata di qualsiasi catastrofe: dalle stragi di Pol Pot a terremoti e Tsunami.
I media musicali parlano ancora una volta di gelosie e di ripicche ma a questo punto anche il management delle Sugabaes aderisce a quel racconto: nel 2008 il loro poco ispirato sesto album viene intitolato Catfights and Spotlights, ovvero “zuffe e riflettori”. Quando, nel 2009, anche Keisha Buchanan viene costretta a lasciare, delle Sugababes resta solo il nome, il brand appunto: il loro settimo e ultimo album, Sweet 7, esce per l’etichetta di Jay-Z, la Roc Nation, e non piace a nessuno. Nessuno si accorge neanche dell’ennesima sostituta: Jade Ewen, un’onestissima ma anonima professionista che nel 2009 aveva rappresentato il Regno Unito all’Eurovision Song Contest.
Le Sugababes che vedremo oggi (2 maggio) al Fabrique di Milano sono il frutto di una faticosa rappacificazione tra le componenti originali che, ormai quarantenni, hanno capito di essere state sfruttate dall’industria in ogni modo ma soprattutto sono il risultato di una lunga (e penosa) battaglia legale per riprendersi il loro nome. Già nel 2011 Mutya, Keisha e Siobhán si riuniscono usando i loro nomi propri ma il loro ritorno sulle scene è costellato di incidenti, fake news, false partenze. Solo nel 2019 le tre artiste riescono a sbloccare i diritti per poter tornare a usare il nome Sugababes: nel 2022 esce – solo in streaming – The Lost tapes il loro “album perduto” del 2013, un lavoro che ha fatto capire quanto la formula funzionasse se a cantare c’erano loro, le ‘babes originali.
I due singoli più recenti Jungle e Weeds (entrambi prodotti da Jon Shave già collaboratore di Charli XCX, Iggy Azalea e Miley Cyrus) mordono poco ma cercano, non sempre riuscendoci, quell’impalpabile equilibrio tra mainstream e underground che aveva fatto delle Sugababes il girl group più interessante di sempre. E se pensate che le Sugababes riformate siano solo un guilty pleasure per nostalgici del girl pop dei primi anni duemila guardate come sono state accolte l’anno scorso dalla folla del Boiler Room London: quarantenni, sudate e scarmigliate si sono esibite al centro del dance floor circondate da una folla di quello che è sempre stato il vero pubblico che fin da ragazzine hanno cercato: la gente dei club. Un pubblico che, alla fine, ha resistito al crollo dell’industria discografica, all’esplosione insensata dei prezzi dei live e alla tirannia degli algoritmi.
La cover dell’articolo è la rielaborazione di uno scatto di Dave Snapper Willis.






