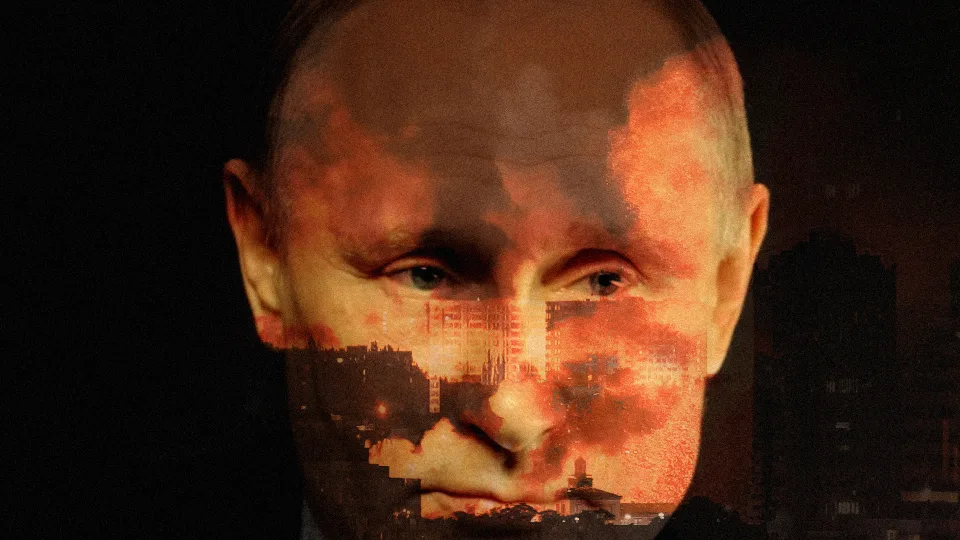Ambientato in un villaggio scozzese del tardo medioevo, il film di Tsangari è una folle sbornia apocalittica che riflette sulla modernità e sulla scomparsa di un mondo.
Harvest, in concorso a Venezia81, è il quarto lungometraggio della regista greca Athina Rachel Tsangari. Racconta la decomposizione sociale di un villaggio rurale agitato da spiriti pagani, nel tardo medioevo. È un film atipico, una folle sbornia apocalittica. Ed è un gioiello. Un film inaspettato, viscerale, allucinato, geniale.
Durante la prima proiezione per gli accreditati si è sollevato un applauso tiepidissimo.
Durante la seconda proiezione per gli accreditati, metà della sala si è svuotata molto prima della fine.
Siamo in Scozia, da qualche parte. L’insignificante villaggio rurale di cui seguiamo le sorti è lontano tre giorni di cavallo da qualsiasi altro insediamento. E sta per essere cancellato dalla Storia. È solo questione di giorni prima che quei campi vengano recintati: vivere solo per campare non ha più senso, bisogna abbandonare l’agricoltura di sussistenza per il pascolo, per la redditizia produzione di lana, per la modernità. Gli abitanti verranno espropriati e sfollati. Nessuno ricorderà le loro vite lerce, le danze e i riti pagani, la comunione morbosa con la natura, le gioie, le invidie, le morti premature, il fango nei capelli e sotto le unghie, le ubriacature e le intossicazioni psichedeliche. È l’apocalisse, la fine di un mondo. Ma di chi è la colpa?
Non di Master Kent, proprietario di quelle terre e padroncino del villaggio, un leader senza polso che ha amministrato la propria comunità con un fatalismo arrendevole, senza mai guadagnarsi il rispetto dei sudditi. Quando dalla città arriverà suo cugino Edmund Jordan a reclamare le terre per poterle convertire al pascolo, Master Kent non potrà far altro che concedergliele. Gli spettano di diritto, per questioni di eredità.
Non è colpa neanche del cartografo Quill, gentiluomo di cultura, dal forte accento nigeriano, appassionato di botanica e di storia naturale, che giunge al villaggio per disegnare le prime mappe di quei territori. Certo le mappe che spennella su pelli e pergamene gli sono state commissionate proprio da Jordan, e serviranno a costruire gli steccati, a modificare i terreni, a estrarre valore dalla campagna dopo aver fatto piazza pulita degli abitanti del villaggio. Dare un nome alle cose è il primo passo per poterle annientare. Ma in fondo, si dice Quill, disegnare la mappa è solo un lavoro come un altro, ed è un lavoro artistico persino. Inutile pensare troppo alle conseguenze che può avere.
L’apocalisse del villaggio non dipende neanche dallo spirito dei suoi abitanti, che davanti alle minacce si dimostrano troppo spesso mansueti, proprio come le pecore che prenderanno il loro posto. Ci sono poteri più grandi che decidono delle loro vite, non possono farci granché.
La colpa non è dei tre briganti che proprio in quei giorni tentano l’assalto al villaggio. Vengono anche loro dalle macerie di un borghetto che ha subito la stessa sorte che spetta a questo. Sono contadini che non hanno più nulla. Gli rimane solo di vivere di espedienti.
Non è neanche colpa di Jordan, il nuovo odioso padrone. È arrogante, è violento, ma a ben guardare fa quel che deve, è agito dal buon senso della modernità. Vuole trasformare questo “villaggio dell’abbastanza” in un “insediamento dell’abbondanza”, perché “non c’è profitto in un albero che produce solo ombra”.
Non è colpa di Walter, infine, giovane vedovo, amico di infanzia di Kent quando erano in città, diventato poi suo servitore in campagna. Walter più di tutti comprende il pericolo a cui il villaggio sta andando incontro, ma non riesce o non vuole agire, divorato com’è dalla propria crisi esistenziale.
La colpa non è di nessuno. È la Storia umana che va avanti così, per inciampi, per strappi e sopraffazioni, cancellando qualcosa in nome di altro. Il più delle volte lo chiamiamo progresso.
“Il film è stato girato su pellicola, e la qualità grezza della fotografia esalta la terra e la sporcizia, i colori caldi, i tramonti violenti, il sangue delle bestie e degli uomini essiccato sui vestiti e sulle porte”.
Athina Rachel Tsangari gira, in media, un lungometraggio ogni otto anni (ma nel frattempo fa anche altro: corti, teatro, televisione). Non è una regista accomodante con il proprio pubblico e, come Harvest, anche i suoi film precedenti sono idiosincratici, liberi, difficili da definire.
L’esordio è il suo lavoro più sperimentale, The Slow Business of Going, del 2000, una sorta di road movie di fantascienza lo-fi, un patchwork di episodi sconnessi: una donna nomade, un cyborg gira il mondo per raccogliere memorie e immagini tramite delle speciali lenti oculari che poi invia a un grande archivio dati digitale.
Nel 2010 arriva Attenberg con cui a Venezia la protagonista Ariane Labed vince la Coppa Volpi. Interpreta Marina, una ventenne goffa, stravagante, estranea alla sessualità e al corpo. La sua unica passione sono i documentari naturalistici di Sir David Attenborough, di cui storpia il nome (da qui il titolo). Attenberg è un film strampalato, provocatorio, eccentrico. Ricorda i primi lavori del connazionale Yorgos Lanthimos, che infatti qui è produttore, oltre che attore, nel ruolo dell’uomo di cui Marina alla fine si invaghirà.
Chevalier è del 2015. Alienante quanto gli altri due, ma meno coraggioso. Sei amici in vacanza per qualche giorno su uno yacht di lusso. Decidono di fare un gioco: nei giorni che rimangono, prima del ritorno ad Atene, si sorveglieranno l’un l’altro, giudicandosi, attribuendosi un punteggio per ogni cosa: il colore delle mutande, il vigore dell’erezione mattutina, la bontà delle analisi del sangue, la velocità con cui, sullo yacht, riescono a montare un mobiletto ikea. Un massacro fisico e psicologico che ricorda molto La grande abbuffata, ma che rimane gelido, fine a sé stesso, non riesce a essere la satira dissennata che era stato il film di Marco Ferreri quarant’anni prima. Presentato in anteprima a Locarno riuscì comunque a collezionare un po’ di premi.
Tsangari sembra incline a girare film che a molti non piacciono, ma che piacciono molto a quelli a cui piacciono. Harvest, probabilmente, non farà eccezione. Guardando le recensioni che stanno uscendo in queste ore (che a occhio sembrano meno di quelle degli altri film in concorso proiettati finora) possiamo già contare una stella su cinque data dal «Guardian» e una recensione entusiastica del «Telegraph».
Il libro di Jim Crace da cui Harvest è tratto (in Italia Il raccolto, uscito per Guanda nel 2016) poggiava su una scrittura lirica. Athina Rachel Tsangari per la sua versione ha scelto un approccio più punk. Il film è stato girato su pellicola, e la qualità grezza della fotografia di Sean Price-Williams esalta la terra e la sporcizia, i colori caldi, i tramonti violenti, il sangue delle bestie e degli uomini essiccato sui vestiti e sulle porte.
Harvest è il film più cupo di Tsangari. Non è però un film desolato. È illuminato anzi da momenti lieti, e sono quelli più evocativi: le cerimonie del villaggio, la festa del raccolto, le notti in cui gli abitanti indossano maschere animali e si danno a orgiastici baccanali. Harvest è un film psichedelico. Walter è un consumatore di funghi allucinogeni. Lui li chiama “chiodini fatati”. Crescono liberi nella brughiera, tra le olmarie, i denti di leone e i giunchi. Walter è attraversato da visioni demoniache durante i suoi bad trip, ma sembra cogliere anche il dono estatico di queste molecole, la loro benevolenza cosmica che si manifesta in un legame mistico con la natura. Forse i chiodini fatati lo aiutano a processare il lutto dell’apocalisse. Walter non si muoverà, quando gli altri verranno cacciati via. Rimarrà lì, in quel posto ancora senza nome, unico testimone di un mondo sconfitto.
Leggi tutti gli articoli di Lucy dalla 81ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia