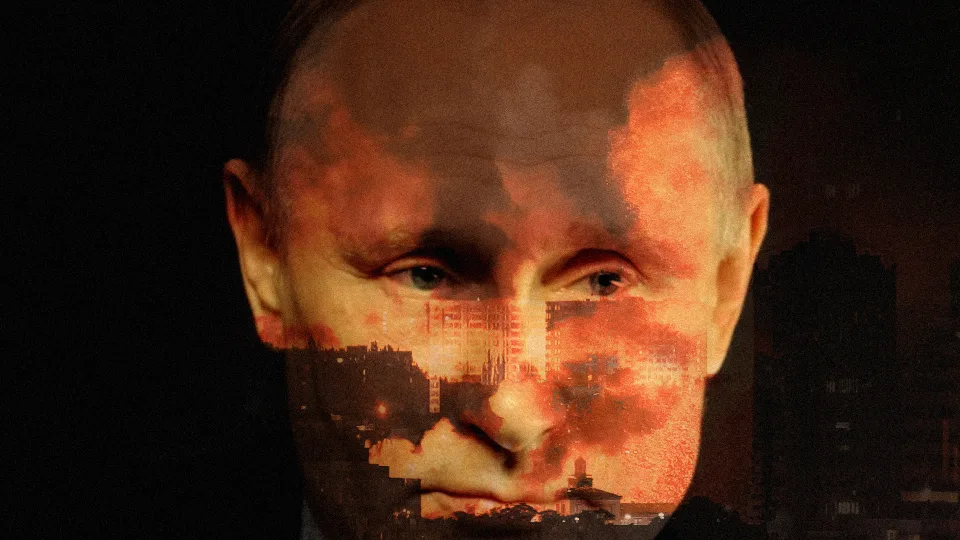Avversati dal governo Meloni a colpi di decreti ad hoc, i rave rappresentano ancora una delle espressioni più significative della sottocultura italiana. Li raccontano Francesca Robiolio e Nicolò Bussolati nel progetto fotografico Anyone Can Dance.
Alla fine di ottobre del 2022, in una fabbrica abbandonata nella periferia di Modena, si è svolto un rave-party che ha suscitato grande attenzione mediatica: la notizia viene coperta da tutte le principali testate e reti televisive, suscitando un acceso dibattito pubblico, anche correlato all’ingente spiegamento di forze dell’ordine per la repressione del rave. In specifica risposta all’evento, il governo Meloni ha approvato “d’urgenza” un decreto legge (poi convertito in legge) che ha introdotto nel codice penale una nuova fattispecie di reato “anti-rave”. E’ il primo atto di un percorso teso a limitare penalmente espressioni politiche e culturali invise al governo; lo stesso percorso che oggi propone il DDL sicurezza.
Oltre a prevedere pene sproporzionatamente alte (da 3 a 6 anni di reclusione: per fare un paragone, l’associazione per delinquere è punita da 3 a 7 anni), questo è l’unico reato nella storia del diritto penale italiano finalizzato a reprimere una forma di espressione (sotto)culturale.
L’utilità primaria di questa norma non è tuttavia di carattere giuridico. I rave sono sempre stati, per propria definizione, illegali, perché volontariamente estranei all’ordinamento giuridico e volti a una riappropriazione temporanea (e non autorizzata) degli spazi abbandonati dal sistema socioeconomico moderno. Al contempo, esistevano già nel nostro ordinamento strumenti sufficienti per la loro piena repressione penale.
Il nuovo reato ha quindi precipuamente una funzione simbolica: indicare con precisione che quella particolare manifestazione sottoculturale è da considerarsi come particolarmente pericolosa, annoverarla tra le principali nemiche dell’ordine costituito, e richiedere una sua implacabile repressione.
Nel suo paradosso, l’effetto sociale della nuova normativa è però stato evidente: i rave sono sempre meno e sempre più piccoli. Dopo trent’anni di mutamenti legati a fattori sociali e tecnologici – come la diffusione di internet, a cui è seguita una necessaria uscita dall’ombra – questa sottocultura appare agonizzante.
Eppure, alcuni suoi aspetti sopravvivono. Nascondendosi tra le pieghe del sistema, continuano a porsi come alternative estetiche, sociali e valoriali al monolite culturale della società contemporanea.
Questo intreccio tra elementi socio-giuridici e suggestioni estetiche si riflette nel lavoro della fotografa Francesca Robiolio Bose e del giurista Nicolò Bussolati, che si è a lungo occupato della difesa del movimento nelle aule giudiziarie. Le fotografie e le interviste raccolte mostrano i luoghi, i momenti di aggregazione e condivisione, i valori sociali, etici e artistici del movimento al di fuori del momento della festa. La musica, la tecnologia, l’arte, il viaggio; e sopra ogni cosa, il legame sociale e intimo che unisce queste persone tra di loro e con il mondo “esterno”. Il senso di appartenenza a una cultura, a un gruppo di persone che si estende oltre i confini geopolitici e si riconosce, sopravvivendo alla stretta penale.
Sta a noi, come società, indicare quali comportamenti devono essere puniti attraverso la legge penale. È quindi imperativo interrogarsi se l’organizzazione di un rave, i suoi partecipanti, la cultura che li permea, siano pericolosi, e meritino una repressione severa quanto quella prevista dall’attuale normativa. La risposta potrebbe discostarsi dal ritratto che il sistema giuridico propone, e dimostrarne l’incapacità di comprenderne l’etica, il funzionamento, le dinamiche, i comportamenti dei partecipanti e, di conseguenza, i confini di repressione penale. O forse, suggerire una cosciente volontà del potere esecutivo di utilizzare il legislatore (soggiogato attraverso decreti legge e questioni di fiducia) per controllare il panorama socioculturale, eradicandovi ogni espressione eterodossa.
Dall’osservazione e dall’ascolto dell’opera di decostruzione e ricostruzione di spazio, tempo e regole comportamentali tipica della sottocultura rave, emergono i principi che muovono il movimento: libertà, autogestione e autoregolamentazione, anticapitalismo, anticonsumismo, uguaglianza sociale, rispetto di sé e degli altri, arte come forma di espressione politica e, in particolare, un forte senso di appartenenza a una famiglia, una comunità che propone una società parallela, forse per certi aspetti più giusta.
“Abbiamo insegnato a un sacco di persone che quando vedono un’ingiustizia o una violenza devono intervenire, che quando una persona sta male bisogna aiutarla, che se c’è qualcosa di rotto bisogna imparare ad aggiustarlo. Perché noi siamo umani, siamo qui per aiutarci l’un l’altra nella vita quotidiana. Ci insegniamo a muoverci, a comportarci, che non c’è sempre qualcun altro che deve risolvere i problemi e che non servono istruzioni. Ci insegniamo a vivere e come vivere.”
Se all’indomani del decreto anti-rave il fenomeno delle feste non autorizzate si è drasticamente ridotto, persistono comunità libere che ne portano avanti i valori. Nella società del controllo e del consumo culturale indotto, resistono luoghi di sottocultura. Le fotografie e le dichiarazioni raccolte ne mostrano la complessità, l’eterogeneità anche estetica, le persone che li attraversano, le idee che li permeano. Ne mostrano però anche il momento di riflessione, di introspezione fisiologica all’indomani della stretta normativa. In attesa di poter riemergere, magari in altre forme.


“Abbiamo insegnato a un sacco di persone che, se vedono un’ingiustizia o una violenza, devono intervenire; che se una persona sta male bisogna aiutarla; che se c’è qualcosa di rotto bisogna imparare ad aggiustarlo. Perché siamo umani, siamo qui per aiutarci l’un l’altro, tutti i giorni. Ci insegniamo a vicenda a muoverci, a comportarci: non c’è sempre qualcun’altro che può risolvere i problemi, non servono istruzioni, ci insegnamo a vivere e come vivere”.
Da una conversazione in uno spazio occupato a Modena, Modena 2022.


“Tendenzialmente siamo lì per costruire un mondo migliore, quindi la società che c’è fuori non ci interessa”.
Matteo e Lorenzo (nomi di invenzione), in un terreno poco fuori Torino, 2022


“Credo fortemente nei messaggi dei rave: è un messaggio globale, di unità. Un rave può essere fatto da quattro ragazzi che si mettono in un parco con le casse e fanno musica tra di loro. Il rave è un’etica di libertà”.
Luca (nome di invenzione), provincia di Torino 2022.