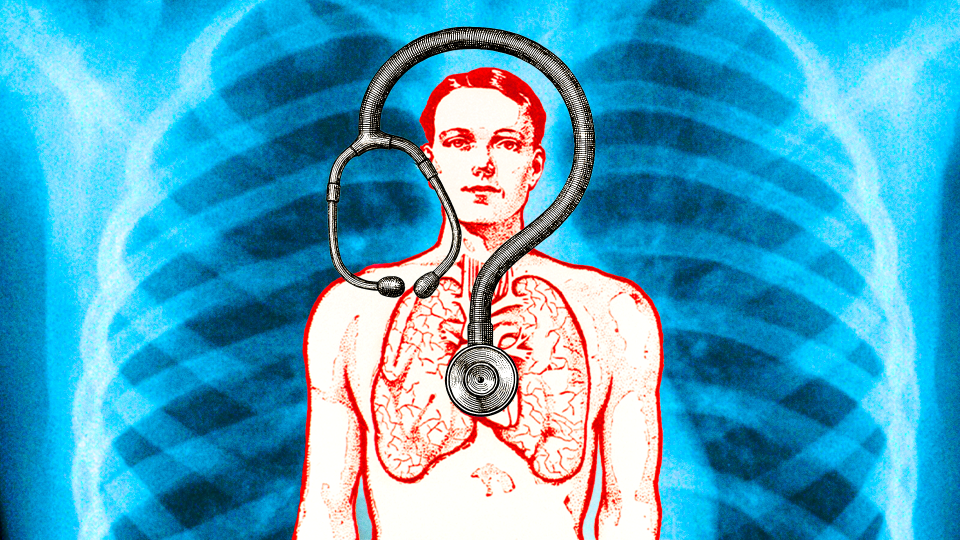Nella clinica come nella ricerca, il bisogno di avere ragione (e, a volte, di offrire una rassicurazione) è una tentazione costante. Ma in medicina, credere di sapere può essere più pericoloso che non sapere affatto.
Ero lì, con il puledro sdraiato davanti a me e la proprietaria che, piangendo, gli sosteneva la testa, implorandomi di salvarlo recitando, tra le lacrime, una sorta di drammatica litania. Era stata lei ad investirlo, mentre faceva retromarcia nell’erba alta del prato, con la jeep. Gli aveva fratturato due zampe e, in più punti, la colonna vertebrale. Avevo visitato il puledro e fatto le radiografie: per quell’animale nessuna pratica chirurgica e riabilitativa sarebbe stata percorribile, dovevo procedere con l’eutanasia. La medicina ha dei limiti e bisogna accettarli. Ma la giovane donna continuava a piangere e a implorarmi di fare qualcosa. Non volevo deluderla. Anzi, volevo alleviare il suo senso di colpa. Pensai di darle qualche ora di tempo per farle elaborare l’accaduto. Potevo somministrare oppioidi per alleviare il dolore del puledro, un sedativo per interrompere i continui quanto inutili tentativi di alzarsi, del cortisone per stabilizzare l’infiammazione. Forse avrei potuto aspettare qualche ora e ripetere le radiografie… Ma mi accorsi per tempo che stavo cadendo nel tranello: volevo accontentare il mio desiderio di consolare una persona sofferente, dimenticando che il mio lavoro è il benessere dell’animale. Spiegai la situazione alla donna con parole accorte e procedetti con l’eutanasia.
È solo uno dei tanti esempi che si potrebbero fare in merito alle innumerevoli influenze emotive che ci possono condizionare durante un processo diagnostico/terapeutico. Da medico veterinario sono consapevole del fatto che, di fronte a un animale malato, il ragionamento clinico si svolge in due fasi: 1) stesura di uno spettro di ipotesi diagnostiche e 2) esecuzione di accertamenti ulteriori (esami del sangue, ecografia, RX ecc.) per escludere/confermare le varie ipotesi iniziali fino ad arrivare alla conclusione tanto desiderata: la diagnosi definitiva.
Detta così sembrerebbe un processo lineare, quasi matematico. Per quanto un approccio sistematico alla diagnosi differenziale sia necessario nelle discipline cliniche, per raggiungere una diagnosi non bastano, purtroppo, gli algoritmi (un ragionamento sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in medicina meriterebbe un articolo a parte). Le variabili in gioco contro le quali dover resistere per svolgere il nostro lavoro nel modo deontologicamente più corretto sono molte: un animale malato è fonte di compassione anche per chi, come noi, tutti i giorni è a contatto con la sofferenza, e questo può influenzare le azioni che dobbiamo intraprendere. Il proprietario dell’animale ci chiede un aiuto e l’idea di volerlo rassicurare e confortare potrebbe indurci a prendere decisioni, per empatia, più vicine alle sue necessità che a quelle reali della contingenza del caso clinico.
C’è poi il proprietario che ha già una diagnosi in testa, perché il gatto di un amico ha avuto sintomi simili a quelli che ora presenta il suo e insiste per vedersi prescritta una determinata terapia che, da quanto ha letto su internet, è perfettamente adatta al suo caso. Alcuni di loro sono così insistenti che è talvolta difficile resistere al desiderio di accontentarli, risparmiandosi così noiose spiegazioni quasi sempre controbattute da ostinate contestazioni. Quando poi si tratta di visitare il cane dell’anziana signora che riferisce “Un paio di volte a settimana si gratta le orecchie con uno sguardo strano”, si prova un senso di disagio profondo nel vederla andar via, delusa, perché non ho voluto riconoscere che il suo amato quadrupede ha sicuramente una malattia che necessita di cure urgenti. La donna, una ex insegnante di storia al liceo, è persona colta e dalla conversazione interessante, e mi intrattengo sempre piacevolmente a chiacchierare con lei. Tuttavia, a volte vorrei dirle che se i suoi nipoti andassero a trovarla più spesso non avrebbe bisogno di sperare che io prescriva delle compresse al suo Billy, solo per combattere, somministrandogliele, la noia di lunghe giornate solitarie. Pur di vederla uscire sorridente, ho spesso fantasticato di darle delle finte capsule contenenti briciole di crocchette per cani, e di descriverle una posologia rigidissima. Fino a ora sono riuscito a desistere.
Ma, a mio avviso, il pericolo maggiore è dentro di noi: il famigerato confirmation bias. Potremmo tradurre la locuzione con “pregiudizio di conferma”. In pratica, siamo portati a confermare un’ipotesi tramite prove a favore, piuttosto che cercare di prendere in considerazione evidenze contrarie. Il confirmation bias tenderà quindi a farmi prendere come buone solo le informazioni che confermano l’idea verso cui sono pregiudizialmente orientato, scartando così ogni ipotesi alternativa. Mi indurrà a ricercare e raccogliere tutti i dati che la supportano, rifiutando o sminuendo le informazioni contrarie.
Nel 2014 alcuni ricercatori belga hanno pubblicato uno studio in cui 157 studenti di veterinaria sono stati inizialmente addestrati a valutare le interazioni sociali tra maiali, riconoscendo sia le interazioni positive (il gioco e il contatto naso a naso) che quelle negative (le testate e i morsi alle orecchie o alla coda). È stato poi chiesto loro di valutare due video di più maiali che interagivano in un recinto. Agli studenti è stato detto che uno dei video mostrava suini allevati per essere altamente sociali mentre l’altro mostrava suini normali, che dovevano quindi rappresentare il gruppo “di controllo” da usare come raffronto per valutare eventuali differenze. In realtà i due video erano identici: uno era il video originale e l’altro era lo stesso video ma mostrato in un’immagine speculare, con luminosità leggermente alterata e con codici e date inventati.
I risultati sono stati stupefacenti: quando i partecipanti allo studio pensavano di osservare maiali pro sociali, riportavano molte più interazioni positive e molte meno negative, rispetto a quando credevano di osservare maiali normali. Simili bias sono stati osservati per diverse altre specie animali, anche per valutazioni di tipo clinico. Nello stesso studio, ad esempio, agli studenti venivano mostrati 24 videoclip con diversi gruppi di bovini. Gli studenti erano preventivamente stati istruiti su come riconoscere il livello di dispnea (alterazione della normale respirazione) in questi animali, come aumento della frequenza del respiro, bocca aperta, collo allungato, lingua fuori dalla bocca, salivazione ecc… Sulla destra del monitor era presente una barra verticale che indicava la temperatura dell’ambiente in cui i bovini venivano tenuti e gli studenti dovevano assegnare un punteggio alla gravità dei sintomi respiratori. Gli sperimentatori avevano però falsificato le temperature indicate che non corrispondevano quindi a quelle reali. Inoltre, come nello studio precedente, alcuni videoclip erano identici tra loro (debitamente camuffati come per i video dei maiali), ma con l’indicazione di temperature diverse. Anche qui il risultato è stato sorprendente: quando gli studenti leggevano sul monitor una temperatura più alta assegnavano di conseguenza un punteggio della dispnea più alto rispetto ai video dove la temperatura veniva indicata come più bassa. Leggendo sul monitor che la temperatura era più alta, la dispnea doveva necessariamente essere più grave.
Il bias di conferma è comodo: minimizziamo lo stress di dover affrontare contraddizioni e ragionamenti alternativi. E poi è gratificante: rafforziamo la nostra identità trovando la prova che le nostre convinzioni sono solide ed esatte. Ho citato questi studi perché riguardano più direttamente la disciplina veterinaria, ma ne esistono molti altri che confermano queste evidenze direi in modo inconfutabile.
In uno studio effettuato su un gruppo di infermieri in Australia, ben il 63% di questi erano incapaci di modificare la loro prima valutazione sullo stato di salute di un paziente anche alla luce delle successive informazioni ricevute.
Richard P. Feynman, premio Nobel per la fisica nel 1965 nonché geniale e istrionico divulgatore scientifico, nel corso di una conferenza (il cui testo è stato poi trascritto nel suo libro Sta scherzando, Mr. Feynman!, ma reperibile anche qui) esorta i colleghi scienziati a fare il loro lavoro con uno speciale tipo di integrità, “a kind of scientific integrity, a principle of scientific thought that corresponds to a kind of utter honesty— a kind of leaning over backwards. For example, if you’re doing an experiment, you should report everything that you think might make it invalid — not only what you think is right about it: other causes that could possibly explain your results; and things you thought of that you’ve eliminated by some other experiment, and how they worked—to make sure the other fellow can tell they have been eliminated”.
Piegarsi all’indietro per osservare attentamente ciò che si sta facendo e cercare in continuazione di capire se e dove si sta sbagliando. Si tratta della continua analisi critica delle proprie osservazioni e affermazioni, arte nella quale uno studioso come Charles Darwin era maestro. Basti leggere la sua opera più rappresentativa, l’Origine delle Specie, per capire come ogni singola affermazione, prima di essere ritenuta pienamente sostenibile, fosse sottoposta a critiche e verifiche dallo stesso evoluzionista, che agiva continuamente da impietoso revisore di sé stesso.
“Il bias di conferma è comodo: minimizziamo lo stress di dover affrontare contraddizioni e ragionamenti alternativi. E poi è gratificante: rafforziamo la nostra identità trovando la prova che le nostre convinzioni sono solide ed esatte”.
In quella stessa conferenza, Feynman pronuncia anche una frase folgorante: “Il principio primario è che non devi ingannare te stesso, e tu sei la persona più facile da ingannare”. Per spiegare questo concetto, Feynman riporta quanto accaduto dopo che il fisico Robert Millikan (premio Nobel per la fisica nel 1923) riuscì a misurare la carica di un elettrone con un esperimento che prevedeva la nebulizzazione di gocce d’olio. Oggi sappiamo che la misurazione non era del tutto corretta (leggermente inferiore rispetto a quella attualmente accertata) ma comunque eccezionalmente accurata, soprattutto considerando i mezzi che il fisico aveva a disposizione più di un secolo fa.
Successivamente, altri scienziati hanno fatto diversi esperimenti per eseguire la stessa misurazione, ottenendo sempre risultati superiori a quelli di Millikan. L’aspetto interessante è che se si tracciano tali misurazioni in funzione del tempo si scopre che una è leggermente più grande di quella di Millikan, la successiva è ancora leggermente superiore, quella successiva ancora di più, finché alla fine si stabilizzano su un numero più alto. Feynman si chiede: perché non hanno scoperto subito che il nuovo numero era più alto? È evidente, commenta Feynman, che le persone facevano cose del genere: quando ottenevano un numero troppo alto rispetto a quello di Millikan, pensavano che ci fosse qualcosa che non andava, e cercavano e trovavano una ragione per cui qualcosa potesse non andare. Quando ottenevano un numero più vicino al valore di Millikan, invece, si astenevano dal cercarne altrettanto a fondo le cause. Fortunatamente, oggi abbiamo imparato questi trucchi della nostra mente e gli scienziati sono consapevoli di essere proprio loro, per primi, la persona più facile da ingannare.
Medici ma anche veterinari, infermieri, ricercatori come pure giudici, investigatori, poliziotti: sono solo alcune delle professioni più predisposte al confirmation bias. Ma il pregiudizio interessa tutti e in qualsiasi contesto quotidiano: nelle idee politiche, quando faccio una ricerca su internet (non affronteremo qui il fenomeno della polarizzazione indotta dagli algoritmi dei social, vera e propria istigazione al pregiudizio) o nel formare la mia opinione su qualcuno. È simile a quello che è noto come bias del tiratore scelto del Texas, in cui, dopo aver sparato, il tiratore che non ha colpito il centro dipinge un bersaglio intorno al foro del proiettile per “far tornare i conti”. Modelliamo la realtà alle nostre aspettative piuttosto che osservarla e trarne conclusioni in seguito a valutazioni complesse e talvolta molto faticose. Affermare ipotesi il più possibile definitive è infatti un comportamento umano naturale associato alla sopravvivenza, mentre, al contrario, contestare una convinzione radicata in noi sembra essere un’azione strana e artificiosa. Crea un contrasto interno che non riusciamo a gestire. È un fenomeno noto in psicologia come dissonanza cognitiva che può provocare stress mentale e persino disagio fisico. Di conseguenza, prendiamo la strada più facile, cioè quella di modificare la realtà per adattarla al nostro convincimento piuttosto che fare il contrario, come il tiratore texano.
Tornando alla pratica clinica, quindi, se si parte con un orientamento diagnostico in mente (il che è comodo e gratificante), poi bisogna avere il coraggio di combattere per scardinarlo pezzo per pezzo, fino a conoscere la verità o, perlomeno, per provare ad approssimarsi a essa il più possibile. Certo, l’esperienza è un’arma potente che ci permette di riconoscere una malattia più facilmente, soprattutto se conosciamo la storia del paziente e i sintomi sono eclatanti. Ma non bisogna impigrirsi utilizzando l’esperienza come alibi.
I cavalli soffrono di asma, come le persone. Hanno degli attacchi durante i quali respirano con affanno, tossiscono e si rifiutano di fare qualsiasi attività. La malattia è cronica e grave perché, come l’asma dell’uomo o quella dei gatti, non si può curare definitivamente ma soltanto gestire con i farmaci. Ricordo che, alcuni anni fa, in soli 5 giorni capitarono in visita quattro casi di asma che gestii con la regolare terapia. Quando arrivò il quinto cavallo con respiro affannato e tosse, sorrisi per l’inconsueta serie di casi analoghi in un tempo così breve e mi accinsi a prescrivere l’ennesimo trattamento per asma. Tra l’altro, conoscevo bene quel vecchio cavallo e lo avevo trattato altre volte in passato per la stessa malattia. La diagnosi, quindi, non poteva che essere “ennesima riacutizzazione dell’asma”. Era un periodo durante il quale diversi impegni burocratici mi stavano soffocando e si sommavano ad alcune preoccupazioni personali: fui perciò felice di aver risolto così rapidamente il caso. Il retaggio dei quattro cavalli precedenti e la fiducia nel fatto che conoscevo bene l’anamnesi dell’animale, mi convinsero a tralasciare l’esecuzione di altre indagini diagnostiche, come l’endoscopia, l’ecografia o la radiografia. In pratica, io non sapevo che quella fosse una riacutizzazione dell’asma, io volevo che fosse una riacutizzazione dell’asma.
Lo feci preparare per la somministrazione dell’aerosolterapia e fu solo quando stavo inserendo i farmaci nel nebulizzatore che mi accorsi di un minimo, quasi impercettibile, sanguinamento dal naso che prima non avevo notato o, meglio, non avevo cercato. La successiva endoscopia rivelò un carcinoma diffuso a livello bronchiale.
Come cita un vecchio adagio che mi sembra appropriato al contesto per più di un motivo: se senti un rumore di zoccoli, pensa a un cavallo… ma non dimenticare di considerare la zebra. In pratica: tieni sempre a mente l’imperativo del rasoio di Occam ma non agire col paraocchi del pregiudizio.
Oltre ad essere un veterinario internista che quotidianamente visita animali, in particolare equini, sono anche un ricercatore. E quello che è vero nell’attività ambulatoriale di routine è vero, come già accennato, anche nella ricerca. Chi non vorrebbe che la molecola che sta cercando sia quella giusta per curare il cancro?
A influenzare una pratica scientifica possono concorrere davvero molti tipi di bias. Da chi studia questi ambiti ne sono stati contati ben 65. Tra tutti, il bias di conferma è quello che può influenzare ogni fase dell’esperimento: dalla scelta dell’ipotesi iniziale, che potrebbe essere la preferita dallo sperimentatore e non necessariamente quella opportuna (nel caso della clinica è la scelta della diagnosi che a priori pensiamo possa essere quella giusta), al metodo che si decide di applicare, fino all’elaborazione dei dati ottenuti (ad esempio il metodo statistico).
Fortunatamente, nel campo della ricerca abbiamo validi meccanismi di difesa, come la randomizzazione, gli esperimenti in cieco (lo sperimentatore è ignaro del protocollo sperimentale o di una parte di esso), l’utilizzo di misurazioni oggettive, la validazione della metodica e dei risultati tramite la revisione tra pari. Proverò brevemente a spiegarmi. Se ad esempio devo testare una nuova molecola per la terapia dell’anemia, la cosa migliore da fare, semplificando molto, è dividere in due gruppi un insieme di persone malate e somministrare il farmaco al primo gruppo e una sostanza del tutto priva di effetti (placebo) al secondo, per valutare poi le differenze relative all’efficacia.
Ci si aspetta che le persone che assumono il farmaco abbiano un miglioramento, mentre quelle che assumono il placebo non abbiano alcun tipo di giovamento. Se io, sperimentatore, dovessi decidere chi inserire in un gruppo e chi nell’altro, potrei inconsciamente scegliere le persone più pallide ed emaciate per assegnarle al gruppo placebo. L’assegnazione casuale (randomizzazione) a un gruppo o all’altro assicura di eliminare questo bias che mi spinge, senza che io me ne accorga, a indirizzare il processo verso la conferma della mia ipotesi. Se poi chi dovrà valutare eventuali miglioramenti clinici non sa cosa sia stato somministrato e a chi (esperimento in cieco), si riduce ulteriormente la possibilità di pilotare le valutazioni. Queste ultime devono essere fatte con parametri misurabili (oggettivazione della misurazione) ad esempio dosando il valore dell’emoglobina nel sangue e non, magari, con la semplice osservazione del colorito cutaneo. Infine, la metodica e i risultati ottenuti, per poter essere pubblicati su una rivista scientifica degna, devono essere valutati da tre o più referees anonimi esperti del settore (revisione tra pari) selezionati dall’editore tra gli scienziati di tutto il mondo e a loro volta ignari di chi siano gli autori della ricerca.
“A influenzare una pratica scientifica possono concorrere davvero molti tipi di bias. Da chi studia questi ambiti ne sono stati contati ben 65. Tra tutti, il bias di conferma è quello che può influenzare ogni fase dell’esperimento”.
Nonostante queste precauzioni, come medici e ricercatori ci troviamo quotidianamente a cercare di scardinare tali meccanismi, tenendo sempre la mente aperta, pronti ad accettare fatti che smentiscono certezze, eseguendo azioni (nello specifico indagini diagnostiche o verifiche sperimentali) potenzialmente in grado di contraddire la nostra convinzione primaria (diagnosi o teoria iniziale). A volte ci ritroviamo addirittura a dover sperare di essere contraddetti dalle evidenze. E tutto ciò è impegnativo.
Mettersi in discussione tutti i giorni è seccante e faticoso e ritengo che questa sia una delle parti intellettualmente più impegnative del nostro lavoro di ricercatori e di medici veterinari. Se qualche volta ci vedete lì, a grattarci il mento, mentre fissiamo negli occhi la vostra bestiolina sofferente, sappiate che non stiamo pensando ad altro, ma stiamo combattendo una battaglia interiore per fare bene, o solo meglio, il nostro lavoro.