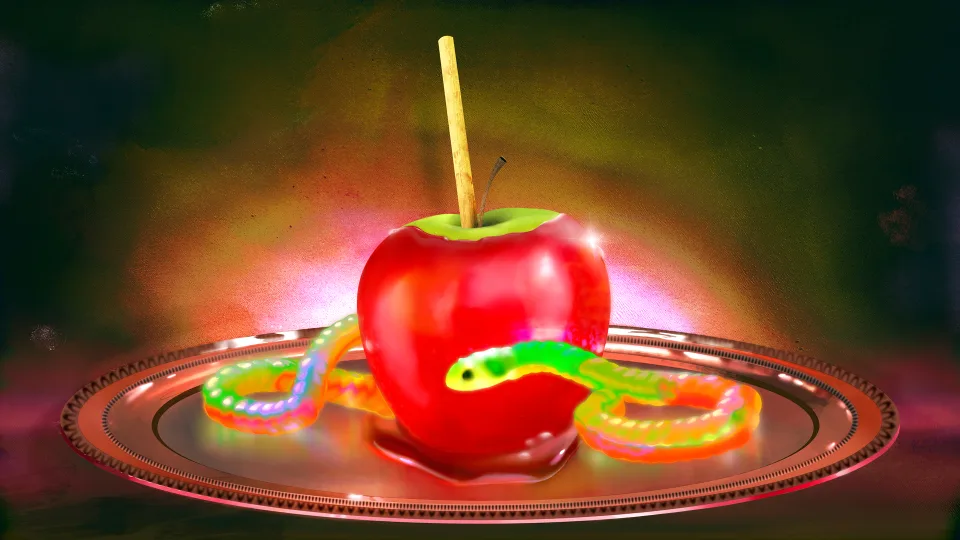Nel suo saggio "Per una rivoluzione degli affetti", la scrittrice e attivista spagnola riflette su come il capitalismo abbia trasformato non solo il modo in cui produciamo, ma anche quello in cui amiamo. Dalle terre comuni alle relazioni, l’autrice cerca uno spazio in cui liberarci dalle imposizioni.
Qualche tempo fa mi è capitato tra le mani un libro sulla rivoluzione. Tra le tante rivoluzioni possibili, questa riguardava le relazioni umane. Mi era stato consigliato, e così ho fatto io a mia volta. Ho inviato alcuni paragrafi ad amici e amiche, ho recuperato le pagine a cui avevo fatto le orecchie perché sapevo già che avrei avuto bisogno di rileggerle. Ne ho parlato a lungo con i miei coinquilini, seduti al tavolo dopo cena, tra una partita di burraco e l’altra. C’erano sempre dei punti che rimanevano sospesi, e molte volte ho immaginato quanto sarebbe stato prezioso avere l’autrice a quel tavolo con noi, offrirle una birra e ragionare insieme.
Con Per una rivoluzione degli affetti. Pensiero monogamo e terrore poliamoroso, pubblicato in Italia da effequ e tradotto da Andrea Gatti e Cristina Velázquez Delgado, ho scoperto per la prima volta la voce di Brigitte Vasallo.
Mentre mi avvio all’hotel di Milano dove l’autrice mi sta aspettando, non posso ancora sapere che l’intervista avrà lo stesso sapore di quelle serate. Entra nella hall dal cortile interno e mi saluta in italiano: “Ciao, scusami, arrivo subito”. E scompare, per ritornare poco dopo. Mentre mi parla si sporge in avanti sul tavolino stretto, eliminando qualsiasi residuo di formalità. Potremmo essere lì o sul mio terrazzo di casa. Mi sorride, chiacchieriamo per un po’ in italiano prima di passare allo spagnolo. Nella sua vita, tra uno spostamento e l’altro, ha vissuto anche a Roma, per studiare all’Accademia di Spagna. Ricercatrice, scrittrice e titolare della cattedra di Studi Catalani presso l’Università di New York (CUNY), il lavoro di Vasallo si articola tra il tentativo di comprendere come razzismo e misoginia si sovrappongono e si alimentano a vicenda, in particolare rispetto alle donne musulmane (da cui il romanzo Pornoburka, tradotto nel 2020 da Claudio Marrucci) — grazie anche a una lunga esperienza di vita in Marocco — e l’apertura a forme relazionali altre rispetto alla monogamia, ponendo una particolare attenzione alla necessità di non ricadere nelle logiche di possesso e di competizione dettate dal capitalismo.
Hai più volte parlato delle tue origini, del tuo essere xarnega e della tua appartenenza a una famiglia che ha “poca genealogia”, che ha dimenticato il proprio racconto, la propria provenienza. Secondo il dizionario della Real Academia Española, xarnego è colui che è “immigrato da una regione spagnola di lingua non catalana”. Il concetto, in realtà, ha un senso più profondo: tra il 1950 e il 1970, nel mezzo della dittatura franchista, il termine “xarnego” viene utilizzato per riferirsi in modo dispregiativo ai migranti economici, coloro che provengono dalle zone contadine e che non avevano entrambi i cognomi catalani. La tua famiglia è originaria della Galizia, del paesino di Chandrexa de Queixa, una comunità di contadini costretti a lasciare la loro terra e a emigrare prima in Francia e poi in Catalogna. In che modo credi che tutto questo abbia influito con il tuo modo di rapportarti al mondo e con la tua volontà di ridiscuterne le categorie?
Sì, è vero, non so tracciare la mia genealogia. O forse, mi chiedo, il luogo da cui provengo ne ha semplicemente una diversa. Al Metropolitan Museum di New York ho fotografato una lunghissima pergamena che rappresenta la genealogia dei re d’Inghilterra. Quando guardo quella foto non posso fare a meno di pensare che io non faccio parte di quelle persone. Allora, forse, questo modo di raccontare chi sei, di definirti sulla base della tua genealogia, non appartiene al mio popolo. Non importa sapere chi erano i miei bisnonni, potrebbero essere chiunque. La consapevolezza di venire da luoghi diversi, e di abitare luoghi diversi — sia a livello di origine, che di genere, che di classe — è alla base di tutto il mio lavoro.
Non appartengo ai circuiti accademici perché non ho potuto permettermi di intraprendere quel tipo di carriera, ma questo fa sì che il mio lavoro di ricerca avvenga in contesti molto più aperti. Ora che ho costruito una carriera internazionale, posso guardare indietro e accorgermi che i luoghi da cui provengo sono stati per me strumenti comunque utili.
Quando parli dell’esistenza xarnega, la descrivi spesso come un’esistenza queer. In che senso?
Per me sono la stessa cosa. Questa associazione genera spesso scandalo, ma la connessione per me è evidente. L’identità xarnega è molto simile al concetto di “terrone” in Italia. Non definisce solo chi proviene dal Sud, si riferisce piuttosto a una provenienza contadina. Nemmeno il concetto di xarnego è esclusivamente geografico. Questo significa che gli strumenti di analisi del mondo sono manchevoli, perché non riescono a spiegare chi viene da un luogo diverso da quelli già schematizzati.
Lo stesso avviene con il concetto di queer: è diventato, ormai, una categoria, che ti impone di essere questo o quello, di scegliere un’identità sola, un solo schema relazionale. Ma il concetto di queer non riesce a spiegare chi sei, non racchiude la tua esperienza, perché la tua esperienza sta altrove, in un posto che non è nemmeno dentro a quel sistema, anche se è completamente dominato e influenzato da esso. Non è che tu stia in un luogo fantastico dove questa struttura non esiste. Esiste, certo, ma non riesce a esaurirti fino in fondo.
Un tema di cui ti stai occupando molto in questo periodo, e di cui parlerai anche questa sera nel tuo intervento al festival 2084 organizzato dalla Scuola di Scrittura Belleville, è la trasformazione del mondo contadino e rurale causata dall’avvento del capitalismo e del cosiddetto “miracolo economico”. In Per una rivoluzione degli affetti parti dalle origini, dal momento in cui nel XVII secolo si iniziarono a recintare i terreni comunitari. La recinzione delle terre è divenuta, poi, una recinzione degli affetti? In che modo l’ordinamento della produzione porta anche a una classificazione della sessualità?
Quando ho riletto Per una rivoluzione degli affetti sono rimasta colpita di ritrovare la questione delle terre comuni, non ricordavo di averne già parlato. Ora è al centro del mio lavoro, perché nel villaggio da cui proviene la mia famiglia — lo stesso da cui me ne sono andata e dove sono tornata per la prima volta dopo trent’anni — ci sono ancora dei terreni comunitari, e io non lo sapevo!
Avviene tutto nello stesso periodo storico: in Inghilterra, ma poi anche in Spagna, con l’arrivo del capitalismo nell’Ottocento le terre vengono recintate, per sfruttarle in maniere aliene alla vita comunitaria. I contadini che vivono in quella terra sono costretti così ad andarsene nelle città.
Parallelamente, il sistema amoroso in cui viviamo, come tutti i sistemi in cui viviamo, è orientato dal pensiero che si produce nelle città. La civiltà urbana è anche la civiltà monogama e la civiltà coloniale. Dirigendosi verso le città, ci si dirige anche verso quella nuova forma amorosa. È tutto intrecciato, tutto converge verso un preciso momento storico in Europa: l’inizio del capitalismo. Il taglio non è netto, perché le comunità contadine hanno resistito attraverso i secoli, e continuano, incredibilmente, a resistere, anche se in nuclei sempre più piccoli e sempre meno “puri”. Quella ricerca della purezza è anch’essa una forma di oggettivazione: dimostra che vedi l’altro come un oggetto, non come un soggetto. Ma ci sono ancora moltissime pratiche e forme di vita diverse da tutte le altre, in luoghi sempre meno popolati. Con uno sguardo attento, si vede che stanno conservando delle forme di esistenza che indicano un altrove, qualcosa che non ha a che vedere con ciò che esiste nelle città. È incredibile. Conservano anche altri modelli relazionali, in molti sensi. Non ci si può aspettare di trovare reti poliamorose o persone che si identificano come trans, questo no.
Per esempio, nel mio villaggio sono rimaste due persone. Se sommiamo tutte le persone che orbitano intorno a quel luogo, me compresa, siamo in nove, completamente diversi l’uno dall’altro. Nel mio paese, quando nasceva una persona intersessuale, gli davano un nome neutro. E, una volta diventata adulta, poteva decidere la sua identità, così come poteva decidere dove andare a vivere, come chiamarsi. Non era qualcosa di eccezionale, era la normalità. E veniva raccontato così, semplicemente. “Guarda, quella persona è nata uomo e donna. E si chiama così perché questo è il suo nome. E ora, da adulta, è una donna”.
Nel mio paese, la donna dà il cognome. Gli uomini vengono chiamati in riferimento alla loro moglie. Quindi: “Juan de la Flora” oppure “Paco de la Sinda”. La donna, invece, è nominata in riferimento al paese dove vive, anche se non è il suo paese d’origine. Quindi di nuovo: non si tratta di dire che modello è migliore, ma di riconoscere che esiste un’alternativa. Esiste qualcosa di diverso, qualcosa che non riusciamo ad analizzare o a vedere, perché siamo condizionati da determinati modelli sociali. E allora bisogna mettere da parte quei modelli per capire che cosa ci può raccontare questa realtà, e come possiamo costruire la nostra genealogia senza lasciarla colonizzare dalle forme urbane.
Nei diversi temi da te trattati (la lingua inclusiva, il poliamore, il mondo rurale) ritorna spesso il contrasto tra ciò che è visibile e ciò che, invece, resta invisibile. Restano invisibili le forme relazionali che non sono monogamia, quasi come se non fossero legittime, resta invisibile tutto ciò che non viene nominato o incluso in un linguaggio. A un primo sguardo, il tuo pensiero sembra evidenziare una necessità di visibilità. Eppure, più volte hai sottolineato la tua volontà di rivendicare l’invisibilità, l’indifferenza degli altri di fronte al tuo essere xarnega o al tuo essere lesbica, per esempio. Perché? Qual è, quindi, il tuo obiettivo?
Credo che sia importante chiedersi: visibile a chi? A me interessa molto di più ciò che è invisibile. Per esempio, di fronte a un contenuto Instagram mi chiedo: quale storia nasconde la foto che sto guardando? Quale linguaggio c’è dietro? Quello che conta, secondo me, è la capacità di vedere l’invisibile. Anche perché la sfera pubblica, per me, non è davvero il visibile. Ciò che mi preoccupa è che non siamo capaci di vedere tutto ciò che avviene attraverso altri canali e che, forse, nasconde strumenti di comprensione.
Mi hanno intervistato in questi giorni sul tema delle radici e la giornalista concepiva le radici come qualcosa che sta dietro, nel passato. E io le dicevo: “No, non ci stiamo capendo, per me le radici non stanno dietro, stanno sotto”. Quindi a me interessa questo: l’invisibile nel senso dell’architettura che ci sostiene. Quando capisci com’è fatta questa architettura, anche quello che sostiene, ciò che si vede, cambia. Riesci a cogliere nuove sfumature, e questo è fondamentale in un momento in cui c’è una sola faccia possibile delle cose, e la molteplicità è considerata sospetta.
” Il sistema amoroso in cui viviamo, come tutti i sistemi in cui viviamo, è orientato dal pensiero che si produce nelle città. La civiltà urbana è anche la civiltà monogama e la civiltà coloniale”.
Un elemento che torna varie volte, sia in Per una rivoluzione degli affetti che in Linguaggio inclusivo ed esclusione di classe è la logica del bello: dovremmo desiderare, tanto sessualmente quanto a livello linguistico, solo ciò che è canonicamente bello. Un bel corpo, un discorso che utilizzi un linguaggio accademico, sono considerati eticamente buoni, sono legittimati. Allo stesso tempo, un corpo canonicamente brutto, un linguaggio dialettale, vengono considerati illegittimi, moralmente cattivi. Puoi spiegare cosa intendi quando affermi che “Le forme di resistenza nascono lì dove non arriva il capitale, ovvero da ciò che il capitale ha schifato, ha ritenuto brutto, ha tagliato fuori”?
Sul bello hanno lavorato tutti, non è certo una novità. L’associazione tra bello e buono è una grandissima trappola, soprattutto sapendo che il nostro modo di intendere il bello è condizionato dal nostro contesto sociale. Eppure quando esploriamo la nostra storia, quando raccontiamo tutte quelle storie subalterne che non hanno potuto essere narrate, emerge sempre il bisogno di difenderle in quanto buone. Ma cosa, di noi esseri umani, è davvero buono? Siamo un disastro. Bisogna imparare a guardare ciò che ci caratterizza, a definirlo come luce o come ombra, senza il bisogno di difenderlo da un punto di vista morale.
Tornando alla frase che citi, io credo non esista nulla al di fuori del capitale, o almeno niente che io conosca, niente nel mio contesto, niente qui in Europa, se vogliamo dare un riferimento geografico. Però esistono gli spazi che il capitalismo disprezza. E lì accade altro. Perché non sei fuori dal mandato, ma nemmeno ne ricevi la ricompensa. Quindi devi trovarti un altro modo di vivere. Ed è lì che si vedono le crepe. È uno spazio rivelatore. Prendiamo, per esempio, il lesbofemminismo. Lo sguardo più interessante è quello della periferia, di chi è emarginato. Quando hai addosso il riflettore del centro del sistema, non vedi nulla e non puoi davvero capire la tua posizione. Bisogna chiedersi: come ci guarda chi è razzializzato? E quello sguardo, quindi, diventa complementare alla tua identità.
Oggi sembra che nessun confronto possa essere complementare, che ogni sguardo su una realtà possa solo negarla o annullarla. Ci ritroviamo dentro a una battaglia, alla logica di George Bush: o sei con me, o contro di me. Ma io credo, invece, che tutti quegli sguardi che non sono vólti al centro del sistema diano informazioni interessanti proprio sul sistema stesso.
Nei tuoi libri porti spesso l’attenzione sul rischio che le relazioni, tanto poliamorose quanto monogame, riproducano le logiche capitaliste, basandosi su gerarchie relazionali. Dovremmo, dunque, liberarci dalla competizione in tutti gli ambiti della nostra vita. Come possiamo riuscirci?
Credo che stiamo sbagliando il modo di vedere i sistemi in cui viviamo, come se potessimo uscirne. Stiamo peccando di individualismo. Quando diciamo, per esempio, “Io non ho genere”. Se tu non hai genere, sottintendi, quindi, che io ho un genere perché lo voglio? Io non voglio nessun genere. Però cosa posso fare? Sono in questo sistema, è qualcosa che va oltre la mia individualità. Dobbiamo tenere a mente le conseguenze di un’affermazione simile, perché non siamo sole nel mondo. Anche il modo in cui io mi percepisco ha conseguenze comunitarie, a prescindere che io voglia far parte di una comunità o meno. La comunicazione comporta la presenza dell’altro, della comunità, quindi ha delle conseguenze sul piano comunitario. Pensare che all’interno di questo sistema monogamo possiamo inventare qualcosa che non ha a che fare con il sistema stesso, significa fingere che il sistema non sia reale, fingere che ci sia una possibilità di scelta. Dunque quello che dobbiamo fare è partire da quella struttura, in cui cresciamo e in cui proviamo a decostruire e a costruire altro. Ma dobbiamo capire qual è il sostrato con cui stiamo costruendo.
Come facciamo a non competere nel sistema in cui siamo? È molto difficile, non ho la formula per non competere. Ma esiste una forma di resistenza, che è la consapevolezza e l’impegno politico a preferire la strada della cooperazione a quella della competizione.
Nella vita quotidiana ci sono moltissime occasioni in cui possiamo scegliere di non competere, eppure optiamo sempre per la competizione, perché, in fin dei conti, ci piace: c’è una ricompensa. Eppure è proprio per questo che è necessario impegnarsi politicamente a preferire la cooperazione, anche nelle cose di ogni giorno.
In Polisicure, Jessica Fern sostiene che per costruire relazioni non monogame sane serva lavorare profondamente sul proprio attaccamento e sui traumi affettivi, a livello individuale e relazionale. Tu invece, in Per una rivoluzione degli affetti, metti in discussione le strutture sociali e culturali che rendono la monogamia una norma ideologica e politica e dai molto più spessore a tutto ciò che è comunitario. Credi che un lavoro interiore possa davvero produrre cambiamento sistemico, o rischia di individualizzare problemi che sono soprattutto strutturali?
Sono sempre un po’ scettica quando entra in gioco il ritorno alla sfera personale. Soprattutto quando si lavora sui traumi quasi come un’accusa. I traumi sono collettivi, quindi anche la soluzione dev’essere collettiva. Dobbiamo essere in grado di accompagnarci nella fragilità. Questo non significa sopportare abusi, ovviamente, ma vuol dire che ogni persona deve poter andare avanti, anche con la propria fragilità. A questo serve la comunità, no? Cerchiamo di costruire un luogo in cui poterci spezzare, in cui poterci rompere senza però rompere gli altri.
Quindi ciò che io mi chiedo è: a livello politico, come si traduce il fatto che ognuno lavori sul proprio trauma? Ognuno deve lavorare sul proprio capitalismo? Come si fa? Perché quello che mi interessa non è un insieme di singole persone non monogame, ma un mondo non monogamo. Un mondo in cui posso dire cioè: “A Gaza c’è un genocidio in corso”, e allo stesso tempo posso non essere antisemita. Le due cose devono convivere. Riconosco il trauma del popolo ebraico, riconosco la Shoah, ma riconosco anche quello che sta accadendo ora in Palestina.
Per me la non monogamia riguarda anche questo, la possibilità di riconoscere e affrontare delle cose che spesso è più comodo vedere come polarizzate.
Quindi, qual è per te la cosa più urgente per te da rivoluzionare nei nostri affetti?
La cosa più urgente è fermare il genocidio a Gaza. Questo ha a che fare con i nostri affetti. A volte mi si chiede: “Come facciamo ad avere relazioni sane?”. Come possiamo avere relazioni sane se ci sono genocidi in corso? Dobbiamo risanare le nostre relazioni rendendoci conto dei nostri dolori, quali sono, da dove vengono, come li rendiamo comunitari, chiedendoci come possiamo smettere di competere, eccetera. E questo significa anche fermare il genocidio a Gaza, perché è il risultato di secoli in cui non ci siamo posti queste domande. Lo stesso vale per le morti nel Mediterraneo. La resistenza a tutto questo dipende da noi, così come la resistenza a schemi relazionali violenti.
Audre Lorde diceva: “Perché sono donna, perché sono Nera, perché sono lesbica, perché sono me stessa, una donna Nera guerriera poetessa che fa il suo lavoro, che è venuta a chiedervi: state facendo il vostro?”. Quindi, ricordiamoci questo: noi dobbiamo fare il nostro, e non arrenderci prima. Perché è questa l’epoca che ci è toccata.
C’è qualcosa dell’amore romantico, dell’amore “Disney”, che per te vale ancora la pena salvare?
Ah, sì, tutto! Io sono super romantica! Voglio tutto dell’amore “Disney”, ma solo come una fantasia. Lo voglio come voglio un viaggio quando prendo droghe o quando mi sbronzo. Ci sono una serie di cose che usiamo come evasione, ma sappiamo di doverle circoscrivere e ne riconosciamo le conseguenze, non solo personali. E ben consapevoli di tutto questo, con tutte le informazioni a nostra disposizione, decidiamo, a volte, di concederci quello spazio. Dà molto piacere, ma dobbiamo ricordarci che non è reale, è un’evasione che ci stiamo concedendo.
Possiamo giocarci, ma dobbiamo stare attenti a non perderci, così come succede con altre sostanze. E allo stesso tempo, dobbiamo ricordare che l’amore romantico non coincide con la cura. L’amore romantico è una narrazione invasiva dell’amore che, portata agli estremi, ci impedisce di vedere ciò che sta realmente succedendo, e non ci permette di tornare indietro quando le cose si fanno complicate. Ci intrappola, lasciandoci in un bosco in fiamme senza però un viale tagliafuoco.
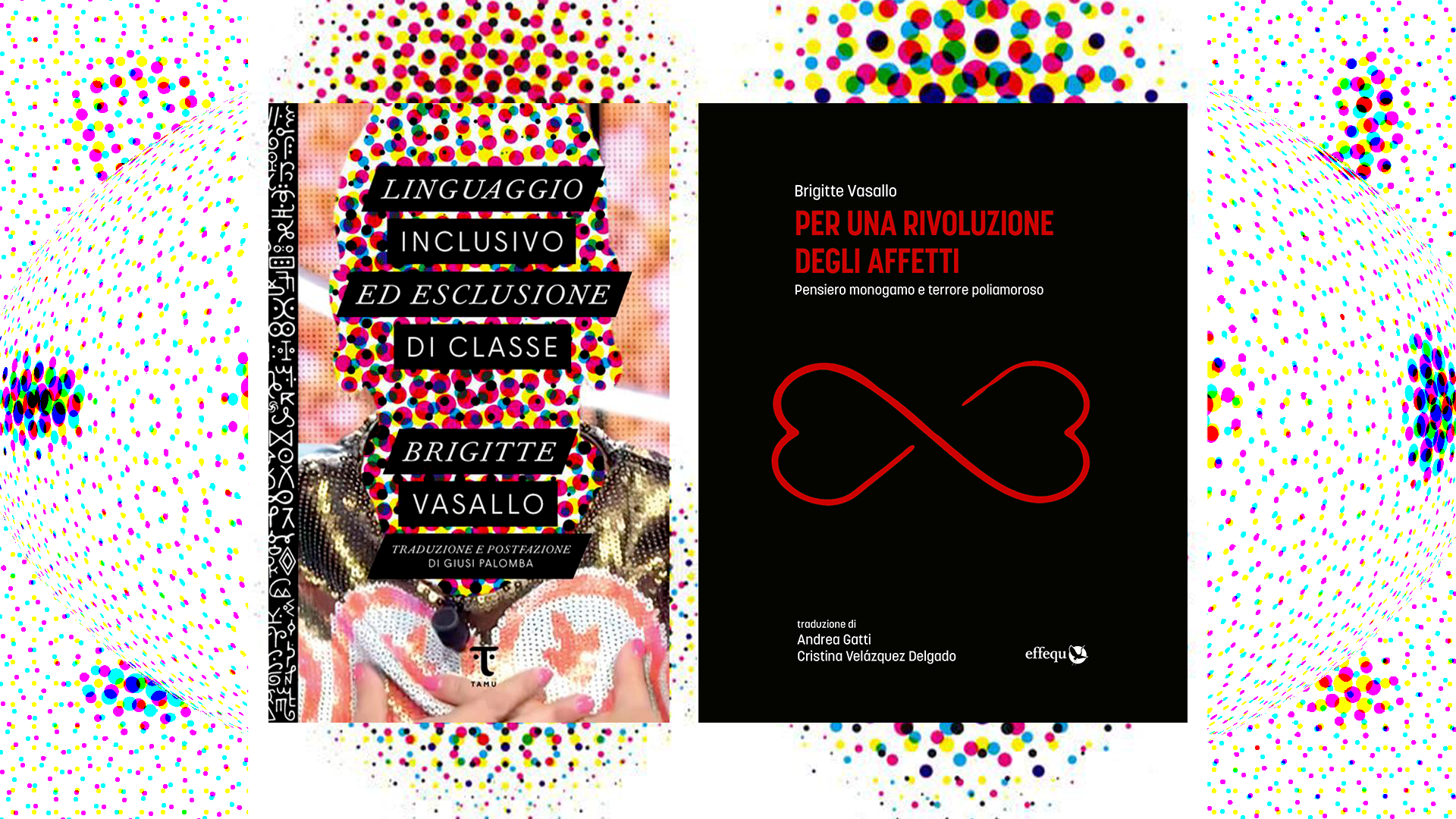
Devi sapere che i miei coinquilini sono tuoi grandi lettori, sono felicissimi che io sia qui a intervistarti. Quando ho chiesto a uno di loro, Samuele, cosa ti avrebbe chiesto se avesse avuto la possibilità di intervistarti, mi ha detto: chiedile che ci consoli. Spieghi molto bene cosa significa costruire relazioni sane, non competitive, distanti dalle logiche capitaliste. Eppure chi ci prova si trova ingarbugliato nella pratica, inabile e inadeguato rispetto alla teoria. Consola Samuele, se puoi.
Credo di aver scritto un libro intero sul fallimento. Innanzitutto, perché quel fallimento non ci appartiene, ma ha a che fare con il fatto che siamo impigliati in strutture che non riusciamo a capire. Il lavoro di chi, come me, si dedica alla teoria critica è proprio questo: cerchiamo di spiegare questa architettura, cerchiamo di comprendere quali strade sono percorribili e quali no. Quindi il fallimento è una fonte di comprensione, se questo può consolare il tuo amico. Altrimenti avrei scritto un libro sui miei successi amorosi, no? Se Samuele si sente solo nei suoi fallimenti, mi guardi: ci siamo tutte impantanate. La cosa buona è che non ci stiamo arrendendo. Come possiamo uscirne? Partendo dalla comunità e dal ricordarci che siamo piccoli. Che non siamo più piccoli di quanto crediamo, ma nemmeno più grandi di quanto possiamo essere. Quindi non arrendiamoci, ricordiamoci cosa non vogliamo essere e cerchiamo di essere qualcos’altro. Il cambiamento ci sembra sempre minimo, ma non ci arrenderemo.