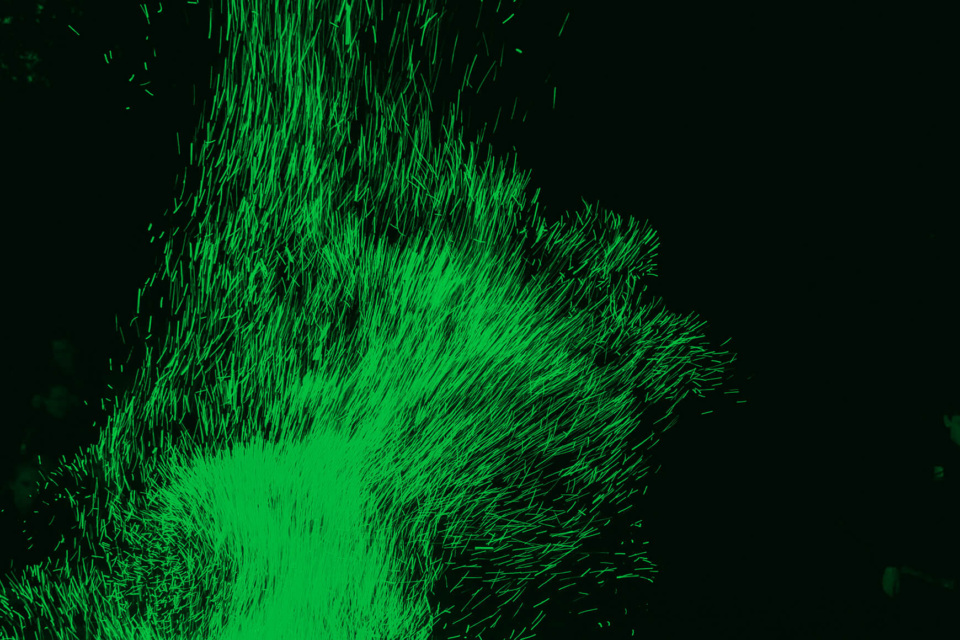Ieri è morto Rino Tommasi che, da solo e in coppia con Gianni Clerici, è stato uno dei più grandi telecronisti sportivi in Italia, oltre che giornalista. Grande professionista, ma anche uomo diretto e dal carattere molto forte.
Credo di essere stato seduto a tavola tre o quattro volte, non di più, con Rino Tommasi. Ed era verso il suo fine carriera, nei primi anni Duemila.
Quando iniziai a sbirciare dalla tv in salotto il mondo del giornalismo tennistico, era già un’istituzione; c’era qualcosa in lui che infondeva una sensazione di competenza e rassicurante assertività; nonostante la mia predilezione non fosse per lo stile asciutto e british, restavo ammirato dalla limpidezza nell’esporre idee e concetti. Non che avesse una bella voce, perlomeno tecnicamente: nasale e con toni un po’ “schiacciati”, ma scandiva le parole in modo tale che parevano uscire dalla sua bocca come fossero state scalpellate: suono e contenuto si fondevano in un solenne verdetto. Lo ha detto Rino.
Se il termine “manicheo” si può usare nel linguaggio del tennis, Rino era manicheo. Non amava le sfumature, credo perché le ritenesse una forma di ipocrisia, o di vestizione delle proprie reali opinioni con un manto superfluo di moderazione. Una volta, in un momento di rilassatezza in una sala stampa – un Monte Carlo degli anni Duemila – si stava parlando del doppio, per lui una specialità nobile che però, dal momento in cui era stata disertata dai migliori singolaristi, andava necessariamente relegata nel girone dei dannati. La discussione verteva sul numero di titoli vinti dai gemelli Bob e Mike Bryan, il rapporto tra la loro grandezza e quella delle più vincenti coppie del passato: Newcombe e Roche, McEnroe e Fleming, McNamara e McNamee. A un certo punto, Rino intervenne tagliando in due la diatriba: “I gemelli Bryan sono due brocchi”. Al momento di imbarazzo collettivo, sottolineato da un improvviso silenzio, ribadì con un ghigno e scandendo ancora meglio i termini: “Due-brocchi”. Fine della discussione.
Non sono la persona giusta per raccontare la carriera di Rino Tommasi, infatti non lo farò. È nato nel 1934, quarantadue anni prima di me (se potessi aggiungere un avverbio, userei “purtroppo”). Non ho mai lavorato con lui, del resto sarebbe stato difficile: da direttore di giornale me lo raccontavano come individualista, avverso alle assemblee e riunioni di redazione. Durante una di quelle, pare si sia alzato in piedi per proferire la seguente frase: “Non accetto di partecipare a una votazione nella quale Tizio”, indicato con il dito per non lasciare spazio a dubbi, “ha lo stesso diritto di voto mio”. Non fatico a credere sia capitato. In televisione, mai avrei potuto far coppia con lui, perché facciamo lo stesso mestiere. Non si dovrebbe, ma mi permetto di buttare lì una piccola vanteria: un giorno, durante una diretta streaming con me e Ubaldo Scanagatta – che lo incalzava, sperando di mettermi un po’ in difficoltà: sono cose che Ubaldo fa per abitudine, e nel nostro lavoro in fondo è una qualità – gli rivolse questa domanda: “Al giovane Ferrero che gli vogliamo dire, Rino?”. “Che non ha più niente da imparare”, replicò. Stavo per cascare dalla sedia. Mi perdonerete se cado in questa trappola autoreferenziale, ma lo faccio perché mi permette di spiegare un aspetto che invece ho vissuto di Tommasi e per il quale ho sempre provato una sensazione composita di ammirazione e incertezza: è giusto essere sempre diretti e specchiati come lui? Dire al bravo che è bravo, al tonto che è tonto, al brutto che è brutto? Credo che la risposta sia sì, se uno se lo sente. A patto di essere coerenti e consequenziali: Rino lo è stato, senza dubbio alcuno.
Qualche anno prima della sua breve sentenza sul mio conto, mi raccontarono fosse capitata una scena simile: un giovane cronista aveva trovato Rino sistemato nel suo desk in una sala stampa di un torneo dello Slam e, davanti a un nugolo di colleghi italiani, era andato a stringergli la mano, presentandosi e dicendo che gli sarebbe piaciuto ricevere, da un professionista autorevole come lui, qualche consiglio per proseguire al meglio la carriera. Mi fu detto che Rino, senza muovere un sopracciglio, si fosse girato e gli avesse risposto in questo modo: “Sì, certo: ti consiglio di cambiare lavoro”.
Con quel modo di essere e di porsi, una specie di autodafé tennistica, Rino risultava indubitabilmente carismatico. Nella mia stanza, davanti alla scrivania, c’era una miriade di foto appiccicate una sull’altra: Sampras, Agassi, McEnroe, Arazi, Becker, Edberg, Stich, Gaudenzi, Camporese, Capriati, Muster, Korda, Ivanisevic, Sabatini, Kafelnikov. C’era di tutto. L’unico non tennista era Rino Tommasi, con la giacca grigia, il gelato (il microfono con la gommapiuma) di Tele+2 e quello sguardo definitivo, che ti fissava con una sicurezza implacabile e sussurrava “sto per dirti una cosa che sicuramente è giusta”.
In telecronaca, spesso Clerici ironizzava sui Tommasi-fan, un gruppo di appassionati che, ai tornei, non fermava solo i giocatori per avere un autografo (i selfie non c’erano ancora) ma anche Rino, che accettava sempre di buon grado. Sono abbastanza sicuro che oggi su nessun telefono o sfondo di un tablet campeggi la fotografia di un telecronista di tennis. L’unica eccezione che conosco è un ragazzo che mi scrisse per dirmi che aveva registrato il match point di un eterno quinto set tra Fognini e Monfils al Roland Garros, commentata da me, e l’aveva usato come suoneria del telefono. Ma era un amico di Fognini, non faceva testo.
“Con quel modo di essere e di porsi, una specie di autodafé tennistica, Rino risultava indubitabilmente carismatico. Nella mia stanza, davanti alla scrivania, c’era una miriade di foto appiccicate una sull’altra”.
In tutta franchezza, i suoi articoli li leggevo su «Matchball» ma non altrettanto spesso su «La Gazzetta dello sport» perché, per i quotidiani, scriveva i classici report: ti dico cosa è successo. Precisi, completi, competenti, senza fronzoli: semplicemente, non era la lettura che preferivo. Molto, ma molto raramente i suoi pezzi concedevano spazio alla riflessione o alla divagazione. Semmai, qualche sententia tommasiana qua e là: una volta, dovendo riferire del fatto che in finale di doppio al Roland Garros ci fosse finito il giocoliere iraniano con cittadinanza francese, Mansour Bahrami, aggiunse una riga al fondo del testo: “Ma vi pare una cosa seria”.
Le telecronache, invece, erano tutt’altro discorso. Anzitutto, perché era maestro nel dettare i tempi: non le sommergeva di parole. Diceva ciò che era corretto dire e offrire allo spettatore. Ed erano tutte considerazioni, va da sé, corrette. Una delle sue frasi storiche: “Quando Internet non c’era, Internet ero io” credo renda l’idea, difficilmente c’era risultato o statistica che gli sfuggisse, nonostante l’assenza pressoché totale di supporto informatico. Su tutto, però, numeri e statistiche li sapeva usare. Dopodiché, l’imprevedibilità e il genio colto della favella di Gianni Clerici, molto spesso al suo fianco, erano un’occasione formidabile per ammorbidire certi suoi spigoli e, di riflesso, la narrazione risultava ancora più piacevole. La sua mente matematica immagino si sentisse più autorizzata a poeticheggiare. Non a caso, è dalla televisione che arrivano tante delle sue invenzioni lessicali: dal “regolarista falloso” al “circoletto rosso” (un punto particolarmente bello, che Tommasi segnava sul foglio con un cerchio a biro), dal “periodico basso” (6-2 6-2 6-2, per intenderci) a “palla calante, volée perdente” (o la sua variante: “palla calante spesso vincente”). Non solo erano efficaci ma tradivano una profonda e arguta conoscenza del gioco: non avvertivi il gusto autocompiaciuto della frase a effetto che qualche suo presunto epigono usa oggi nel tentativo di impressionare l’uditorio. Erano parole giuste, che riflettevano un pensiero e una comprensione autentica di ciò che stava succedendo in campo. Amava ricordare che, essendo stato più volte campione italiano universitario di tennis, la circostanza fosse “a conferma del basso livello culturale dei tennisti italiani”.
Era talmente ammirato e seguito che si era guadagnato la libertà di dire e fare ciò che voleva; nel nostro lavoro, è una benedizione rara. Ma sono certo sia sempre stato così. Non ricordo la fonte ma, una volta, raccontò del giorno della sua discussione della tesi di laurea. Un membro della commissione mi pare gli avesse chiesto, in soldoni, che bisogno ci fosse per lui di prendere il titolo, quando già aveva una carriera avviata tra collaborazioni giornalistiche con «Il Messaggero» e «Tuttosport» e la passione per il pugilato, nel quale organizzava riunioni di alto livello. Rino rispose che “oggi il giornale parla di me come del ‘dottor Tommasi’ e vorrei regolarizzare”.
Se devo pensare ai suoi più grandi meriti, non dimenticherei il fatto di aver sprovincializzato il racconto del tennis. Non era campanilistico, non gli interessava “il professionismo di basso livello”, compresi i campionati nazionali, aveva insegnato a una miriade di giovani appassionati a fare il tifo per i campioni stranieri; un po’ perché, dopo Panatta e soci, per decenni di italiani non ce n’erano più stati. Un po’ perché, esattamente come Clerici – che aveva definito “Italopitechi” una masnada di ragazzi che profanarono Wimbledon 1979 facendo un tifo calcistico e sguaiato per Adriano nella sua corsa fino ai quarti di finale, persi disgraziatamente contro Pat Du Pré, ma è un’altra storia – trovava piuttosto mesto doversi ridurre a curvaioli da stadio in uno sport nobile e internazionale come il tennis. Il suo modello di giornalismo era più moderno di quello in cui era vissuto, aborriva la retorica e, saggiamente, pretendeva il più possibile di vivere gli eventi là dove capitavano. Se una partita faceva schifo, in bel modo trovava la maniera per dire che la partita faceva schifo “perché non vendiamo tappeti”, anche se era direttore della rete che lo metteva in onda e non aveva interesse a squalificarne un prodotto. Si trattava di essere onesti: ecco, credo che la sua brutale franchezza fosse una maniera, personale e talora rude ma apprezzabile, di manifestare una profonda umanità. So che ha aiutato tante persone a trovare un lavoro nel tennis, che non lo ha fatto per amicizia ma per stima e, soprattutto, non se ne è mai vantato. Le sue “telechiacchiere” con Clerici – coppia che non sarebbe esistita senza la sua insistenza con Silvio Berlusconi, cui la voce di Clerici pareva del tutto antitelevisiva – erano intrise di esperienze, conoscenze dirette di giocatori e situazioni, intelligenza, arguzia. Non nascondo che, negli anni, qualche volta mi sono sentito a disagio nell’informarmi su Indian Wells da Wikipedia, perché non ci ero mai stato. Rino ha fatto mille volte il giro del mondo e non esiste sito web che possa compensare un paio di occhi, un naso, due orecchie e, se possibile, un cervello. Non a caso, l’unico momento in cui ho avvertito una qualche sua difficoltà è stato quando, negli ultimi anni di lavoro, era stato invaso dal “mare di Internet in cui si può anche affogare”. Le email degli spettatori, l’abuso di numeri e grafiche durante le partite, le cronache chiuso in una cabina in uno studio. Per sua fortuna, Rino ha solo sfiorato l’avvento dei social.
“Non era interessato a una comunicazione che non avesse un significato ben definito o che non comprendesse un’inclinazione personale. Evidentemente, cibo e bevande non rientravano nella categoria delle cose degne di perdite di tempo”.
Una sera, a Wimbledon, di ritorno da una giornata al club – lui commentava per Sky e scriveva almeno due pezzi, uno per «La Gazzetta dello sport» e l’altro per «Il Mattino», io lavoravo per il «Tennis Italiano» – ci trovammo in un ristorante italiano vicino al suo albergo. Lui, Vincenzo Martucci, inviato della «Gazzetta», e io. Quando ordinò genericamente “un primo e un secondo”, e poi ricevette una telefonata e si allontanò per un momento, Vincenzo mi spiegò che si trattava di una delle tante sue abitudini: Rino andava dritto all’obiettivo e si fermava solo se lo riteneva necessario.
Non era interessato a una comunicazione che non avesse un significato ben definito o che non comprendesse un’inclinazione personale. Evidentemente, cibo e bevande non rientravano nella categoria delle cose degne di perdite di tempo. Chiedere “un primo e un secondo” era più che sufficiente.
Dopo il pasto, lo accompagnammo verso l’albergo “così facciamo due passi”, gli dicemmo. “Seicentonovanta”, rispose. Ai nostri sguardi attoniti, con un altro dei suoi ghigni aggiunse: “In realtà gli ultimi li ho interpolati, perché alcuni ragazzi di Verona mi hanno chiesto di fare una fotografia con loro e, per un po’, ho continuato a camminare parlando”. Penso fosse tutto vero, anche quella volta.

Questo testo è un estratto da “Parlare al silenzio. La mania di raccontare il tennis”: ringraziamo l’editore e l’autore per la concessione.