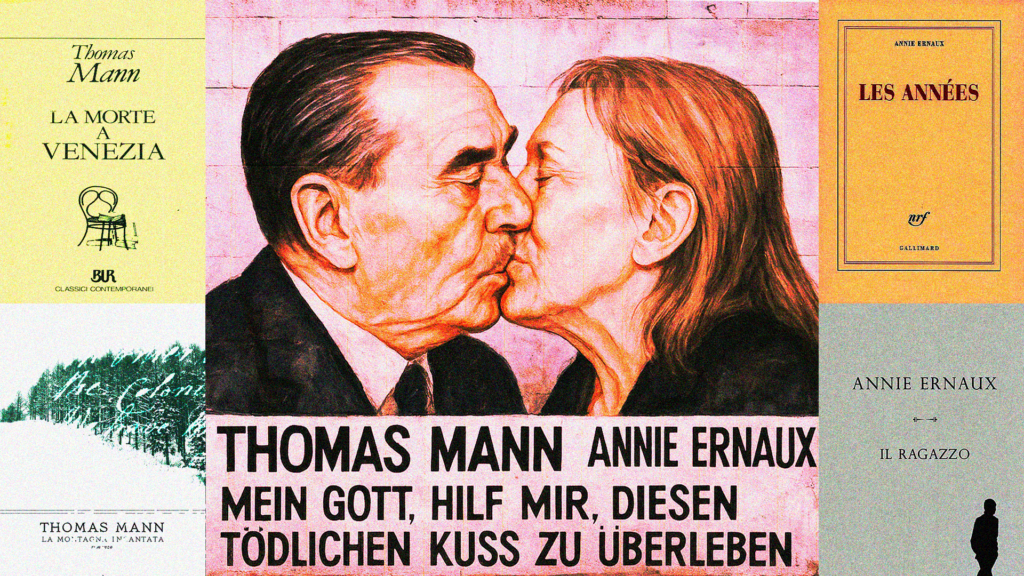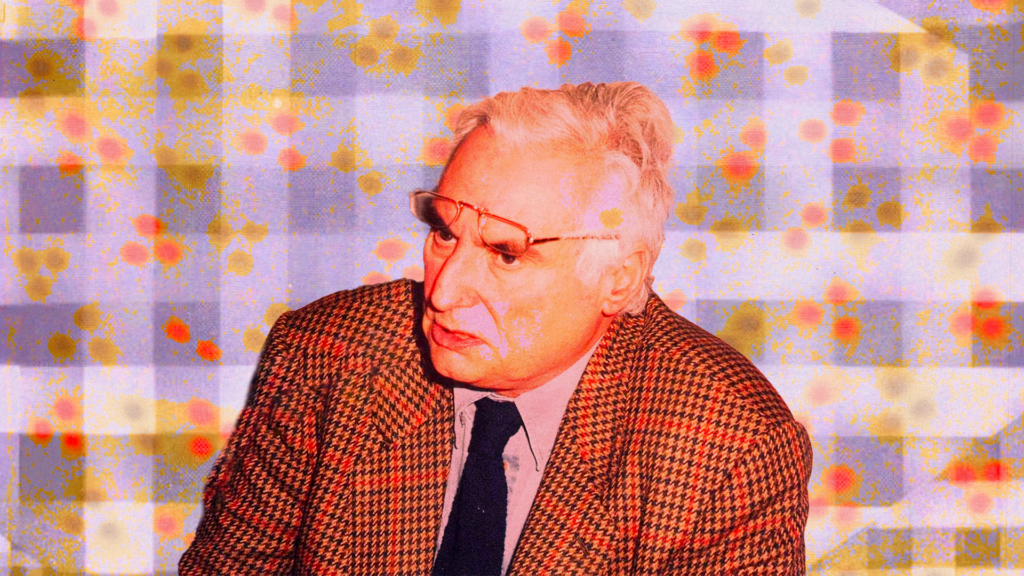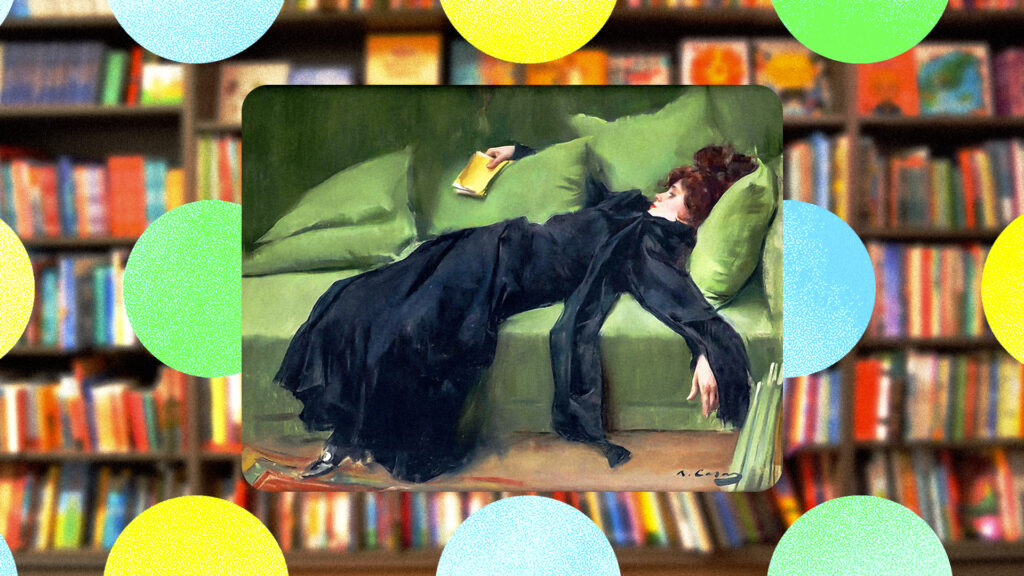Andrea Roventini e Maria Enrica Virgillito
Il caso Stellantis è l’emblema del “capitalismo della rendita”

Le dimissioni del CEO Carlos Tavares hanno certificato le difficoltà di Stellantis. Ma nonostante la crisi produttiva, la scarsa competitività sul mercato e la chiusura di stabilimenti in Italia, negli ultimi anni il gruppo e i suoi azionisti hanno continuato ad accumulare profitti. Una situazione paradossale che riguarda anche altri colossi dell’automotive.
Tanto in Italia si è discusso sui motivi che hanno condotto alla rottura tra il CEO Carlos Tavares, che si è dimesso domenica primo dicembre, e la proprietà di Stellantis. Si è parlato invece meno delle implicazioni simboliche, politiche ed economiche che il caso Tavares comporta. Manager e proprietà d’impresa hanno mostrato, nello specifico, una pressoché totale mancanza di responsabilità sociale, come dimostrano la scelta di non presentarsi ai tavoli negoziali con i sindacati e quella di non riferire in Parlamento sull’accaduto. Di più: l’arroganza di manager e proprietà è stata tale che, mentre si decideva di chiudere lo stabilimento Maserati di Grugliasco, si invitava pubblicamente all’acquisto di automobili di lusso come reazione alla crisi del settore. Tuttavia, l’operato dell’ex CEO Tavares e le vicende di Stellantis esemplificano i tratti di un capitalismo contemporaneo nel quale il potere manageriale e quello finanziario non sono contestabili nelle loro scelte e nelle implicazioni che esse comportano, persino se hanno un notevole impatto sui lavoratori, la società e la stessa profittabilità di lungo periodo delle imprese.
Già nel 2021, anno di nascita di Stellantis, Tavares aveva subito mostrato forti perplessità nei confronti dell’elettrico, con dichiarazioni che esprimevano una scarsa volontà di investire in quella tecnologia, a suo dire a causa dell’assenza di domanda. Di certo, è vero che il mercato dell’elettrico in Italia è poco appetibile per i produttori. A settembre 2024, qui da noi la quota di mercato delle auto BEV (Battery Electric Vehicles) era del 3,84%, contro quote a due cifre negli altri paesi dell’Europa, eccetto la Spagna, che si attestava al 4,84%. In Olanda le auto elettriche sono il 31,54% del totale, in Belgio e Regno Unito il 25,60% e il 17,26% rispettivamente. Poi la Francia con il 16,8% e la Germania con il 12,72% (dati Motus-e). Dal rapporto dell’associazione degli operatori industriali per la mobilità elettrica, si evince tuttavia anche una chiara relazione tra la scelta di un auto elettrica e il reddito pro-capite. I cinque modelli più venduti includono Tesla (Model 3 e Y), Volvo X30, Jeep Avenger e BMW IX1. Quando si osservano le regioni di vendita, il top delle immatricolazioni si registra in Lombardia e Trentino Alto-Adige, due delle regioni più benestanti del Paese, e tra i modelli più venduti ci sono Tesla (Model 3 e Y), Volvo X30, Jeep Avenger e BMW IX1, tutte auto di segmento D. Alcuni osservatori del settore automobilistico ritengono che l’auto elettrica sarebbe ben accolta in Italia se fosse meglio supportata da incentivi. Infatti, nel giugno 2024, sono bastate solo 9 ore perché i circa 200 milioni di incentivi attivati dal MIMIT fossero esauriti dai consumatori (incentivi destinati pure ad auto con motori endotermici “puliti”, in sfregio alla decarbonizzazione). L’effetto redistribuivo di tali incentivi è verosimilmente regressivo, dato che le auto elettriche sono un prodotto destinato alla fascia medio alta di acquirenti, e che soltanto un quarto di chi beneficiava degli incentivi rientrava tra persone a basso reddito ISEE. Le difficoltà per le classi meno agiate ad acquistare una BEV derivano da un quadro economico dove i salari reali non crescono da più di trent’anni (fonte OCSE), mentre la disuguaglianza cresce incessantemente. Non a caso, nell’ultima audizione di Tavares al Parlamento la richiesta di incentivi per supportare la domanda non è mancata.
Indipendentemente dall’elettrico, la produzione italiana non è mai stata al centro degli interessi e delle strategie di Stellantis. Lo dimostra la fusione con FCA, con l’AD del gruppo designato da PSA, lo stato francese presente nell’azionariato attraverso Bpifrance, e la sede legale istituita nei Paesi Bassi (come Exor, la holding controllata dalla famiglia Agnelli). Non a caso, il «Financial Times», ai tempi, si riferiva all’operazione come a un’acquisizione di FCA operata da PSA. Nel 2021, Tavares, nonostante negli ultimi tempi, smentendo se stesso, avesse espresso una predisposizione favorevole di Stellantis nei confronti dell’elettrico, dichiarava alla Reuters come la transizione fosse un’imposizione esterna che avrebbe condotto a un aumento del costo di produzione del 50%, una percentuale impossibile da trasferire sul prezzo di vendita. Già all’inizio della “fusione” con FCA era chiaro all’ex AD di PSA che la produzione all’elettrico avrebbe comportato perdite di occupati e produzione.
La previsione, non sorprendentemente, si è ampiamente avverata per l’Italia, Paese diventato via via sempre più periferico nelle strategie del gruppo. Il calo strutturale del numero di veicoli prodotti in Italia è ormai un dato incontestabile: il volume di auto prodotte è passato da circa 1400 unità nei primi anni Novanta a circa 470 nel 2022.
“Indipendentemente dall’elettrico, la produzione italiana non è mai stata al centro degli interessi e delle strategie di Stellantis”.
Il calo di produzione è frutto di processi di delocalizzazione, di disinvestimento, di una spinta accelerata alla fuoriuscita degli occupati e del ricorso ad ammortizzatori sociali. La produzione italiana rappresenta ad oggi il 5% della produzione totale di Stellantis. Il piano di produzione del gruppo, annunciato nel 2022, prevedeva 75 modelli BEV (diventati 45 nel 2024) per un volume di vendite di 5 milioni di veicoli; 30 miliardi di investimenti e una gigafactory a Termoli. Nonostante i piani annunciati nel 2022, ad oggi, nel 2024, tutti gli stabilimenti italiani riportano delle contrazioni (ma non, ad esempio, alcuni stabilimenti all’estero, come quello di Orano in Algeria, dove si produce la 500 ibrida).
Se le vicissitudini produttive dimostrano la difficoltà del gruppo a competere sui mercati internazionali – come testimoniato anche dall’accumulazione di scorte di invenduto negli Stati Uniti, e da un ultimo trimestre con cali del 27% delle vendite – l’accumulazione dei profitti di Stellantis e la distribuzione dei dividendi non sembrano tenerne conto: 18,6 miliardi di euro i profitti nel 2023, con un aumento dell’11% rispetto all’anno precedente, e distribuzione di dividendi agli azionisti per circa 6 miliardi.
Come è possibile arrancare in termini produttivi sul mercato reale e nello stesso tempo registrare profitti crescenti? Il settore dovrebbe trovarsi, anche a detta delle dichiarazioni di molti dei CEOs in grave crisi, tale da provocare perdite, e non accumulazione di profitti. Tuttavia, Stellantis è in buona compagnia: nel 2023, anche VW (18 miliardi), Mercedez-Benz (14.500), BMW (12 miliardi) hanno visto crescere i loro profitti.
PRODURRE MENO AUTO, MA PRODURLE DI LUSSO
È possibile identificare tre meccanismi che portano alla divaricazione tra la dinamica produttiva e l’accumulazione di profitti. Il primo è un semplice meccanismo di mercato che si chiama strategia di mark-up: consiste nel privilegiare il prezzo per prodotto rispetto all’obiettivo del volume delle vendite. Ciò implica che si producono meno pezzi, si aumenta il prezzo unitario e dunque i margini unitari.
Le quote di mercato si riducono, ma i profitti aumentano. Tale strategia è molto chiara nelle scelte perseguite dalle imprese nella fase post-covid. Si manifesta in una chiara ricomposizione produttiva verso le auto di alta gamma, dalla fascia D (berline grandi) in su, riducendo progressivamente l’offerta delle auto del segmento A (mini-cars), B (utilitarie), C (berline medie), rendendo l’auto un prodotto di lusso, che più che permettere la mobilità in senso stresso, promette “un’esperienza di guida”, resa più attraente dall’inserimento di tecnologie di realtà aumentata. Il nuovo paradigma dell’auto sembra quindi escluderne la diffusione di massa, e il suo acquisto comporta molto spesso la necessità di accendere prestiti finanziari. L’auto sta subendo un processo di suvvizzazione: modelli dalle dimensioni più grandi rivolti a chi ha maggiore potere di acquisto, come dimostra il prezzo medio di un suv, salito dai 21k euro prima del COVID, ai 28k di oggi.
Questa risemantizzazione del mezzo di trasporto di massa in mezzo di trasporto per le élite, comporta conseguenze negative sulla sicurezza stradale dei pedoni, sulle emissioni di gas serra, sulla vivibilità delle città.
“L’auto sta subendo un processo di ‘suvvizzazione’: modelli dalle dimensioni più grandi rivolti a chi ha maggiore potere di acquisto, come dimostra il prezzo medio di un suv, salito dai 21k euro prima del COVID, ai 28k di oggi.”
Pertanto, produrre meno auto (e concentrarsi sul segmento premium, soprattutto BEV) e venderle a prezzi più alti è il primo meccanismo di accumulazione di profitti. Uno degli argomenti più utilizzati per giustificare l’assenza di investimenti in Italia è quello dell’aumento dei costi di produzione e dell’energia. Tuttavia, occorre verificare non soltanto quanto i produttori subiscono l’aumento dei costi energetici, ma in che misura trasferiscono gli aumenti di tali costi sui consumatori con aumenti dei prezzi finali. Ad esempio, un’analisi sull’economia americana pubblicata sulla rivista «Monthly Labour Review» nel 2023 racconta di una chiara evidenza: i dealers, attraverso il management delle scorte, hanno contribuito all’aumento dell’inflazione totale, e hanno registrato tra il 2019 e il 2022 un aumento del mark-up rispetto agli anni pre-covid del 150% (circa). Dall’articolo si evince chiaramente come la differenza tra il prezzo alla produzione (PPI) e il prezzo al consumo (CPI) sia influenzato dal ruolo degli intermediari con un trend di mark-up crescente fino al 2022. La differenza tra PPI e CPI continua invece ad essere persistente, anche dopo il calo del costo dell’energia nel 2022, e qui la nuova strategia che prevede la produzione di meno auto, ma più grandi e a prezzi più alti, diventa quella dominante.
LA FINANZIARIZZAZIONE DEL SETTORE AUTO
Il secondo meccanismo che permette accumulazione di profitti nonostante la riduzione delle quote di mercato e delle auto prodotte è rappresentato dal processo di finanziarizzazione del settore. La collocazione di Stellantis come soggetto finanziario e finanziarizzato si evince già dal suo sito web, in cui è presente una sezione “Investors” con una “dashboard” che mostra in tempo reale le quotazioni in borsa del titolo. Dalla dashboard è ben evidente come il prezzo per azione nella borsa di New York fosse di circa 14 dollari nel gennaio del 2021, e, dopo il picco di 29 dollari raggiunto nel marzo del 2024, sia precipitato fino a raggiungere circa 13 dollari in questi giorni. Un raddoppio del prezzo azionario in 3 anni rappresenta certamente un risultato di grande prestigio per il management, ma come si spiega? Analisti finanziari sentiti su «Forbes» già all’inizio del 2024, prima della crisi del prezzo in borsa, esprimevano incertezza rispetto alla vaga strategia di Stellantis, che continuava a ottenere alti profitti, ma accumulando enormi scorte già a partire dall’ultima metà del 2023. Secondo tali analisti è chiaro che Stellantis non abbia una strategia produttiva chiara. Nel febbraio 2024, gli analisti di HSBC scrivevano che l’unico obiettivo perseguito con costanza a partire dalla creazione del gruppo è stata la riduzione dei costi, ma la sostenibilità di tale strategia sarebbe stata presto messa a rischio. Gli investitori impazienti non si sono fatti attendere e il titolo è quindi crollato da marzo 2024. Stellantis ha retto nella fase post-covid 2021-2023, grazie all’alta domanda causata dai blocchi della catena di produzione e dall’accumulazione di risparmio durante la pandemia. A mercato normalizzato, ha subito un rimbalzo negativo, accumulando invenduto nonostante riducesse la produzione di auto.
LA RIDUZIONE DEI COSTI DEL LAVORO
Il terzo meccanismo che ha permesso accumulazione di profitto è stata la già menzionata strategia di riduzione dei costi, in particolare quelli del lavoro. Un riduzione di posti di lavoro si era già registrata in termini strutturali, da 281 mila nel 2021 a 258 mila nel 2023. Tagli a posti di lavoro sono stati annunciati a Detroit per 1.100 unità a seguito della crisi da sovrapproduzione negli Stati Uniti, e anche a Luton (UK) la riduzione è di 1.100 posti di lavoro. In Italia, licenziamenti sono già in arrivo per l’indotto. Per chi conosce però l’operato in passato di FIAT, poi FCA, la notizia non appare certo sorprendente. Gli studi del settore dell’auto in Italia e delle relazioni e condizioni di lavoro nella fabbrica documentano da anni chiare tendenze di contrazione occupazionale, che soltanto una politica sorda, cieca e anche compiacente, non ha voluto rilevare. Ad oggi Stellantis occupa circa 47mila dipendenti, con tendenze di declino dovute alle dimissioni volontarie e un accesso strutturale alla cassa integrazione, che ha costi rilevanti non irrisori per la collettività – si calcola quasi un miliardo dal 2014 ad oggi. Inoltre, le condizioni di lavoro sono strutturalmente peggiorate nella fabbriche dell’auto italiane, con l’inserimento della metodologia del World Class Manufacturing (WCM), sistema di “lean management” solo in teoria volto a rispondere alla variabilità di mercato e ad aumentare la qualità del processo produttivo. Il WCM ha rappresentato un fallimento sia in termini di guadagni di efficienza, sia per le condizioni di lavoro in fabbrica. Tavares ha sancito la fuoriuscita dal WCM nel 2021, proponendo un nuovo modo di produzione che della filosofia del lean management mantiene soltanto la riduzione dei costi. Il fallimento del paradigma del lean management applicato in FIAT si traduce in modo molto chiaro nell’aumento dei tempi di saturazione e nella perdita di controllo sul processo produttivo. Alla traiettoria di un aumento di controllo tecnico e manageriale sulla forza lavoro, si è accompagnato una chiara mancanza di investimenti tecnologici e ritardi nei nuovi modelli, e una costante predilezione per i risultati finanziari rispetto a quelli produttivi.
Purtroppo Stellantis non è un caso a sé stante, ma la manifestazione di un modello produttivo in larga parte estrattivo e muscolare, che usa strumentalmente il mercato e la competizione internazionale per avanzare minacce alla stabilità occupazionale, chiedendo quindi “sacrifici” ai lavoratori per migliorare la competitività aziendale (si ricorderà il Referendum a Pomigliano d’Arco sotto la gestione di Marchionne) in cambio di produzione di modelli e conservazione dei posti di lavoro. Ai governi si chiedono incentivi e supporto con cassa integrazione, ai clienti prezzi sempre più alti per i singoli modelli, e alla proprietà e agli investitori finanziari si distribuiscono profitti. Tuttavia, la relazione tra settore dell’auto e finanza in Italia nasce già negli anni Ottanta, quando l’Avvocato Gianni Agnelli designava Cesare Romiti come AD, quest’ultimo tra i principali organizzatori della marcia dei 40mila a Torino, che ha sancito un cambio di passo delle relazioni industriali in Italia. La vittoria di Romiti su Ghidella è stato il primo passo della trasformazione di FIAT da un’impresa volta all’innovazione e alla produzione di nuovi modelli ad una focalizzata ai profitti di breve termine. Ad oggi l’Italia e l’Europa si trovano ad affrontare una gravissima crisi del settore dell’auto. Chiedere alla proprietà e al management delle case automobilistiche responsabilità sociale per il proprio operato diventa sempre più urgente, così come impedire delocalizzazioni selvagge, garantire il reinvestimento dei profitti accumulati, assicurare partecipazione alla collettività con una maggiore tassazione sui profitti e una ancora più elevata e progressiva sulle rendite. Ciò richiede un nuovo ruolo dello Stato che oltre a intervenire fiscalmente dovrebbe promuovere concretamente politiche industriali per il settore automotive, inasprire le norme sulle delocalizzazioni, introdurre nuove procedure per la gestione delle crisi aziendali che offrano ai lavoratori la possibilità di orientare il processo produttivo, e irrigidire il mercato del lavoro limitando il lavoro temporaneo e introducendo il salario minimo. Ma la politica vuole veramente cambiare il suo ruolo per salvare l’industria automobilistica italiana?
Andrea Roventini
Andrea Roventini è professore ordinario di economia politica alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e research fellow all’Ofce, Sciences Po (Francia).
Maria Enrica Virgillito
Maria Enrica Virgillito è professoressa associata in Economia alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.
newsletter
Le vite degli altri
Le vite degli altri è una newsletter che racconta di vite che non sono la nostra: vite straordinarie, bizzarre o comunque interessanti.
La scriviamo noi della redazione di Lucy e arriva nella tua mail la domenica, prima di pranzo o dopo il secondo caffè – dipende dalle tue abitudini.
Contenuti correlati