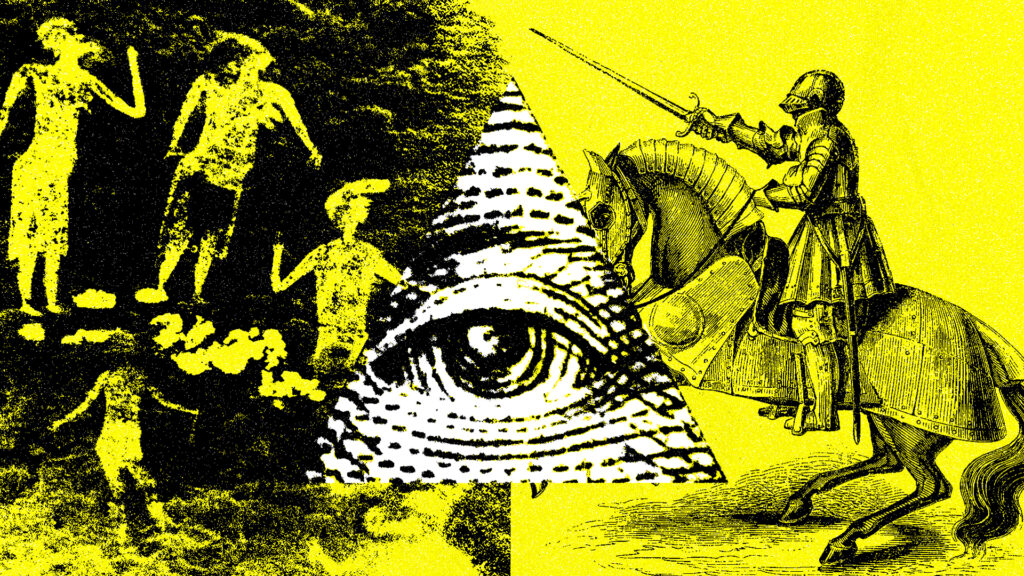Francesca Sabatini
Il primo viaggio da sole è indimenticabile

Per le donne viaggiare in solitaria è ancora un'esperienza sorprendente. Lo sguardo e il corpo leggeri, il paesaggio che si sfrangia dietro di sé, mentre all'orizzonte, oltre le molestie velate, gli atti di gentilezza e le relazioni stravaganti, si staglia la sensazione che la libertà sia molto più vicina di quanto non sia mai apparsa prima.
Questa è la storia di un viaggio in bici da Bordeaux a Roma: 1500 km in 29 giorni a bordo di una favolosa bici gialla degli anni ’90. È la storia di una ragazza che, per ventiquattro anni, non è riuscita a imparare la bici e poi, un giorno, sotto la neve di rue Lafontaine, ha fatto una prima, arrischiatissima, pedalata su una brutta pieghevole rosa.
Questa storia racconta come la scarsa confidenza di un corpo femminile con lo sforzo e l’equilibrio dinamico possano ribaltarsi nel desiderio di un viaggio in solitaria per il sud della Francia con tenda, consigli di amici e tanta inesperienza. Un viaggio per rallentare un ritorno faticoso: prendere tempo e fare spazio, sfruttando la distanza come occasione per distendere i pensieri. Un viaggio per esplorare i limiti, giocarci, spostarli ogni giorno un chilometro più in là: scoprendo la forza e la solitudine di un corpo che può portare se stesso e tutto il resto che gli serve.
Questa storia non racconta tutto il viaggio: nostalgica e cattivella, non ha ancora trovato le parole per riportarmi a casa. Mi tiene in ostaggio, col pedale fermo, alla frontiera.
Sette, otto anni forse, pineta della Feniglia, Porto Ercole. Ho un cappellino di paglia rosa calcato in testa. Pedalo forte sulla bici con le rotelle troppo piccole per me: le ginocchia mi arrivano quasi in bocca. Dietro di me, i miei genitori sulle loro bici adulte. Un gruppo di ragazzini della mia età o forse più grandi viene dalla direzione opposta. Li sento guardarmi a lungo, so che rideranno.
Non so andare in bici: non ho mai imparato e non imparerò per molto tempo.
Tredici anni, forse quattordici, nel comprensorio in cui abita la mia amica, a Roma. Villini, siepi, gradini di marmo. Lampioni, felci, portieri notturni. Signore filippine che portano i cani, la spazzatura, la spesa, e sempre chiamano un fidanzato. Odore di sughi pesanti, umidità, molto silenzio. Flaminia e la sua amica Claudia, le loro bici, le salite e le discese. Loro che ridono, io che non ci sto neanche provando.
Ventuno anni, papà, domenica di maggio. Villaggio Olimpico, Roma. Riesco a fare qualche curva, larghissima. Sono tesa, rigida. Dolore ovunque, nervi tesi. Papà non insiste, io che invece devo essere insistita. Non concludo niente e mi arrabbio con loro: genitori indolenti che non ci hanno provato abbastanza.

Bordeaux, ventiquattro anni. Città piana piccola poco trafficata, fastidiosamente ciclabile. È una mattina di ottobre quando per la prima volta metto piede da Musette, una caffetteria-ciclofficina. Christopher e Robert fanno caffè e dolci, riparano bici, sono inglesi e molto belli. Hanno appena aperto, stanno ancora finendo di arredare, possono solo farmi un caffè. Stranamente, gli dico subito che non so andare in bici. Increduli e divertiti, mi dicono: ti insegniamo un paio di domeniche, la mattina presto sui quais.
La prima bici che mi hanno dato era una pieghevole rosa, Easy. Era febbraio, l’unica settimana dell’anno che aveva fatto neve. Chris era preoccupato: la strada ghiacciava e io ero davvero incapace. La bici però mi dava sicurezza: era minuta e così stavo seduta col baricentro basso. L’equilibrio veniva facile.
La prima volta che sono andata in bici sola aveva appena smesso di nevicare, avevo lasciato Chris e il mio zaino all’inizio di rue Lafontaine. Piangendo e ridendo gli avevo urlato don’t look at meee, sapendo che sarebbe restato lì, piantato, immobile in mezzo alla strada, in apprensione, così simile a mio papà.
Easy una notte sfortunata me la rubarono. Piansi, mi arrabbiai tantissimo. Il mio coraggioso travagliato sofferto inizio era stato violato. In realtà, fui anche molto sollevata. Forse quella storia angosciosa si era naturalmente conclusa.
Avevo spiegato ai Musette del mio ipotetico futuro e condizionale progetto: partire da Bordeaux in bici, tornare a Roma pedalando. Pochi giorni dopo, i Musette mi avevano chiamata dicendo: come, we’ve found the good one. Avevano comprato una Mercier Trekker Rider usata con cambio a undici marce e tre rapporti. Una bici da viaggio solida e gialla: un po’ scanzonata, da gita di famiglia. Uno strana combinazione di extravagant sicurezza.
Non so ricostruire il momento in cui ho deciso di partire. Forse il giorno che ho capito Mercier, portandola sopra l’ottava marcia, là dove diventa robusta e leggera, così simile a una nave. O forse quando, cadendo, mi sono storta una caviglia e all’ospedale ci sono andata con lei. È stato un giorno semplice e incredibile quello in cui sono entrata da Musette con i soldi in mano. Urlavo: fammela comprare prima che cambio idea. Chris non ha mai parlato italiano, ma era pronto in cassa. Scuoteva la testa, simile a mio papà.
Decisi di partire il 3 giugno e la sera prima salutai gli amici. Fu lì che capii che non avevo assolutamente capito cosa stavo per fare. Durante una cena al ristorante senegalese, ci abbracciammo e mi regalarono un quaderno di disegni, pensieri e auguri. Thomas aveva scritto solo: capire il viaggio.
Quella sera, con lo stomaco contratto, feci i pacchi eliminando il superfluo. Sulla bici avevo la tenda, il sacco a pelo, le borse per cibo e vestiti. Un asciugamano, il carica batterie e la batteria ausiliaria. Strumenti e pezzi di ricambio per Merci, soldi, mappe, creme, poche medicine. Un diario, un libro, la macchina fotografica e una pallina da tennis per massaggiare la schiena.

Lasciare Bordeaux in bici non fu niente di eccezionale. Uscendo dalla città, avevo pensato di fare una foto con la bici carica sul pont de Pierre che collega il centro alle campagne. Guardandolo sulla carta, sembra l’imbuto che espelle la città nelle vigne. Troppo presa dall’alba anonima di quel giorno, non scattai la foto. Stavo per tornare indietro quando si manifestò una delle poche regole che avrebbero orientato l’andare: mai tornare indietro. Le decisioni, in viaggio, sarebbero scaturite da un lento, circolare, ossessivo persistere su un’idea, un’immagine, una parola. Scomporla, fissarla, ascoltare l’eco che produce. Avrei poi scoperto che pedalare genera un ritmo che ha qualcosa di ossessivo. E quel che affiora dall’ossessione ha qualcosa di inevitabile.
Quel giorno con Christopher pedalammo 70 chilometri: una prima, ottima, lunga tappa. La destinazione era il castello di un discografico inglese che aveva lasciato Londra per vigneti, jazz e donne filiformi. Dieci stanze da letto, cinque bagni, due cucine. Due ettari di filari, musica diffusa, vetrate, tessuti damascati. Un posto sospeso, percorso da vento leggero e strane angosce.
La mattina dopo, a un incrocio, io e Chris facemmo quella cosa che è salutarsi. Lui tornava a Bordeaux, io proseguivo per il canal du Midi: l’imponente infrastruttura idraulica che allaccia l’Atlantico al Mediterraneo. La mia traccia semplice, piana e ombreggiata per arrivare alla costa. Alla curva dopo, ero ferma leggendo una lettera di Chris e cercando di piangere. Non era facile, tenendo la bici con tutto il peso sopra.
I primi tre giorni furono un volo. Settanta, ottanta, ottantacinque chilometri al giorno. Le gambe erano fresche e io poco capace di dosare le energie. Mi sentivo più forte di quello che pensavo: avevo meno sete e più fame, meno foto da fare e più chilometri da mangiare. Il giorno della partenza aveva cominciato ad abbattersi un orage alerte jaune, una tempesta di pioggia violenta. Sapevo che ci stavo andando incontro, ma pensavo che si sarebbe spostato prima di me. Invece, a sud di Tolosa fui io a raggiungerlo.
Smottamenti e frane, fango dappertutto. Le mie sacche erano impermeabili, così cibo e vestiti restavano più o meno all’asciutto, mentre io me la prendevo tutta. Per un paio di giorni fu doccia interminabile. Procedevo lentissima per il fango, la paura di scivolare. Dentro all’impermeabile scadente sudavo. Quando mi fermavo le scarpe cacciavano acqua: bianchissime e molli, facevano gni gni. Stare per ore sotto secchiate di pioggia torrenziale mi faceva, in fondo, molto ridere.
“Le decisioni, in viaggio, sarebbero scaturite da un lento, circolare, ossessivo persistere su un’idea, un’immagine, una parola”.
È in mezzo a quella difficoltà che ho iniziato a capire il viaggio: non riuscivo a fermarmi, non potevo aspettare. Mentre bevevo pioggia e strizzavo gli occhi, mentre cambiavo strade, smontavo i pacchi e mi incollavo la bici a spalla, mentre scansavo fronde e colline franate, capii che avevo una sola cosa da fare: andare.
Se lasciare Bordeaux non era stato niente di eccezionale, arrivare al mare fu eroico. Alla fine della pioggia, oltre le radici dei platani e la strada viscida di foglie, al di là delle chiuse e dei giardini ordinati di una provincia minore, si apriva la costa: mi attendeva un sole. Caldo, secco, fortissimo sole. Fu arrivo e conquista. Dalle campagne del nord-ovest, ero scesa al Mediterraneo.
Arrivate ad Agde, la cittadina in cui il Canal du Midi sfociava in mare, eravamo tanto infangate che la ghiera del cambio si inceppava e la catena usciva di continuo. A una fontana, sotto gli occhi increduli della gente, lavai Merci e ci posai su una panchina al sole. Io e Merci sedute ad asciugarci: lei e me, io e lei, coperte di fango, stremate, maleodoranti.
Quel pezzo di costa occitana si rivelò come un susseguirsi di infrastrutture della vacanza. Edifici multipiano, palme e cemento delle ferie. Cartelloni, sconti e famiglia. Ruote panoramiche, borse di plastica, insalate niçoise. Molta famiglia costretta nelle canotte a righe. Aree camper e postazioni barbecue, creme solari, parole crociate. Teli e cosce che si spartivano lo spazio minimo del mare urbanizzato. Piattaforme di legno e reggaeton, cremolati, vaniglie, granatine. Creme e zuccherini, vecchie con l’alluce valgo e pizzi, superfici riflettenti poco coprenti. Dai vetri in plexiglas degli stabilimenti, si intuivano pranzi di pesce con vino in ghiacciaia, i crudi e les frites.
Entrando nella terza settimana cominciò un altro pezzo del viaggio: la grande corsa. Mi scoprivo forte e decisa. Stavo bene, molto meglio dei primi giorni: ero affamata di strada, le gambe toste, il fiato espanso. Il tempo: lungo. Lo spazio: possibile. La frontiera non era, ma sembrava, vicina. Allora tracciai una linea, senza troppo pensare alla qualità dell’andare. Fino a quel momento ero stata fortunata: il canal du Midi era stata l’ottima infrastruttura di un viaggio piano e lieve, per quanto bagnato. Da lì in poi scelsi e piansi la Route Nationale 7, un incubo a scorrimento veloce accompagnato dai clacson e gli allucchi degli automobilisti, arrabbiati o eccitati per il mio corpo a bordo strada. Io non rispondevo e non reagivo: per due giorni, misi la musica e scesi in apnea. Riconoscevo il passaggio delle macchine da un venticello leggero cui seguiva un risucchio forte e deciso: una sensazione di vuoto davanti cui dovevo farmi trovare pronta e salda.
Per un paio di giorni rimasi nel cuore anonimo di una Provenza di piccoli centri e grandi magazzini. In quel momento divenne chiaro un altro umore del viaggio: non avevo più voglia di parlare. Invece delle persone, mi piaceva stare tre le cose: Mercier e la macchina fotografica mi calavano in un paesaggio sintetico e affatto umano.

Senza che me ne rendessi conto, la grande corsa mi portò alla Costa Azzurra.
Il 18 giugno fu il giorno in cui scoprii di poter fare 80-100-120 chilometri. Per la seconda volta giungevo a un mare bellissimo e inabitabile. Una costa asfissiante di cemento, plastiche e vetrate. Cannes fu il colpo fatale che mi tramortì: SUV, limousine, clacson, buste enormi di negozi costosi. Occhiali da sole e cappelli giganti. Gioielli di lusso, palme narcotizzate e siepi geometriche. Corsi così tanto e così duro da essermi dimenticata il resto.
Dormii nella mansarda di una famiglia caotica e gentile. La mattina dopo, le gambe bruciavano più del sole, Nizza era veramente rumorosa e io sentivo di dover scappare. Ero completamente assorbita dal viaggio, dalla imperiosa e seducente necessità di andare. Quel giorno sarebbe stato il giorno della frontiera, ormai vicinissima: una calamita irresistibile, un boccone troppo buono, una liberazione inevitabile.
Inforcai la bici a mezzogiorno, il sole spaccava l’asfalto e io avevo le gambe di pietra. Fu un semaforo a metà di una salita il presagio della follia in vista. A metà di un vialone di raccordo a quattro corsie, un rosso mi fermò. Il sole sopra di me, le macchine calde affianco a me, la bici pesantissima sotto di me, la strada molto più che obliqua davanti a me: la partenza fu una caduta. Rotolai a terra con tutti i pacchi, la catena mi venne addosso e le macchine suonarono in francese. Piansi, mi rialzai e ripartii. Ogni pedalata era un pugno alle cosce, avanzavo così piano che la bici sbandava: sembrava chiedermi, ma che fai. Mi guardai attorno e vidi che Nizza si sviluppava, in effetti, su dei colli.
Uscire da Nizza fu come addentrarsi in un’isola mediterranea: il centro urbano si disperdeva in colline tortuose piene di ville, glicini e salsedine. Dopo la città si apriva, finalmente, una costa stupenda. Nelle gambe e nel fiato conobbi una costa irregolare, che cambiava idea. Finita la linea di spiaggia, iniziava la roccia. Svolta dopo svolta, seguii una costa frastagliata che s’insenava, straripava, spariva: poi si calmava e tornava morbida, comunque piena di dislivelli, esposta, assolatissima. Era la famosa moyenne Corniche ed era veramente bellissima. Lungo questa strada scavata nel canyon rosso a strapiombo sul mare, mi fermai più volte.
All’incrocio tra lo sconforto, l’accecante bellezza e un invincibile desiderio di arrivare, mi ripetevo le parole che Robert mi aveva detto la sera prima di partire: dig deep, follow your heart, believe in yourself, you’re not alone.
“Rotolai a terra con tutti i pacchi, la catena mi venne addosso e le macchine suonarono in francese. Piansi, mi rialzai e ripartii”.
Robert mi spinse fino a Menton e, poco dopo, la frontiera si palesò come un’ovvia e semplice infrastruttura di transito: un ingranaggio articolato di controllo dei flussi. Un vecchio ponte a quattro archi di cemento, barriere di acciaio e segnaletica sparsa. Uomini in uniforme e molto caldo assediavano una lunga fila di macchine col motore spento, le portiere aperte e i documenti pronti.
Era il 19 giugno: ero arrivata in Italia in poco più di due settimane. Molti si aspettavano, in fondo, che mi fermassi lì. Mia madre da giorni mandava screen di treni regionali. Sembrava la fine naturale di quell’avventura un po’ improbabile. Eppure, quella mattina di martedì l’aria era rotonda, Merci stava una favola e le gambe, dopo dislivelli impegnativi, erano di nuovo leggere.
Passare la frontiera successe come un fatto banale. A mezzogiorno di quel martedì di giugno, seguii i cartelli: frontière, Poste de Police, Italie. In mezzo a quel cemento anonimo che segnava l’arrivo in Italia, vidi gli occhi semplici e seri di Thomas che prima di partire mi aveva scritto: capire il viaggio.
Passare la frontiera fu una lunga frenata senza sosta. Guardarmi attorno, sospendere tutto, pensare: sono nel mezzo, nella cerniera. Singhiozzo, Italia. Spingere il pedale non fu proprio una decisione, ma l’ovvia conseguenza dei fatti. Semplicemente, la strada continuava.
Cosa successe in Italia è una storia a parte che dimora nelle profondità di un viaggio in solitaria. Una storia di silenzi enormi, fame sorda e lunghissime campagne che ancora non so scrivere. Forse perché una parte di me è ancora lì, tra le cicale e il giallo dei campi a luglio, e non si arrende a tornare.
Francesca Sabatini
Francesca Sabatini è geografa. Fa ricerca su aree interne, turismo e metodi itineranti. Ha scritto articoli per riviste scientifiche e culturali. Fa parte del collettivo di ricerca indipendente Emidio di Treviri
newsletter
Le vite degli altri
Le vite degli altri è una newsletter che racconta di vite che non sono la nostra: vite straordinarie, bizzarre o comunque interessanti.
La scriviamo noi della redazione di Lucy e arriva nella tua mail la domenica, prima di pranzo o dopo il secondo caffè – dipende dalle tue abitudini.
Contenuti correlati