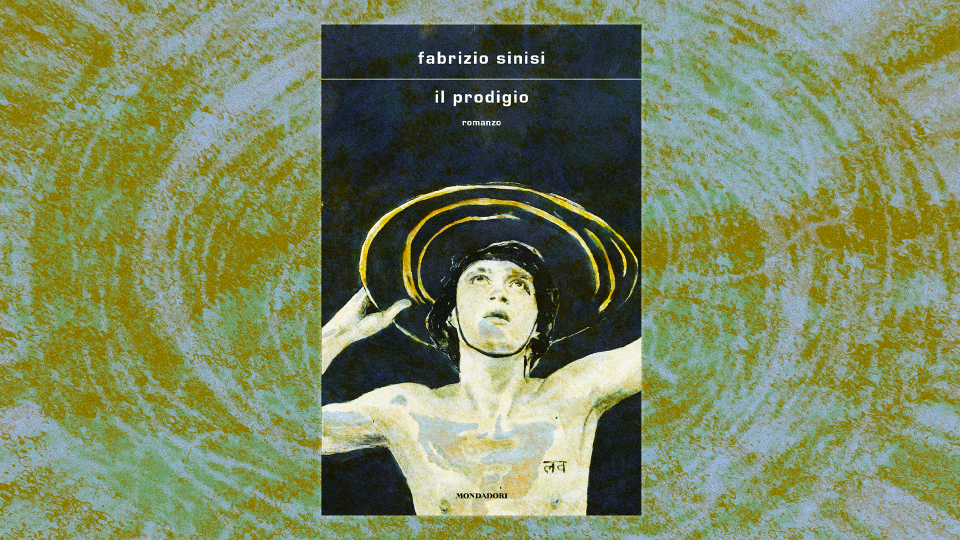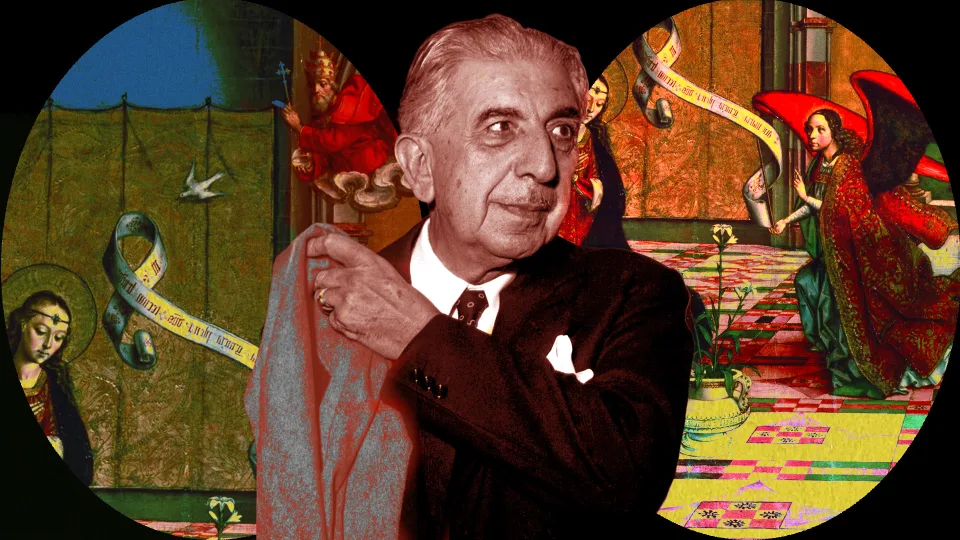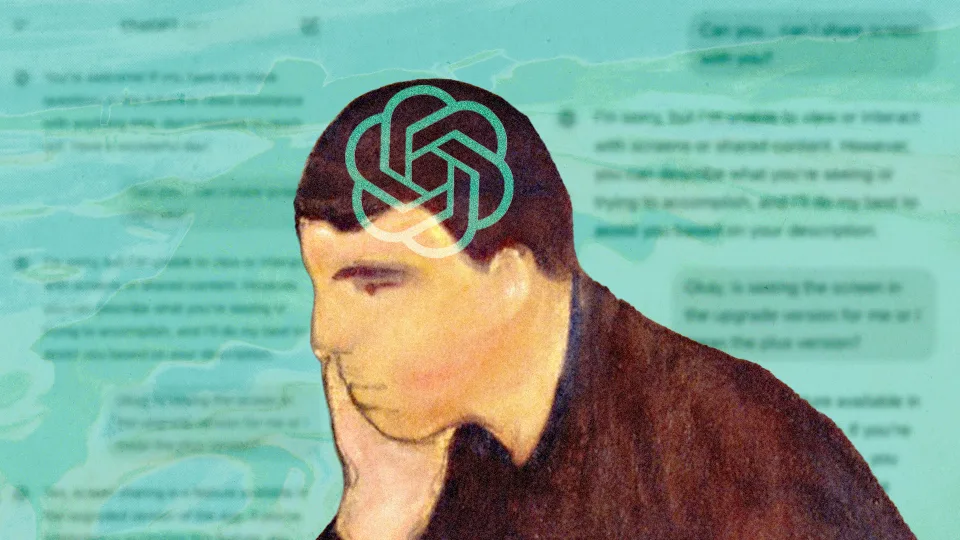L’esordio di Fabrizio Sinisi è pieno di idee e capace di unire una vena surreale allo sguardo affilato sulla realtà.
Nella settimana in cui ho letto Il prodigio (Mondadori, euro 19,50, pag. 246), notevole romanzo d’esordio di Fabrizio Sinisi, le piazze italiane si sono riempite di manifestanti che protestavano contro il governo, per fermare il genocidio in Palestina. Scioperi, presidi, cortei, blocchi nelle stazioni ferroviarie, sulle tangenziali, scontri con le forze dell’ordine. Che si sia d’accordo o meno con le ragioni dei manifestanti, è un dato di fatto che negli ultimi decenni non si era mai visto un tale scatto di ribellione da parte della società civile italiana, senza che, oltretutto, nessun partito politico o movimento precostituito se ne sia potuto intestare il merito. Nella stessa settimana durante la quale ho letto questo romanzo, ho visto anche il film Una battaglia dopo l’altra e iniziato svogliatamente la serie tv Wayward – Ribelli.
Più avanzavo nella lettura e nella visione, più facevo inevitabili parallelismi: sia tra queste tre opere, diverse, ma con un denominatore comune di realismo distopico; sia tra ciò che succede nel mondo e la finzione letteraria e cinematografica. Il confronto tra letteratura e eventi reali è sempre scivoloso: la solita tiritera della realtà che supera la fantasia. E in ogni caso, non è questo il caso: qui la fantasia è in grande spolvero e, con le dovute differenze stilistiche e qualitative, si tratta di storie assai più folli e immaginifiche della realtà. Rimane il fatto che le pagine di questo libro mi risuonavano per forza di cose in modo differente, mentre mezza Italia scendeva in piazza a manifestare e l’altra metà era incollata agli schermi per seguire l’impresa di alcuni attivisti in navigazione verso la Striscia di Gaza.
Ma veniamo al romanzo. Sul finire della notte, in una città che assomiglia molto a Milano compare una nuvola a forma di faccia. In un primo momento la reazione al “colossale emoticon di stupore” è di curiosità, scetticismo, ma presto il prodigio assume una dimensione pubblica amplificata dai social, dalle piazze, dalle campagne mediatiche, fino a diventare oggetto di un devastante delirio collettivo. Mentre le ipotesi si moltiplicano – da semplice fenomeno atmosferico a segnale divino – si verificano eventi inspiegabili, guarigioni miracolose. Più il Volto, come viene ribattezzato, rimane in cielo e più cresce la tensione: le istituzioni – civili e religiose – vengono messe sotto pressione, incapaci di fornire spiegazioni che soddisfino tutti, e così le folle iniziano a muoversi. I fedeli, i curiosi, i disperati arrivano in città con richieste di miracoli, riconoscimenti, risposte concrete. Alcuni manifestanti cominciano a chiedere che il sindaco o il vescovo prendano una posizione ufficiale. Alcuni chiedono che il faccione sia riconosciuto come segno divino, altri invocano misure pratiche e di ordine pubblico o di stabilire un contatto diretto con la manifestazione della faccia.
Mentre le strade vengono bloccate, cordoni di fedeli impediscono il traffico, la folla occupa le piazze e le vie principali. I manifestanti esibiscono cartelli, accendono ceri o lumini, pregano insieme, urlano, litigano con le forze dell’ordine. Vengono improvvisate barricate, manifestazioni che diventano cortei spontanei. L’ordine pubblico vacilla: scontri con la polizia, cariche, lacrimogeni o altri mezzi per disperdere la folla. Alcuni quartieri vengono isolati, sorvegliati, controllati; le autorità locali cercano di imporre coprifuoco o restrizioni: “Incurante dei rischi e degli allarmi lanciati da governo e giornali, la gente ha continuato ad arrivare. La città congestionata ha preso a ingrossarsi e a schiumare; per le strade è diventato sempre più difficile camminare; nelle stazioni e all’aeroporto sbarcava così tanta folla che per gestire le uscite è dovuto intervenire l’esercito. Ogni giorno, a tutte le ore, c’erano folle chiassose ed esaltate da incanalare verso le loro mete come tifosi ai cancelli di uno stadio”.
A raccontare il prodigio è Don Luca, protagonista e voce narrante, un sacerdote quarantenne colto, carismatico, mondano. Ospite fisso di talk show televisivi, Luca è consapevole della crisi che attraversa la chiesa cattolica, ormai sempre più irrilevante e quasi completamente schiacciata dalla nuova religione del nostro tempo: il capitalismo. È Don Luca a raccontare le conseguenze della comparsa del Volto ed è attraverso di lui che apprendiamo che cosa succede in città nelle successive cinque settimane di tensioni, fino a quando il faccione svanirà – se mai svanirà.
Le manifestazioni, che inizialmente sembravano pacifiche, diventano violente. Alcuni dei fedeli si separano dal gruppo, altri dall’ordine: la rivolta assume tonalità che vanno ben oltre la religione, diventa richiesta di senso, di verità, di manifestazione del sacro. Emerge un desiderio, quasi un diritto, di salvezza, che è poi il cuore di questo romanzo.
La vita di Don Luca è attraversata da una relazione tormentata con Marta, una ragazza problematica che sembra sfuggirgli continuamente. I due vivono insieme o meglio saltuariamente dormono insieme, anche se non hanno rapporti sessuali. Marta ha un problema di salute mentale o come dice lei è «tutta sfasciata e rotta e poi rimontata da capo senza libretto delle istruzioni». I due non fanno altro che parlare e camminare. “Lunghe marce silenziose, piene di dolore e di euforia alternata a panico. Percorrevamo le cerchie più estreme delle periferie, camminavamo lungo le circonvallazioni, sui viali interminabili sotto l’ombra dei ciclamini grigi avvelenati dallo smog”.
“Le manifestazioni, che inizialmente sembravano pacifiche, diventano violente. Alcuni dei fedeli si separano dal gruppo, altri dall’ordine: la rivolta assume tonalità che vanno ben oltre la religione”.
Don Luca è un sacerdote che ha perso ogni verve cristiana, del resto celebra ormai la Messa per pochissimi fedeli, confessa maschi anziani bianchi violenti e il suo spirito caritatevole si è perso per strada. L’attività con i padri separati ospitati in parrocchia, attività che ogni chiesa è tenuta ad avere, è gestita quasi completamente da Laura, la sua “perpetua”, colonna portante della parrocchia e di tutto quello che le gira intorno, che non si stanca mai di sistemare, richiamare, correggere, “come un angelo nevrotico e paziente”.
Tra i momenti più amaramente esilaranti del romanzo ci sono proprio quelli dedicati ai padri separati e i loro comportamenti inammissibili: del resto “fra tutte le svariate categorie di disgraziati, i padri separati sono i più problematici. I più disperati. I più logorroici. I più retorici, i più lamentosi. I più resistenti a qualsiasi forma di empatia. I più irrecuperabili. I più ambigui e in assoluto i più difficili da amare”.
A metà strada tra Rumore bianco di De Lillo e La torta in cielo di Gianni Rodari, il romanzo di Fabrizio Sinisi (drammaturgo classe 1987) si sviluppa per brevi capitoletti molto densi, con pochi dialoghi e tantissimi monologhi, forse anche retaggio della sua esperienza di scrittura per il teatro. La struttura è scomposta e la prosa è ipertrofica ma non prolissa. Al netto di qualche ridondanza e aggettivazione eccessiva e una trama complessivamente debole, il romanzo è un esordio originale e molto ambizioso: un libro che guarda senz’altro oltre l’Italia . A tratti sembra quasi sia stato immaginato per essere tradotto in altre lingue e in altri Paesi, con le descrizioni di una città invasa (“da turisti? Fedeli? Pellegrini?”), popolata di personaggi così familiari, da Giorgio Folker, il ricchissimo rampollo diventato santone (“la versione transessuale di san Francesco d’Assisi”) al generale neofascista Capogrosso (“un personaggio folcloristico, un panciuto ufficiale da operetta”), a capo del movimento “rivoluzionario” detto Comitato Libertà del Popolo. Lo scontro tra i due – parimenti inquietanti e insopportabili – sembra quasi ricalcare l’ottusa polarizzazione costante in cui viviamo, quella tra woke e antiwoke: “l’androgino e il fascista, uno davanti all’altro come le figure di una danza antica, simboli loro malgrado di una colluttazione di forze opposte”.
Se è scontato sovrapporre il personaggio di Capogrosso al generale Vannacci, per me è stato naturale anche immaginare il personaggio di Folker con la faccia e il corpo dell’attrice queer Mae Martin, il poliziotto trans di Wayward-Ribelli, serie tv che poi ho terminato a fatica (non riuscitissima, a differenza del film di Paul Thomas Anderson). D’altronde è di corpi che vogliono essere visti e salvati che parla questo primo romanzo di Fabrizio Sinisi. Ed è di persone che fanno politica con i loro corpi che si parla in questi giorni nel nostro Paese. Corpi che sono forse l’unica risorsa possibile in un Occidente sprofondato su se stesso.