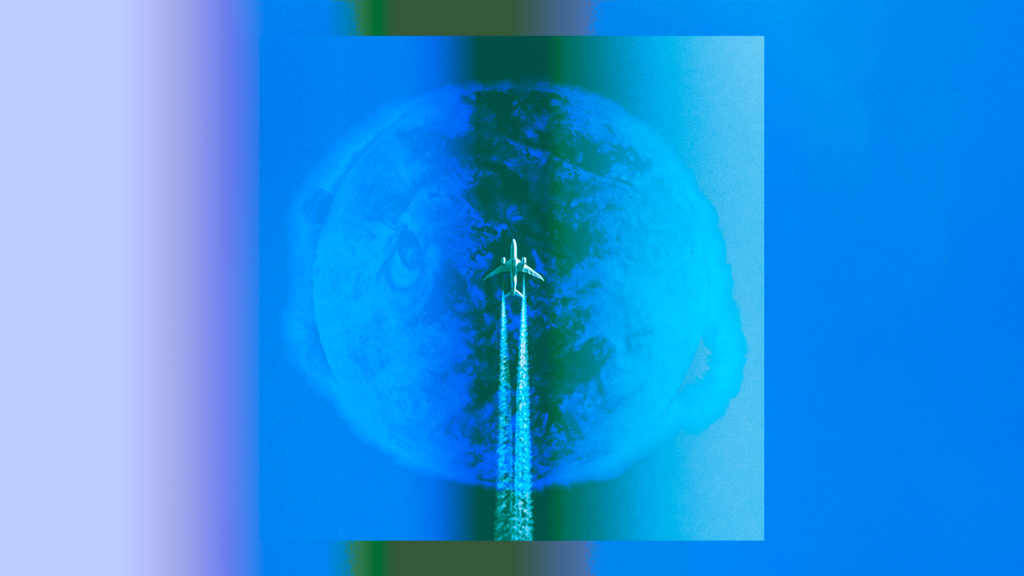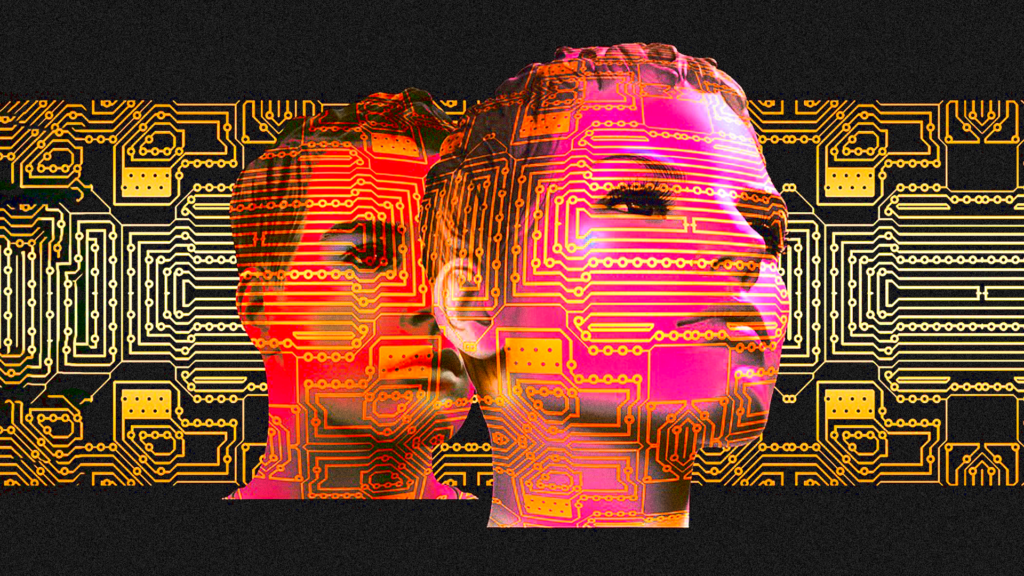Paolo Pecere
Inseguendo Carlo Ginzburg

21 Dicembre 2023
Ripercorrere le tracce del pensiero di Ginzburg significa perdersi e ritrovarsi in sentieri poco battuti, scoprire connessioni impensate, incontrare sciamani, streghe e miti. Tra etnologia, inconscio, arte e letteratura, una conversazione con uno dei più importanti storici contemporanei.
Carlo Ginzburg mi aspetta sulla porta e mi accoglie a casa: libri, libri ovunque, in pile e mucchi su tavoli e sedie, colonne di carta sormontate da soprammobili che si fingono fermacarte. Libri che occupano ogni superficie libera e sembrano formare cunicoli, passaggi. “Sei già stato qui?”, mi chiede la sua voce, ma il professore è già sparito in un corridoio, tra pareti di volumi, dove m’invita a seguirlo.
Non sono stupito, mi sembra di riconoscere un luogo in cui per decenni ho sostato e cercato orientamento, quello dove vive uno dei più grandi storici e intellettuali di ieri e di oggi. Quando era già uno studioso noto, che aveva insegnato da Bologna agli Stati Uniti, i suoi libri mi hanno attratto e non ho smesso di imparare leggendoli e rileggendoli, talvolta aprendoli come romanzi d’avventura. Il fatto che libri specialistici, di grande complessità, attirassero uno studioso di filosofia mi sembra avere a che fare con il mondo di carta che mi circonda. Ginzburg non è soltanto un erudito che fin da giovanissimo ha familiarità con la storia antica e l’etnologia, la storia dell’arte, la filosofia e la letteratura europea, l’uomo che cita a memoria pagine di autori lontani come Agostino e Proust. Ginzburg è lo studioso che ha insegnato a passare tra i settori diversi delle biblioteche, seguendo le tracce delle sue domande senza curarsi dei compartimenti disciplinari, ed è per questo che i suoi libri, e il loro metodo, parlano a chi ha interessi diversissimi e domande diversissime. Purché si sappia seguirlo quando svolta all’improvviso, come fa spesso, in una nube di citazioni prodotte magicamente, portandoti a fare salti nello spazio e nel tempo, così come ora, di fronte a me, è sparito in una galleria di libri.
Il primo tema delle ricerche di Ginzburg sono stati i processi di stregoneria nel Cinquecento. Partendo dagli archivi, per decenni si è impegnato a interpretare i resoconti forniti dagli inquisitori leggendovi qualcosa di non detto, scoprendo qualcosa che si nascondeva tra le righe. Nelle dichiarazioni fornite dal mugnaio Menocchio, esaminate ne Il formaggio e i vermi (1976), ricostruì una cosmologia che affondava in una sapienza popolare e erudita di ricchezza impensata. Prima ancora, aveva ricondotto le credenze popolari esaminate ne I Benandanti (1966), i viaggi notturni di alcuni contadini friulani, a modelli remoti, persino allo sciamanismo siberiano. L’ipotesi sulle origini eurasiatiche dei racconti dei benandanti fu sviluppata poi nel libro forse più ambizioso, Storia notturna. Una decifrazione del sabba (1998), in cui le credenze su un complotto contro la società – ordito da lebbrosi, ebrei, musulmani, eretici e streghe – si mostravano sovrapposte a un complesso di saperi e pratiche che rimandavano a sciamani, lupi mannari, divinità della natura, e figure mitiche o fiabesche come Edipo e Cenerentola.
“Ginzburg è lo studioso che ha insegnato a passare tra i settori diversi delle biblioteche, seguendo le tracce delle sue domande senza curarsi dei compartimenti disciplinari, ed è per questo che i suoi libri, e il loro metodo, parlano a chi ha interessi diversissimi e domande diversissime”.
Passo per un salotto: su una delle due poltrone sono accomodati libri, che dialogano con gli altri che sommergono il tavolino. La vastità delle indagini di Ginzburg collega storie in cui spesso si ritrova qualcosa di familiare, ma sotto altre forme: personaggi apparentemente lontani e estranei si mostrano collegati, dicono le stesse cose. Mentre continuo a esaminare l’ambiente, penso che questi nessi abbiano a che fare col modo in cui sono disposti i libri. Pilastri simili a rocce calcaree, che finiscono in mucchi apparentemente caotici, come letti di un fiume carsico di testo. Dalle fessure tra i volumi escono fogli, cartelline, appunti. Mi sembra di essere nel motore di ricerca analogico che, insieme ai motori di ricerca digitali cui Ginzburg ha dedicato diverse riflessioni, ha prodotto quei salti imprevedibili che per anni mi hanno sbalordito. In questo modo lo stesso nome di Ginzburg viaggia nelle bibliografie più disparate, in traduzioni – molte presenti qui in salotto – dove parla oltre venti lingue. Due anni fa ho trovato citata Storia notturna nel saggio di un etnologo brasiliano dedicato agli sciamani amazzonici: tanto lontano era arrivata la storia dei benandanti friulani. Ho scritto la cosa nella nota a pié di pagina di un libro in cui parlavo di sciamani, ed eccolo là, in cima a una piccola torre, sulle spalle di altri volumi. Anche io sono nell’archivio, mentre cerco di trovare un filo tra le tracce, e la voce di Ginzburg mi chiama da una camera più interna.
Accanto alle indagini di storia e antropologia (una disciplina in cui aveva precocemente trovato un interlocutore ideale in Ernesto de Martino), Ginzburg ha lavorato sulla storia dell’arte e l’iconologia. Indagini su Piero (1981) è un altro libro che mette in discussione i confini disciplinari e interroga gli specialisti, il primo di una serie costante di saggi in cui l’interpretazione di opere d’arte figurativa, da Michelangelo a Picasso, dialoga con il linguaggio dei testi e dei documenti. Poco dopo escono Miti emblemi spie (1986) e Il giudice e lo storico (1991). In quest’ultimo lavoro si rivolge stavolta a un processo contemporaneo, quello ad Adriano Sofri, mostrando un’attenzione all’attualità, guardata in prospettiva storica, che diverrà sempre più evidente.
Seguono raccolte di saggi memorabili, sul modello di Miti emblemi spie, in cui si tutti i fili delle ricerche di Ginzburg continuano a svilupparsi e intrecciarsi. Occhiacci di legno (1998), Rapporti di forza (2000), Il filo e le tracce (2006), Paura reverenza terrore (2008), La lettera uccide (2021). Sto ricordando soltanto parte dei suoi libri, oltre ai quali si apre poi un arcipelago di articoli e interventi ancora diffusi in diverse lingue, come una massa dai confini ancora oscuri. Il percorso segue però linee metodologiche chiarissime: dal problema di interpretare le voci dei processati e dei membri di classi subalterne, per esempio, è emersa l’importanza dei miti per l’elaborazione dell’esperienza individuale. Ma alla luce del ritorno della mitologia nel Novecento, è emersa al tempo stesso la necessità di fare i conti con i miti con lucidità, con lo strumento della filologia e un occhio esercitato a distinguere il vero dal falso, l’inganno dalla congettura. Lo studio dei miti, come quello delle opere d’arte, ha richiesto un metodo che va oltre quello della lettura delle fonti, e richiede un confronto tra forme e racconti tradizionali, per indovinare frammenti di storie che nessuna testimonianza ha riportato direttamente. Procedendo per questa via si arriva all’inconscio, alle strutture del linguaggio e del pensiero, alle fondamenta del soggetto individuale che si muove nelle strutture più evidenti del testo, della società, del potere.

Finalmente raggiungo Ginzburg, ci sediamo. È l’occasione per me di una conversazione che durerà a lungo, da cui cercherò di trarre un percorso introduttivo attraverso alcuni temi delle sue ricerche. Prendiamo spunto da uno dei suoi tanti libri collegati, il primo dove il metodo dell’indagine è esplicitamente esaminato: Miti emblemi spie, che è appena uscito in nuova edizione ampliata per Adelphi. Cuore di quel libro era ed è il saggio “Spie. Radici di un paradigma indiziario”, del 1976, e mentre comincio a conversare tengo a mente le prime righe di quel saggio, dove Ginzburg scriveva di voler fare un contributo per uscire “dalle secche della contrapposizione tra ‘razionalismo’ e ‘irrazionalismo’”, secche in cui mi sembra che ci troviamo ancora.
1. Stregoneria e cultura popolare
Il primo dei saggi della raccolta è “Stregoneria e pietà popolare. Note a proposito di un processo modenese del 1519”, lo studio di un singolo processo che è del 1961. Qui Ginzburg si interrogava sul problema di distinguere ciò che una donna, Chiara Signorini, credeva o piuttosto inventava quando parlava di visioni diaboliche della Vergine Maria. Si domandò quanto le sue dichiarazioni dipendessero da quello che gli inquisitori credevano. Si rese conto che alcune delle cose che venivano dette non appartenevano al repertorio dell’inquisizione: aprivano uno spiraglio sull’immaginario e la religiosità popolare. Era l’inizio di una riflessione sui documenti inquisitoriali, di cui Ginzburg mi racconta le origini “Avevo fatto una scelta triplice: diventare uno storico, cercare di studiare i processi di stregoneria, e cercare di catturare gli atteggiamenti, le voci dell’imputato e degli imputati. La scelta era avvenuta di colpo, in un momento in cui ero alla Scuola normale, di cui ho un ricordo vivissimo. Non mi rendevo conto in quel momento di quanto il terzo punto, cioè cercare di catturare le voci e gli atteggiamenti delle vittime, implicasse una lettura ‘in contropelo’ delle fonti, cioè degli archivi, della repressione”. Ginzburg si mette a lavorare sui processi partendo da una sorta di “ingenua ipotesi”, la chiama così, ispirata a Gramsci e Michelet: la stregoneria come forma elementare di lotta di classe.
“Ho trovato un caso, quello di Chiara Signorini e del marito, in cui lei in particolare era accusata di aver gettato un incantesimo contro la padrona che li aveva cacciati. Ricordo ancora la delusione che provai quando vidi questa che sembrava una conferma della mia ipotesi. L’ipotesi non era più interessante se trovavo una conferma così rapida! Dopodiché però effettivamente la stesura del saggio ha preso un’altra strada, che collegava la stregoneria con la pietà popolare”.
Quel processo gli apparve come caso esemplare di un’indagine che sarebbe proseguita. Ginzburg si rese conto in seguito di aver usato in quel saggio il termine “paradigma”, in uno dei sensi che Thomas Kuhn avrebbe introdotto l’anno dopo nel suo La struttura delle rivoluzione scientifiche. “Si trattava di un caso paradigmatico, ma anomalo”, mi spiega. “Un tipo di esempio che ha continuato poi a caratterizzare le mie ricerche”. Non si trattava soltanto di riscoprire documenti, ma di leggerne un contenuto cifrato. L’anomalia era preziosa, perché aiutava a capire sia le norme del discorso religioso, sia i contenuti della loro occasionale violazione.
2. Paradigma indiziario e verità storica
Il problema del metodo di ricerca divenne sempre più un argomento di riflessione nei saggi di Ginzburg, e trovò un primo bilancio proprio in “Spie. Radici di un paradigma indiziario”. Che cos’era questo paradigma? Si trattava di un metodo di indagine che era stato “largamente operante di fatto, anche se non teorizzato esplicitamente”, scriveva Ginzburg.
Lo introduceva con l’esempio di tre figure apparentemente disparate: il critico d’arte Giovanni Morelli, il fondatore della psicoanalisi Sigmund Freud e l’investigatore Sherlock Holmes, protagonista dei romanzi di Conan Doyle. Il tratto comune tra il conoscitore d’arte, lo psicoanalista e l’investigatore stava nel ricostruire una storia ignota tenendo conto di dettagli “poco apprezzati o inavvertiti”. Lo stesso metodo attraversa discipline diverse come la medicina e la giurisprudenza, che – a differenza di scienze come la fisica – si basano appunto su segni, indizi, per decifrare ogni volta un caso particolare.
La riscoperta del paradigma indiziario ebbe un’immediata risonanza. Ma, come osserva Ginzburg nella nuova Postfazione al libro, nel saggio “Spie” mancava una parola chiave: “prove”. “Io ero talmente preso dall’euforia degli indizi che non mi sono soffermato su questo punto, sulle prove”, mi racconta. “All’orizzonte c’erano l’ermeneutica e il postmodernismo, che metteva in dubbio la verità storica. Successivamente mi sono reso conto che era assolutamente necessario insistere sulle prove e quindi l’ho fatto per decenni”. Il metodo di seguire indizi non toglie l’importanza di fornire delle prove per raggiungere la verità storica, per esempio scoprire l’autore di un quadro, il colpevole di un crimine, la motivazione di un comportamento apparentemente insensato.
“Rileggere le sue cose insieme a Ginzburg restituisce una sensazione di comune coinvolgimento. C’intendiamo, troviamo riferimenti comuni, ci scambiamo indicazioni su puntuali riferimenti che da un testo rimandano a un altro e mi rendo conto che per lui le domande sono sempre aperte”.
Il punto era questo: insistere su un metodo capace di scoprire verità su cui mancano testimonianze dirette, per esempio per accedere al pensiero dei processati con l’accusa di stregoneria, non toglieva la necessità di fornire prove mediante questo metodo. Per Ginzburg è infatti fondamentale capire il pensiero di figure marginalizzate, senza idealizzarlo.
Rileggiamo insieme a lui un breve passo che mi illuminò: nella prefazione a Il formaggio e i vermi, in poche righe, tratteggia una critica del metodo di Michel Foucault nel suo lavoro del 1973 sul caso di un parricida dell’Ottocento, Pierre Rivière. Ginzburg lamentava il disinteresse di Foucault per l’autentico pensiero e le motivazioni di Rivière, che nella ricostruzione veniva ridotto a un corpo selvaggio, muto. Questo era uno degli esempi di irrazionalismo a cui intendeva contrapporsi nelle prime righe di “Spie”. Lo chiamava “un irrazionalismo estetizzante”: un pensiero che evocava figure marginali e oscure per farne dei feticci affascinanti, presentarli al pubblico come eroi di una lotta contro la ragione dominante, senza curarsi dell’autentico contenuto del loro pensiero.
Rileggere queste cose insieme a Ginzburg restituisce una sensazione di comune coinvolgimento. C’intendiamo, troviamo riferimenti comuni, ci scambiamo indicazioni su puntuali riferimenti che da un testo rimandano a un altro e mi rendo conto che per lui le domande sono sempre aperte. Fintanto che si tratta di ripercorrere ricerche già svolte e fornire chiarimenti già offerti, lui è gentile e attento; ma il suo sguardo si infiamma quando coglie un particolare ancora da chiarire, in un testo che può essere stato scritto da lui stesso, o da altri. “Non ci avevo pensato”, dice, e poi resta in silenzio, come me, mentre le domande ci attraversano, ci oltrepassano.
Tornando al metodo storico, approfondiamo il significato di una parola che Ginzburg ha usato per definire alcune prove: “morfologia”. Si tratta di un termine che ha una lunga storia, che attraversa discipline diverse come storia naturale e linguistica, e che molti, per la prima volta, incontrano studiando le regole con cui una lingua forma le parole. Ginzburg lo usa per indicare una ricerca su forme ricorrenti in testi o immagini, che per la loro analogia diventano indizi, aprono a connessioni impensate. Ne ha fatto ampio uso in Storia notturna, dove, per interpretare i racconti degli imputati nei processi di stregoneria alla luce di un orizzonte culturale profondissimo, affrontava il problema dei limiti della documentazione storica. Quando non c’erano prove dirette di un contatto culturale con aree lontanissime, attingeva a miti dotati di elementi comuni e diffusi in aree vastissime.
A approfondire metodo è dedicato il saggio “Medaglie e conchiglie”, che ora è in appendice alla nuova edizione di Storia notturna. Medaglie e conchiglie sono emblemi del metodo dell’antiquaria, una disciplina che parte dagli oggetti per ricostruire un mondo su cui mancano testimonianze, sia esso un antico impero, o il regno sottomarino di milioni di anni fa. Per introdurre le origini di questo metodo, Ginzburg propone una vertiginosa serie di riferimenti bibliografici: da Vladimir Propp, l’autore di di Morfologia della fiaba, si va indietro fino al poeta-filosofo Goethe, e al palentologo Georges Cuvier che, a proposito del suo studio di reperti fossili come le conchiglie, si definiva “antiquario di una specie nuova”.
“Su questa strada ho scoperto il nesso tra antiquaria civile e antiquaria naturale”, mi dice. Studiosi di antiche civiltà e naturalisti, in entrambi i casi, lavorano su reperti per reagire a un atteggiamento scettico sulla conoscenza storica, secondo cui in mancanza di testimonianze verbali non si può conoscere. Con le sue ricerche, Ginzburg ha trovato le origini di questo approccio già in un umanista del Cinquecento, Francesco Robortello. Nel mezzo del discorso si alza e esce, va a prendere un libro nell’immenso archivio per controllare una cosa, lasciandomi solo a unire i punti della sua narrazione.

Quando ritorna appoggia il libro sul tavolo e mi spiega che tutto questo discorso sulla morfologia è collegato a quello delle prove storiche. “L’antiquario produce delle prove”. Il racconto storico nasce dall’unione di due elementi: un’idea narrativa – come nella “storia filosofica” di cui parlava Voltaire – e le prove sui singoli frammenti del racconto. Questa dimensione è fondamentale contro il rischio dello scetticismo storico, che non è solo faccenda accademica. Come ricorda Ginzburg, la questione della verità storica si ripropone oggi sotto forma delle fake news. Il metodo indiziario, la storia, la filologia, sono insomma strumenti più che mai attuali per orientarsi nel mondo.
3. Warburg e de Martino
Abbiamo già nominato Gramsci e Goethe, Voltaire e Foucault. Quando si legge o si ascolta Ginzburg, si è parte di una conversazione che coinvolge numerosi personaggi del passato, storici, filosofi, scienziati e artisti. Due, in particolare, percorrono tutta la sua riflessione. Il primo è Aby Warburg, il grande storico dell’arte che all’inizio del secolo scorso indagò il significato delle immagini del paganesimo antico nell’arte rinascimentale europea e lasciò un’eredità intellettuale ancora viva nella Biblioteca e nell’Istituto che ancora portano il suo nome. L’altro è lo storico delle religioni Ernesto de Martino, che pure approfondì la sopravvivenza di miti e riti antichi nelle civiltà moderne e contemporanee, a partire da un libro fondamentale come Il mondo magico (1948). Non c’è prova che de Martino avesse letto le opere di Warburg, eppure Ginzburg ha colto convergenze tra i due, come l’interesse per il mito inteso non soltanto come forma di pensiero, ma come esperienza esistenziale che risponde a una fragilità fondamentale. Gli chiedo come ha scoperto questi due autori.
“Ho cominciato con de Martino. Ho letto Il mondo magico prima di iniziare l’università, a diciott’anni. Poco dopo ho scoperto la rivista della Biblioteca Warburg e un saggio di Warburg, Il rituale del serpente. A Londra, Delio Cantimori mi introdusse fisicamente all’Istituto Warburg”.
De Martino in una lettera racconta del progetto che poi diventerà Il mondo magico e scrive di volersi mettere in contatto con l’Istituto Warburg. Come è arrivato a Warburg? “Oggi, in base al lavoro di Riccardo Di Donato, direi attraverso il suocero Vittorio Macchioro [storico delle religioni antiche con forte interesse per la magia], che aveva incontrato Warburg e che esercitò un importante influsso sul giovane de Martino. Poi c’è il nesso tra i due che dipende da letture comuni. Penso a un libro di Alfred Storch, studioso che mette in rapporto lo studio sulla schizofrenia e lo studio sui popoli primitivi, e che era stato acquistato da Warburg, come mi ha fatto notare la bibliotecaria. Ecco l’ipotesi di un anello comune, e se ne potrebbero fare altre”.
Anche su questi due autori Ginzburg si è messo a indagare. “Sono stato attratto da figure diversissime. Cadere nell’ortodossia mi sembra sempre un errore, una forma di provincialismo. Poi naturalmente bisogna distinguere fra la domanda e le risposte. Nel caso di de Martino, per esempio, la distinzione è per me decisiva. Perché lui, per esempio, credeva nella realtà dei poteri magici, io invece non ci ho mai creduto. Quindi è la domanda che mi pare importante”. Un esempio è proprio il tema della perdita della presenza che de Martino pone nel Mondo magico. De Martino considerava la magia come un modo per rispondere al rischio esistenziale radicale che caratterizza l’io di fronte alle asperità del mondo, e si chiedeva che cosa sostituisse la funzione della magia nel mondo contemporaneo. Rispetto a questo tema, Ginzburg non è convinto che de Martino offrisse una soluzione. La sua trattazione della perdita della presenza, mi dice, “è una domanda o una risposta? Io credo che sia ancora una domanda”.
“Gramsci e Goethe, Voltaire e Foucault. Quando si legge o si ascolta Ginzburg, si è parte di una conversazione che coinvolge numerosi personaggi del passato, storici, filosofi, scienziati e artisti. Due, in particolare, percorrono tutta la sua riflessione: Aby Warburg e Ernesto de Martino”.
Quanto a Warburg, anche lui praticò un metodo morfologico. Le sue “formule di pathos” (Pathosformeln) sono posture e movenze che svelano continuità nascoste tra le raffigurazioni di personaggi antichi come le ninfe e la pittura moderna. Warburg è un altro modello di intreccio tra discipline. Ha attinto alla filosofia: un suo punto di riferimento fu la riflessione sui simboli e sul mito del filosofo tedesco Ernst Cassirer, che tra l’altro, come ha ricordato Ginzburg, fu anche uno dei modelli di de Martino. Ma Ginzburg ha trovato anche una fonte di Warburg che – mi dice – “era stranamente sfuggita a tutti”: L’espressione delle emozioni nell’uomo e negli animali di Charles Darwin, dove a un certo punto il grande naturalista rinvia a un libro dello storico dell’arte Joshua Reynolds, che collega l’espressione gestuale delle emozioni in figure diverse come le Baccanti e Maria Maddalena. Ecco l’idea da cui sarebbe partito Warburg: un dettaglio che non è sfuggito al teorico del metodo indiziario.
4. Sciamani e miti
In questo percorso tra libri e note a piè di pagina, siamo arrivati a parlare di miti e emozioni capaci di ispirare e sopraffare l’individuo, un tema che fin dall’inizio è al centro delle domande di Ginzburg, sia che si tratti del pensiero di imputati con l’accusa di stregoneria, sia che si tratti di immagini di turbamento e sensualità nell’arte. Ma questa domanda, come ricorda Ginzburg, nasce sempre dal presente. Lo stesso Warburg andò dagli indiani Hopi per assistere alle loro cerimonie e interrogarsi sul valore della loro visione del cosmo per l’Europa contemporanea con i suoi profondi bisogni: e lesse il suo saggio, ancora inedito, sul Rituale del serpente mentre era ricoverato in una clinica psichiatrica, come testimonianza della sua guarigione, ma anche della sua inquietudine. De Martino si occupò a lungo di sciamani, figure capaci di tramandare racconti, viaggiare fuori dal corpo, curare e divinare, intervenendo sulla fragilità della psiche umana: ma anche in quel caso il suo interesse era mosso da un malessere personale e da preoccupazioni legate al presente. Nel saggio “Promesse e minacce dell’etnologia”, de Martino raccontava di essersi dedicato all’etnologia proprio nell’epoca in cui “Hitler sciamanizzava in Europa”, e di aver scelto di studiare questa disciplina proprio per fare i conti con il ritorno dell’irrazionalismo e del mito al tempo del fascismo e del nazismo.
La sua intenzione era salvare il valore culturale di miti e magia dalle strumentalizzazioni pseudostoriche come il mito del sangue. È un altro tema che Ginzburg ha ripreso, e che è al centro di un altro dei saggi di Miti emblemi spie: “Mitologia germanica e nazismo”. Il punto di partenza del saggio è “un vecchio libro” di Georges Dumézil, grande studioso di lingue e culture indoreuropee: ma il tema, era molto più vasto, e animato da preoccupazioni attuali. Nelle prime righe del saggio, Ginzburg ricordava la “rivalutazione della cosiddetta cultura di destra” che era in atto (era il 1984, pochi anni prima era uscito Cultura di destra di Furio Jesi che già affrontava questo tema), e ne coglieva l’occasione per introdurre quella distinzione tra domande legittime e risposte sbagliate di cui abbiamo detto. Nel saggio Ginzburg ricordava l’interesse di storici e intellettuali francesi come Lucien Febvre per i sentimenti primitivi resuscitati nel Novecento. Un caso particolarmente delicato era quello di Georges Bataille, fondatore del “Collegio di Sociologia” e comunista, che aveva manifestato entusiasmo per i miti fascisti negli anni Trenta. Ginzburg lo definiva severamente “un apprendista sciamano”.
“Rispetto al mito, ignorare la distinzione tra domanda e risposta ha portato a identificarsi con miti di vario genere. Se noi prendiamo le distanze, allora non abbiamo bisogno di credere ai miti, ma di analizzarli. Questo problema della distanza a mio parere è cruciale: e si ripropone riguardo a quella frase di de Martino, che mi ha sempre colpito come ha colpito te, su Hitler che sciamanizzava”.
Per spiegare cosa intende, Ginzburg mi propone un altro dei suoi frammenti di investigazione: partendo da un riferimento nel Mondo magico mostra quanto de Martino dipendesse da una fonte discutibile, lo studioso tedesco Wilhelm Mühlmann. “È lui che lo indirizza verso la filosofia di Heidegger”, che conteneva un’analisi dell’esistenza di cui de Martino fa uso per definire la crisi della presenza. Notoriamente Heidegger collaborò per un certo tempo col nazismo da rettore dell’università, e i suoi “Quaderni neri” sono stati di recente occasione di una controversia sul suo antisemitismo. Ma il caso di Mühlmann – prosegue Ginzburg – era più chiaramente problematico: questo studioso, “che de Martino considera un acuto studioso, era un nazista feroce, che dopo la guerra continua la sua carriera per una sorta di amnistia-amnesia dell’università tedesca”.

Tutto ciò pone un problema ancora attuale, quello di trovare una giusta distanza. Da una parte, Ginzburg non accetta una liquidazione razionalistica del mito, che ne faccia una pura superstizione, una semplice falsità. D’altra parte, sottolinea l’importanza di distinguere diversi punti di vista senza aderire senz’altro a quello di chi crede nel mito che vogliamo comprendere. Per delineare questa giusta distanza, Ginzburg ha ripreso una distinzione che fa Kenneth Pike, antropologo, linguista, missionario protestante, fra etic e emic, cioè tra le categorie dell’osservatore e le categorie degli attori.
“Ho rielaborato questa distinzione soprattutto sulle tracce dello storico Marc Bloch”, mi dice. “Bloch si era posto il problema: è lecito usare il termine classe, la categoria di classe nel senso di classe sociale, per il Medioevo, quando questo termine non aveva quel significato? Io credo che la giusta distanza implichi da un lato, appunto la dicotomia etic-emic, dall’altra parte un dialogo. Si tratta di partire da domande inevitabilmente anacronistiche e etnocentriche per cercare di catturare le voci degli attori e quindi di formulare le risposte. Credo che la conoscenza storica non possa fare a meno di questo, a meno di non fare parlare gli attori con le proprie voci, come hanno fatto molti storici e antropologi. Questa è una forma di ‘ventriloquismo’, che trovo assurda”.
Insomma bisogna stare in un dialogo tra due poli, senza aderire solo a uno solo: presente e passato, etnocentrismo e rivalutazione di culture lontane. Bisogna riconoscere che la realtà non è narrata da una sola voce, una lezione che Ginzburg ritiene dotata di un valore che va al di là della storiografia, e riguarda in genere la comprensione degli altri. “Io direi che si tratta di tradurre questo approccio anche nella vita quotidiana, dove abbiamo a che fare con persone che sono diverse da noi. Per capire quello che ci dicono dobbiamo riformulare le nostre eventuali ipotesi, basate su tratti fisiognomici, espressioni, intonazioni di voce, eccetera, per cercare di capire che cosa ci stanno veramente dicendo”.
Dietro la questione di comprendere categorie socialmente marginalizzate o politicamente oppresse c’era anche un coinvolgimento personale. A un certo punto, Ginzburg si è reso conto che sotto l’interesse di far emergere le voci dei sottoposti ai processi di stregoneria agiva anche una forma di proiezione prossima all’identificazione. Nella conversazione rievoca quell’episodio.
“Si tratta di ricordi della guerra. Eravamo nascosti (mia madre, sua madre e io) in un albergo in Toscana, vicino a Vallombrosa, allora sulla linea del fronte. Ricordo ancora le voci degli ufficiali tedeschi che leggevano il nome dell’albergo. A un certo punto la mia nonna materna, l’unico membro non ebreo della famiglia, mi disse: Se ti chiedono come ti chiami, dì che ti chiami Carlo Tanzi (era il nome di suo padre). Scrisse il nome “Carlo Tanzi” sulla prima pagina di un libro che mi stavano leggendo: Il più felice bambino del mondo, di Carola Prosperi. Avevo cinque anni”. Questo ricordo per Ginzburg è indelebile. “Però la cosa che mi sembra stupefacente è che, nel momento in cui io decisi di cercare di diventare uno storico e di concentrarmi sulle vittime dei processi di stregoneria, non pensai affatto che quella decisione nascesse anche dall’esperienza che aveva fatto di me un bambino ebreo. Questo nesso rimase inconsapevole per molti anni. Sono portato a pensare, anche se la cosa è indimostrabile, che la mancanza di consapevolezza abbia permesso a quella connessione di agire in maniera più vigorosa”.
5. Io e inconscio
Arriviamo così dal vissuto all’inconscio, che è un altro tema assiduo della ricerca di Ginzburg, a partire dalla ricorrente attenzione per Freud. Il rapporto tra inconscio e credenze si presenta anche in un altro saggio di Miti emblemi spie, “Freud, l’uomo dei lupi e i lupi mannari”. Qui Ginzburg interpreta il sogno dei lupo del famoso paziente di Freud alla luce delle credenze popolari sui lupi mannari che aveva intercettato nelle ricerche di Storia notturna. L’ipotesi è che il paziente di Freud, che si chiamava Sergej Costantinovič Pankëev, avrebbe assimilato queste credenze dalla sua balia russa, e queste avessero influenzato il suo sogno. Come i benandanti, anche lui era nato con la camicia, ossia avvolto nel cencio amniotico. Perciò Ginzburg descrive Pankëev quasi come un benandante, e scrive: “sottoposto a pressioni culturali contraddittorie – la njanja, la governante inglese, i genitori, i maestri – l’uomo dei lupi non seguì la via che gli si sarebbe aperta avanti due o tre secoli prima. Anziché diventare un lupo mannaro, divenne un nevrotico sull’orlo della psicosi”.
“Presente e passato, etnocentrismo e rivalutazione di culture lontane. Bisogna riconoscere che la realtà non è narrata da una sola voce, una lezione che Ginzburg ritiene dotata di un valore che va al di là della storiografia, e riguarda in genere la comprensione degli altri”.
Ecco di nuovo un’alternativa, tra una eccessiva vicinanza e un’eccessiva distanza dal mito. In questa conclusione si ritrova la riflessione di Ginzburg sulla tradizione etnologica e su un problema che nel Novecento fu posto più volte: per esempio, per de Martino, il codice mitico popolare perde efficacia e allora resta la malattia dell’individuo, oggetto della psichiatria (così era successo ai tarantati pugliesi dopo la fine dei riti del tarantismo). E ancora, per Claude Lévi-Strauss, lo sciamano, nelle civiltà europee contemporanee, è sostituito dall’analista. La conclusione di Ginzburg rispetto a queste trasformazioni sembra escludere una piena emancipazione dal mito: contro l’immagine “ipertrofica” di un io che interpreta, quasi avesse una padronanza assoluta, Ginzburg scrive: “i miti pensano noi”.
“È una frase su cui continuo a riflettere, che riguarda i limiti dell’io. Penso che il compito della scienza – come pensava anche Freud – sia quello di ridurre per quanto è possibile lo spazio del cosiddetto libero arbitrio. Io ho usato anche questa espressione: ‘essere agiti’. Nel momento in cui veniamo a contatto con le narrazioni mitiche, si crea un intreccio per cui esse ci spingono in una certa direzione”. Per cui il problema della distanza non è un problema pacifico. La distanza è qualcosa che dobbiamo costruire.
C’è poi, in generale, il condizionamento della tradizione. “Quando formulai quella battuta, che aveva un suono provocatorio, e per me ce l’ha ancora, ossia che ‘i miti pensano noi’, mi riferivo anche al fatto che il nostro rapporto con la tradizione, con le tradizioni, è qualcosa che ci condiziona, anche se non ne siamo consapevoli. Questo è innegabile. L’autonomia dell’io è inevitabilmente relativa”.
6. Riproduzione e copie
L’ultimo tema di cui parliamo sono le copie, un altro Leitmotiv della ricerca di Ginzburg molto presente nei saggi di Miti emblemi spie. In una tradizione che va da Aristotele a Dante, si sostiene che l’arte (un termine variamente definito) imita la natura. Ginzburg sottolinea che da Giotto in poi molti pittori cominciano a rivendicare “orgogliosamente il potere dell’illusione”. Da questa consapevolezza si arriva col tempo all’idea della fiction, creazione-finzione dotata di un alto valore culturale, che anzi per molti artisti e pensatori dell’Ottocento supera quello della natura.
Da millenni, però, al centro della nostra cultura esiste una tacita distinzione tra testi scritti, sempre riproducibili in quanto riproducono un testo invisibile, e una determinata classe di immagini (le opere d’arte) che costituiscono originali non riproducibili. Quando acquistiamo una copia di un romanzo non crediamo di aver tra le mani una “copia”, che vale meno dall’originale, mentre se scopriamo di aver visitato una mostra di Van Gogh dove erano esposte delle riproduzioni digitali ci sentiamo ingannati. Volevamo vedere gli originali! Ginzburg riprende la questione analizzando il caso delle Nozze di Cana di Veronese, di cui anni fa venne esposta una riproduzione a Venezia, nell’ex-monastero benedettino di San Giorgio Maggiore, dove si trovava l’originale (oggi al Louvre). Rispetto a questo episodio, Ginzburg solleva la questione “della fragilità del nostro patrimonio culturale, biologico e ambientale di fronte alla possibilità di riprodurre”. L’incrinarsi dell’unicità delle immagini apre una strada che va verso una “perdita storica gravissima”.
“Chi esce dai libri di Ginzburg non possiede sempre delle risposte, ma di certo impara a formulare quelle domande in modo più attento e radicale; porta con sé questa capacità mentre ritorna al compito di orientarsi nel mondo fuori dai libri”.
Siamo alle ultime battute della nostra conversazione. Parliamo ancora della mise en abîme, la tecnica con cui l’autore si rappresenta come personaggio della sua stessa storia, messa in atto da Dante nella Commedia e da Proust nella Ricerca del tempo perduto, e mi rendo conto che un tema ha attraversato tutto il nostro dialogo: quello del rapporto tra le storie che costituiscono il nostro pensiero e la nostra coscienza. Un risvolto attuale di questa riflessione è il tema delle fake news. Ginzburg accosta questa nozione a quella delle “profezie che si autoavverano, mediante cui le paure si traducono in realtà” di cui parlava il sociologo Robert Merton, e ricorda che, secondo Merton, questo avviene “in assenza di un deliberato controllo istituzionale”. Attraverso molti esempi, ritrova la questione nella propaganda fascista in Italia, citando Mussolini che, a proposito della capacità di usare la fede delle persone per manipolarle, disse a un giornalista: “le masse sono come cera tra le mie mani”. Mussolini concludeva: “tutto gira intorno alla capacità di controllare le masse come un artista”. Imparare a smentire le false notizie e i falsi miti, rendersi conto di chi è l’autore di un testo, di una notizia che riceviamo, di un’immagine che vediamo, sono dei compiti attuali che Ginzburg trae dalla ricerca storica.
Quando mi alzo per andare via, mi sembra che tutte le domande di cui abbiamo parlato, e di cui ci parlano i libri da cui siamo circondati in casa di Ginzburg, si colleghino vorticosamente: l’accertamento della verità, il potere persuasivo del mito, i condizionamenti inconsci, la verità e le copie, e la difficoltà dell’io di padroneggiare tutto questo. Chi esce dai libri di Ginzburg non possiede sempre delle risposte, ma di certo impara a formulare quelle domande in modo più attento e radicale; porta con sé questa capacità mentre ritorna al compito di orientarsi nel mondo fuori dai libri.
Paolo Pecere
Paolo Pecere è filosofo e scrittore. Insegna Storia della filosofia all’Università di Roma Tre. Il suo ultimo libro è Il senso della natura. Sette sentieri per la Terra (Sellerio, 2024).
newsletter
Le vite degli altri
Le vite degli altri è una newsletter che racconta di vite che non sono la nostra: vite straordinarie, bizzarre o comunque interessanti.
La scriviamo noi della redazione di Lucy e arriva nella tua mail la domenica, prima di pranzo o dopo il secondo caffè – dipende dalle tue abitudini.
Contenuti correlati