Guadagnino è in stato di grazia. Dopo aver declinato in varie forme l'ossessione, in "Queer", con Daniel Craig, sembra riversare tutto se stesso.
Queer è il film che Guadagnino avrebbe voluto girare da quando diciassettenne gli capitò di leggere l’opera di Burroughs, ed è sintomatico, s’immagina quanto emozionante, che questa possibilità arrivi a quest’altezza della sua carriera.
Qualcosa di simile era accaduto qualche tempo fa a Matteo Garrone i cui primi “storyboard” per Pinocchio, improvvisati a matita su dei fogli, risalivano persino ai giorni aurorali dell’infanzia.
E c’entra, certo, in questo voler fare i conti col se stesso adolescente del regista di Chiamami col tuo nome, la scelta di girare parte del film, ambientato tra Messico e Sudamerica, nei luoghi della sua Palermo, tra la Kalsa rocciosa e il lussureggiante giardino botanico.
Ma a colpire, in Queer, oltre a ciò, è il talento fabbrile con cui il regista, e non riesce di abituarcisi nonostante i precedenti, ricrea in studio una Città del Messico irreale – fatta di decòr e locali madidi – che è il perfetto teatro espanso dei suoi protagonisti. E d’altronde, come nota il biografo di Burroughs James Grauerholzon, non c’è nulla di realistico neppure nei luoghi del romanzo che comincia giusto col protagonista seduto “su una panchina di cemento lavorato in modo da sembrare legno”, un pezzo “d’arredo surreale e improbabile, a dispetto del fatto che nel Parque México esistono davvero panchine così”. Ma nel libro ogni regola salta se le teste di cervo tarlate appese a un locale danno a un bar del Messico “una tetra, incongrua aria tirolese”.
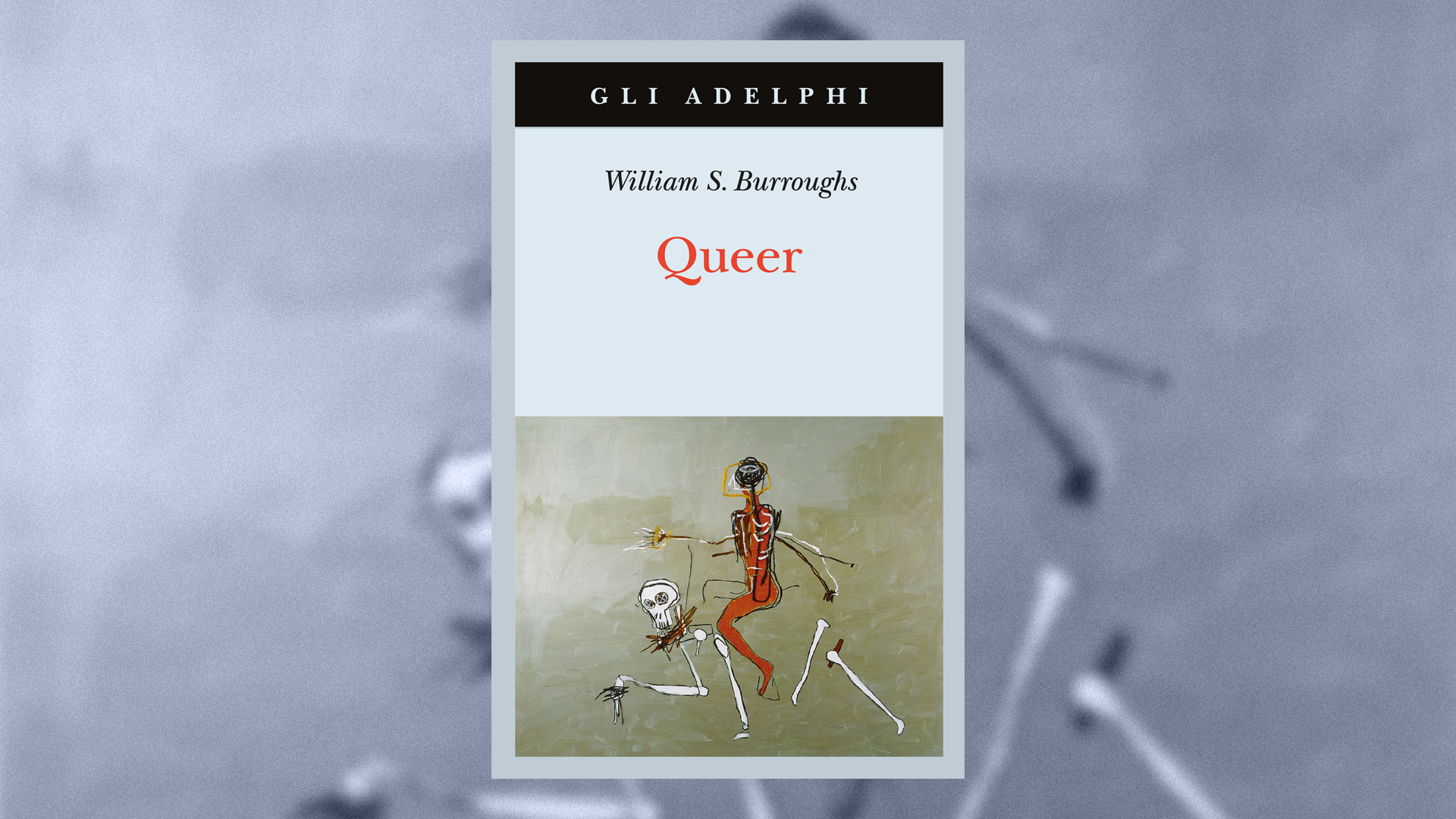
È tra queste quinte oniriche che si muove, completo bianco di lino e cappello panama calcato, William Lee (un sorprendente Daniel Craig) americano transfugo che con passo elastico attraversa i locali come soglie, quasi sempre in solitaria, per stordirsi di mescal o trovare sfogo nella compagnia maschile. Alla cintura ha un revolver, eppure lo cogliamo sempre in momenti di vulnerabilità, impaccio, goffaggine – ed è frizione forte se si sovrappone a questo Lee, invece, l’immagine dell’algido e tonico James Bond di Craig che, a dirla tutta, già in Casino Royale piangeva sotto la doccia.
Craig ha poi il volto ideale per incarnare la natura ambigua di Burroughs, quella sua purezza corrotta così nitidamente catturata dall’amico Jack Kerouac quando, incontrandolo un mattino di maggio del 1952, lo aveva definito “un ragazzo dagli occhi azzurri bellissimi” che viveva “nella spazzatura”.
In effetti sono molte le affinità che la sceneggiatura stabilisce tra Lee e Burroughs, come pure le divergenze, se è vero che lo scrittore era stato soprannominato El hombre invisible dai giovani spagnoli che tampinava a Tangeri, per via dei suoi modi accorti.
Qui vediamo Lee fare sbadatamente dietrofront per l’imbarazzo, svenire eccentrico per la troppa tequila dopo una dichiarazione d’amore, salutare con levate di cappello, improvvisare performance teatrali… (queer significa pure “fasullo”) – atteggiamenti che Burroughs nel libro chiama i “numeri” di Lee e che costituiscono la parte più comicamente disperante, ma anche emotivamente immaginifica, dei suoi tentativi di catturare l’attenzione degli uomini. Scenate, ma anche trucchi (“queer” significa anche “dubbio”). Le battute nei locali sono per quelli come lui: “Siediti sul tuo culo, o su ciò che ne resta dopo quattro anni in Marina” uomini maturi con cui Lee, tra cenni d’intesa e comiche incomprensioni, si interroga sull’orientamento sessuale dei giovani che varcano la soglia dei bar malconci – e in questo il personaggio interpretato da Jason Schwartzman è teneramente irresistibile nel suo reiterare sempre gli stessi errori.
Capita persino che Lee non sappia se deve pagare gli autoctoni con cui fa sesso o se, al contrario, spetta al suo carisma il merito della conquista – nel dubbio, però, tira fuori i pesos.
Il suo peregrinare luttuoso ricorda, e forse non per caso, quello vagheggiato, in seguito alla morte del compagno, dal professore-protagonista di Un uomo solo di Christopher Isherwood quando per un attimo ipotizza che: “Forse farà qualcosa di drastico, prenderà un aereo per Città del Messico e girerà per bar, sbronzandosi per una settimana di fila.”
“Alla cintura ha un revolver, eppure lo cogliamo sempre in momenti di vulnerabilità, impaccio, goffaggine – ed è frizione forte se si sovrappone a questo Lee, invece, l’immagine dell’algido James Bond di Craig”.
Come il romanzo di Isherwood, da cui fu tratto nel 2008 un film omonimo diretto da Tom Ford, la pellicola di Guadagnino è un’opera sulla solitudine, sulla perdizione e sul desiderio, che talvolta assume le forme, dolorose ma penetranti, di arti fantasma con cui Lee non ha l’ardire di compiere alcuni gesti – come una carezza al ragazzo che gli siede davanti, agognata ma non eseguita.
D’altronde, come dichiarava Burroughs a proposito del suo personaggio in appendice al romanzo: Lee è un “disintegrato, disperatamente bisognoso di contatto, del tutto insicuro di sé e dei propri obiettivi”.
In questo, il personaggio di Craig è di sicuro uno scrittore: c’è sempre la fantasia o l’estasi del sogno, peraltro nutrita dall’abuso di oppiacei, a risarcirlo di ciò cui anela.
Durante le scorribande di Lee in sottofondo ribolle una colonna sonora grunge, una scelta spiazzante almeno quanto azzeccata. Più prevedibile sarebbe stato se Guadagnino avesse scelto i dischi di Stan Getz, Charlie Parker e Miles Davis che in questa fase Burroughs ascoltava insieme a Kerouac: opere enormi che hanno a loro volta ispirato la loro wild form. E però il suono sporco delle chitarre anni Novanta, nel suo staccarsi dal glamour del decennio precedente, risulta dissonante e insieme incredibilmente aderente alle atmosfere beat dei Sixties (stagione che del resto ha non poco salato il sangue ai Nirvana): è la voce graffiata di Kurt Cobain a scandire la notte che scorre sordida per le calle messicane. Ed è per queste strade che, per quanto estrema nella sua fumosa ricorsività, la routine di Lee subisce uno squasso. Attratto da un crocchio di messicani accalcati intorno a un combattimento tra galli, il suo sguardo posa sopra la mischia e si impiglia a quello di un ragazzo dall’altra parte della strada – è il principio di un’ossessione.
Guadagnino, sollecitato su questo aspetto, ha detto che per lui l’amore è ontologicamente legato all’ossessività – e l’intera sua filmografia la si può ritenere un trattato intorno a questo postulato. Nel caso di Queer, forse, più che mai.
Dopo averlo cercato tra i locali Lee riesce ad avvicinare lo sconosciuto: si chiama Eugene Allerton ed è un ex militare, una costola rotta è il segno del suo passato. I due trascorrono una memorabile notte insieme bagnata di pessimo cognac, ma nei giorni successivi Allerton si fa schivo, criptico, e il desiderio di Lee monta in maniera incontrollabile.
C’è una scena in cui vediamo Lee iniettarsi una dose di eroina e accendersi una sigaretta: Guadagnino tiene ferma l’inquadratura per l’intera durata del rito e intanto, alle spalle il cielo messicano, osserviamo il volto di Craig implodere di tristezza. È questo uno degli aspetti più ambiziosi della sceneggiatura: il modo cioè in cui Guadagnino riempie o dilata il tempo di un romanzo incompleto, attraversato com’è da ferite e vuoti temporali, suturandoli con la forma – spiazzante e quasi kubrickiano il modo in cui risolve l’ellissi di due anni che incerniera il libro a metà. Ma anche le riprese plogée di tutti gli oggetti che alimentano la vita dei protagonisti a cui da sempre ci ha abituato – viene da pensare ai vestiti a bordo piscina in coda alla festa di We Are Who Are.
Lee è disperato perché non sa come ottenere il suo controllo su Allerton: si propone persino di acquistare il locale con cui il ragazzo ha un conto aperto per avere qualcosa da riscuotergli. Attraverso i suoi studi, lo si vede spesso leggere, Lee viene a scoprire che in Ecuador cresce una pianta, lo yage, che è in grado di stabilire un contatto telepatico tra gli esseri umani – “Voglio parlarti senza parole” gli aveva sbiasciato Lee ebbro in occasione di uno dei loro primi incontri.
Lee propone così ad Allerton di seguirlo alla ricerca della pianta e il ragazzo inopinatamente accetta: “È sempre bello vedere posti nuovi”. È chiaro allo spettatore come l’obiettivo neanche troppo taciuto di Lee sia quello di esercitare finalmente il controllo su Allerton tramite lo yage (“il governo sovietico e quello statunitense lo stanno già sperimentando”) e di sopperire alla propria inguaribile solitudine di tossico. I due partono così per un viaggio e il film diventa a un tratto picaresco e pionieristico, nel suo avanzare per indizi o sentieri mai battuti. Durante gli spostamenti, soprattutto in aereo, Lee subisce delle crisi d’astinenza e a incrudelire il percorso c’è il vento diaccio sudamericano – la fotografia, intanto, si fa più tetra. Il freddo lo trova sotto le coperte e fiacca i numeri con cui vorrebbe sorprendere Allerton.
L’attraversamento della foresta pluviale avviene in “un’atmosfera da incubo”, una catabasi che è suggerita anche dalla presenza di Sotto il vulcano di Malcolm Lowry, libro che Lee ha con sé da una fauna, fatta di vipere e bradipi, che è introibo anticipato alle allucinazioni da trip.
I due giungono infine al luogo prestabilito, il rifugio di una donna metà curandera e metà ricercatrice, che li accoglie non poco sospetta alla porta. L’assunzione dello yage è uno dei più intensi momenti di accensione del cinema di Guadagnino: sullo schermo scorrono, armonizzate in una coreografia amorosa, scene di fusione carnale tra i due corpi. Di più: il dilatarsi si fa etereo e incarnato insieme come suggerisce la voce che echeggia fuori campo – e il pensiero procede così naturalmente alle ossessioni di Cronenberg, il cineasta che ha reso cult Il Pasto nudo, il capolavoro di Burroughs. E anche in Burroughs d’altra parte le dita sono “ectoplasmatiche” e i “pollici fantasmatici”; il contatto così febbrilmente bramato da Lee penetra, ora, a uno stato più fondo, quello della coscienza.
Anche questa non una novità per Guadagnino: una delle scene più belle di We Are Who We Are è una coreografia che i due protagonisti improvvisano sulla musica di Black Orange – e gli stati fusionali sono negli ultimi due suoi film con l’acmé dell’ amore cannibalico di Bones and all e l’abbraccio al termine del match di Challengers, seppure con la rete da tennis a dividere i due ex amici. Qui la resa però si fa più estrema.
L’indomani l’ospite, dapprima scoraggiante, li esorta a proseguire l’esperienza per condurla al successivo livello (“Avresti dovuto vederti ieri sera”, “si è aperta una porta”). I sentieri però sembrano biforcarsi – o forse Allerton non ha il coraggio di guardare dentro di sé (è spaventato da ciò che ha visto?) e preferisce continuare a sfuggirsi.
Le ultime sequenze di Lee, rimescolate con momenti della vita di Burroughs declinati in chiave di incubo surreale, ci mostrano l’uomo scrutarsi, lo fa attraverso un gigantesco occhio dilatato, con cui prende atto della propria condizione di desolazione immedicabile, e ormai da vecchio. A risarcirlo, forse, resta il ricordo del desiderio.

E dentro di sé non ha mai mancato di guardare Burroughs al punto di ammettere, nell’introduzione al libro che uscirà 30 anni dopo la sua stesura, quanto la prosa e insieme l’occasione scritturale di Queer risenta dell’uccisione della moglie Joan Vollmer con un colpo di pistola, avvenuta nel settembre del 1951, per poi aggiungere: “Sono obbligato a giungere alla terrificante conclusione che senza la morte di Joan non sarei mai diventato uno scrittore”.
In questo film Guadagnino ha voluto riversare tutto della propria visione artistica: aderendo ai desideri della sua giovinezza e informando su pellicola gli astratti furori che la lettura di Burroughs gli aveva causato adolescente.
Curiosamente, nel 1987, la medesima sensazione, e con la spontaneità solita, era stata fermata da Pier Vittorio Tondelli, lo scrittore italiano che forse più di tutti ha saputo prolungare sulla pagina certe frenesie della giovinezza: “Che gioia, nel silenzio della notte, che felicità tuffarsi voracemente in un Burroughs come a vent’anni”. Il fatto che Guadagnino abbia ipotizzato ora un riadattamento di Camere separate ci sembra, dunque, più di una coincidenza.
Leggi tutti gli articoli di Lucy dalla 81ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia






