Fare il professore di lettere significa essere additati come principali colpevoli dell’impoverimento lessicale del Paese. Ma se invece non fosse la scuola, il luogo adatto in cui imparare la propria lingua?
Al ricevimento generale, quello che si fa di pomeriggio, coi genitori che si accalcano attorno a un foglio A4 per stabilire l’ordine di arrivo, tu, che sei l’insegnante, ti senti una cosa a metà tra una rockstar col camerino assediato dai fan e un medico della mutua con la sala d’attesa piena: la gente è smaniosa di parlarti, ma furibonda perché ci metti troppo tempo per ogni visita. Non sono neanche le quattro e il tramonto ha già scurito il muro rosa della scuola in un prugna molto intenso, i genitori stanno litigando per chi deve entrare per primo e nel frattempo non entra nessuno.
A me, durante queste pause, vengono i pensieri: ma non sarà che questo buio, come Genova nella canzone di Jannacci, ora ci inghiotte e da qua non usciamo più? Anzi non sarà che, da sempre, tutti quanti entriamo a scuola a sei anni e un pomeriggio d’inverno qualunque, anziché esserne inghiottiti, siamo noi che inghiottiamo lei, e da quel momento non smettiamo più di portarcela dentro? Non sarà per questo che ogni volta che parliamo di scuola non parliamo mai della scuola com’è veramente, ma di una specie di scuola archetipica, perpetua, immutabile, che esiste solo nei nostri discorsi, nei nostri falsi ricordi, nel nostro immaginario?
Io, per esempio, insegno lettere alle medie. Lettere significa che dovrei insegnare ai ragazzi a leggere, scrivere, parlare. Sono davvero cose che si imparano a scuola? Va bene, i quaderni con le aste, i rudimenti, sì certo, ma tutto il resto (la reale comprensione di un testo, il lessico, una comunicazione efficace) si può davvero insegnare? Si è mai imparato a scuola? È mai esistita nella storia patria un’età dell’oro in cui gli italiani parlavano e scrivevano secondo le prescrizioni del Bembo e del Trissino? C’è stato mai nel bel paese dove il dolce sì suona un momento in cui questo dolce sì è suonato con l’accento giusto e la grafia corretta?
“Sì professore, mi dice uno dei pochi genitori sopravvissuti al mio sproloquio, ma mio figlio si rivolge al salumiere di sessant’anni chiamandolo ‘bro’, lei lo capisce questo?”.
Quest’anno ho 3 classi, una settantina di ragazzi: significa che fuori dall’aula ci sono un centinaio di genitori, la fila è diventata ressa. Si spintonano, si tirano per la maglia, entrano in scivolata da dietro: vederli che si azzuffano per parlare con me mi lusinga. Guardali come combattono, mi dico compiaciuto, devono tenerci parecchio all’istruzione del figlio.
Uno dei genitori falciati si rialza, entra in classe e subito mi dice: professore, mio figlio non sa scrivere in italiano, anzi non sa nemmeno parlare in italiano, mi spiega com’è possibile?
Shhhhh, gli faccio io, non parliamone per il momento: godiamoci questa riedizione del calcio storico fiorentino, vuole?
Il genitore però insiste: ma lei l’italiano a mio figlio glielo insegna o no?
Io rimango in silenzio, guardo i gatti e i gatti guardano nel sole mentre il sole fa l’amore con la luna.
Mio figlio usa “dove” come se fosse un pronome relativo, continua lui, mi spiega come mai, prof?
Io non lo so, però o mi invento una risposta o sono guai.
Vabbe’, gli dico, tanto ormai c’è chat gpt, questa generazione non avrà bisogno di sapere leggere e scrivere in italiano, ci saranno delle macchine che lo faranno al posto loro, si concentreranno su altro, potranno liberarsi da questa schiavitù e creare contenuti, immaginare, sognare, inventare e poi lasciare che la realizzazione di quanto partorito dalla loro anima venga affidata alla manovalanza digitale.
I genitori in coda fuori dall’aula non aspettavano altro che sentirmi pronunciare una di queste frasi da cyber-entusiasta: adesso possono correre dalla preside e chiedere di cambiare classe al figlio.
Non posso permetterlo, qua come niente mi ritrovo senza cattedra. Disarmo il mio rivale e mi metto a far roteare la matita della Lim come il nunchaku di Bruce Lee.
Statemi a sentire, dico, io insegno alle medie, i miei studenti non sono più esattamente bambini, undici anni sono già un’età, potrei fare come fanno gli elettricisti, gli idraulici, i meccanici: dare la colpa a quello che è intervenuto prima di me. Le maestre delle elementari, e prima ancora quelle dell’asilo, che hanno fatto? Che cosa gli hanno insegnato? Potrei tornare ancora più indietro, tentare un’anamnesi familiare e far svolgere a voi genitori un test, così, a sorpresa, su due piedi, anzi facciamolo. Punto la Bic alla tempia di una mamma e la costringo a sedersi a primo banco: adesso vediamo quante e con l’accento azzecca e quante a con la h sbaglia, cara signora, risponda a queste semplici domande, scopriamo insieme se la malattia è nel frutto o nella pianta.
La signora trema, ma soprattutto vedo che il marito sta chiamando il 112. Fingo magnanimità, la libero e continuo: potrei spingermi perfino oltre, risalire l’albero genealogico, indagare sugli antenati, dimostrare come tutte le famiglie vengano in realtà da progenitori analfabeti, contadini illetterati, e ancora più indietro, da primati senza linguaggio, scimmie prive del pollice opponibile, sospingere la catena delle responsabilità fino al primo motore immobile dell’universo, e poi presentare fattura come fa l’elettrauto: senta, qui chi ci ha messo le mani l’ultima volta ha fatto un casino, fanno 200 se paga col Pos, 150 se mi dà i contanti. No, il problema però è più radicale, dico. Solo che sto parlando da solo: i genitori se la sono svignata.
Ne afferro per il polso uno che è a colloquio con la professoressa di matematica e a bruciapelo gli chiedo: secondo lei, mi dica, esiste davvero qualcuno che abbia mai imparato l’italiano a scuola?
Scusi ma lei chi è?, mi chiede quello.
E io: LE DOMANDE QUA LE FACCIO IO, SE NON LE SPIACE.
Ma che vuole da me?, mi dice quello con l’espressione terrorizzata.
E io: mi dica, dall’unità nazionale a oggi, un secolo e mezzo, anno più anno meno, c’è mai stato qualcuno che ha imparato a scrivere e a parlare in italiano a scuola? Le risulta?
Il genitore risponde urlando impaurito: MI LASCI IL POLSO!
Sento in lontananza le sirene del 118.
Mamma mia quante storie per una leggera pressione sul polso, dico al genitore mollando la presa, vada, mammoletta, vada, corra pure a colloquio con Arte e Immagine, che con voi proprio non si può parlare.
Mi metto a girare in tondo per l’aula, cercando di far sfogare i pensieri.
“Dall’unità nazionale a oggi, un secolo e mezzo, anno più anno meno, c’è mai stato qualcuno che ha imparato a scrivere e a parlare in italiano a scuola?”.
So che alla mia domanda viene l’istinto di rispondere: sì, eccome, certo che è successo, molti, soprattutto nella seconda metà del Novecento, si sono emancipati, tirati fuori dalla povertà, conquistati una posizione sociale grazie all’istruzione pubblica, all’italiano imparato a scuola. Ne sono convinto anch’io. Mi sembra però una risposta solo parzialmente vera, e pure un po’ riduttiva: la scuola, in quegli anni, non era l’unico ente educativo, anzi, probabilmente era un ente educativo complementare, uno tra i tanti, e nemmeno quello trainante. A scuola si rafforzavano nozioni e comportamenti appresi, almeno in parte, già fuori, prima di andare in classe, e si continuava ad apprenderne di altri, sia dopo esserci entrati sia dopo esserne usciti. C’era, o almeno io così mi immagino, un generale entusiasmo per l’italiano una lingua percepita a lungo come straniera.
Giornali, radio, cinema, televisione ricorrevano in quegli anni a una koiné ancora ignota alla stragrande maggioranza della popolazione, la quale era interessatissima ad apprenderla, proprio perché non voleva essere tagliata fuori dal contesto in cui le era capitato di vivere: un contesto nuovo, nazionale, che chiedeva di essere esperito tramite questo strumento, la lingua.
Tutto spingeva verso l’italiano, e la scuola era uno dei tanti spingitori, e nemmeno il primo. Probabilmente, anzi, era uno degli ultimi, il grosso della fatica la faceva l’intrattenimento: tanta doveva essere la voglia di godersi canzoni, radiodrammi, fotoromanzi, film, quiz televisivi, giochi a premi, insomma la lingua italiana andava imparata perché ad impararla non c’era solo da trovare lavoro, c’era anche di che divertirsi.
Le ombre si allungano sulla parete del corridoio, mostrandomi come nel frattempo i genitori in fila stiano stabilendo i turni con dei duelli al primo sangue. Cado preda di interrogativi cupi, che presto evolvono in oracoli funesti: no, non c’è modo di insegnare l’italiano a scuola, e nemmeno di impararlo, non si può insegnare a nessuno la propria lingua, il mio non è un mestiere inutile, è un mestiere impossibile.
Un genitore abbatte una serie di avversari e riesce a mettermi sotto al naso lo screenshot di un editorialista che lamenta il declino della scuola dell’obbligo.
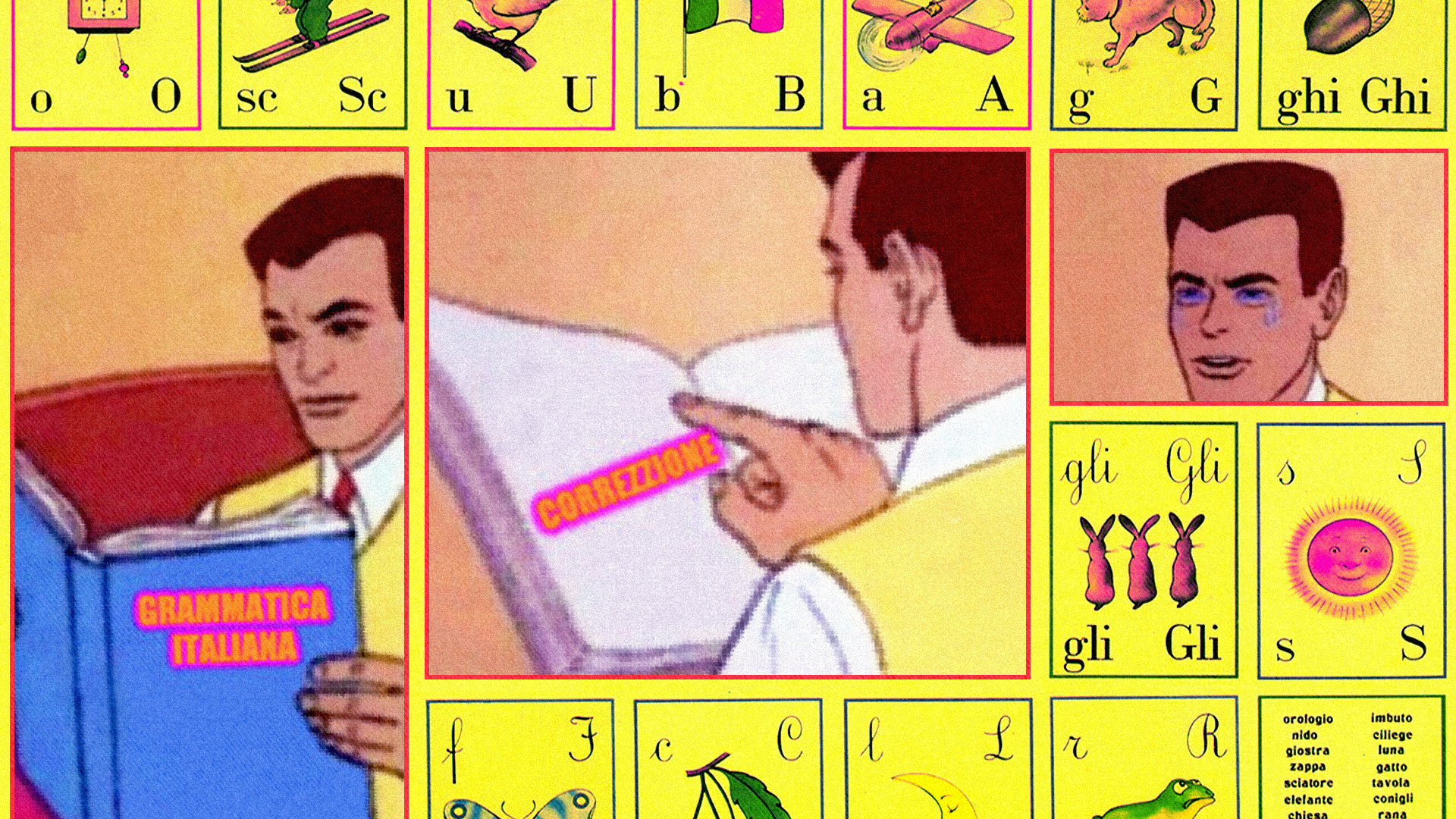
Professori universitari, psichiatri, filosofi e persone colte in generale svergognano di continuo gli influencer, gli youtuber, i gamer, i trapper, i content creator e molte altre giovani o giovanissime persone che godono di una notevole visibilità mediatica perché sbagliano le consecutio e travisano il significato di parole di uso comune, adoperandole fuori contesto o addirittura in senso opposto.
È vero che la lingua è meno sorvegliata? Secondo me sì. Siamo tutti un po’ più imprecisi nell’esprimerci, più distratti, più disattenti a quello che diciamo e a come lo diciamo. Un po’ perché diciamo troppe cose, di continuo, e controllarle tutte è difficile, e un po’ perché abbiamo poco da temere: il numero di coloro che saprebbero smascherare la nostra ignoranza va diminuendo, e, sempre più spesso, a costoro non va affatto di correggerci e fare così la figura degli odiosi, dei tronfi, dei frustrati, addirittura dei livorosi o degli invidiosi.
La seconda metà del Novecento, però, non è stata un periodo altrettanto autoindulgente e ipocrita? Ci affannavamo a dimostrarci più colti e più studiati di quanto in realtà non fossimo, ed è così che abbiamo dato vita al concetto di cultura generale. Mio nonno, che aveva fatto le scuole e l’università 40 anni prima di me, quando sentiva l’espressione cultura generale metteva mano al revolver. Per lui eravamo una generazione molto irritante: di tutto sapevamo solo un po’, orecchiavamo qua e là nomi, titoli, espressioni, delle cose che non avevamo (e non avremmo mai) letto, avevamo sentito parlare, sapevamo quel che se ne diceva o se ne scriveva, e lo usavamo ai fini della nostra impostura.
“È vero che la lingua è meno sorvegliata? Secondo me sì. Siamo tutti un po’ più imprecisi nell’esprimerci, più distratti, più disattenti a quello che diciamo e a come lo diciamo”.
Per diversi decenni, l’intrattenimento, la cultura generale si sono basati sulla lingua. Conoscere parole, espressioni, concetti, comprenderli e poi saperli restituire o riproporre o rielaborare era il segno che si apparteneva alla comunità, nazionale sì, ma anche giovanile (è nei dintorni degli anni ’60, che in Italia si scopre la categoria dei giovani); che non si era esclusi. Che a includere e a escludere fosse la lingua se ne erano accorti i didatti come Don Milani, e tutti quanti ricordiamo bene il famoso articolo che Calvino scrisse su «Il Giorno» nel 1965, definendo antilingua “l’italiano di chi non sa dire ‘ho fatto’ ma deve dire ‘ho effettuato’”.
Ne abbiamo fatto un comandamento: che senso ha complicare le cose? Perché ricorrere a sinonimi, a termini meno frequenti o addirittura desueti? Nel frattempo, però, dal ’65 a oggi, le cose sono cambiate, e adesso siamo diventati un po’ schizofrenici: vogliamo il trionfo dell’essenzialità e allo stesso tempo non vogliamo perdere la ricchezza del lessico. Stiamo con Calvino che voleva una lingua alla portata di tutti, ma se nostro figlio poi trova “effettua” su un testo e non capisce cosa significa afferriamo il trinciapolli dal cassetto delle posate e corriamo a far visita al professore di lettere assetati di sangue.
I dati Ocse-Pisa e i rapporti Invalsi dicono che il lessico si impoverisce, che i ragazzi (in particolare al Sud, dove insegno io) hanno difficoltà a comprendere un testo, che per esprimersi ci si affida sempre di più a emoticon e meme. Non dicono però che tutto questo dipende dalla scuola. Sebbene gli insegnanti si sentano costantemente messi sotto accusa dai test Invalsi, i resoconti che l’ente propone anno dopo anno sembrano, al contrario, assolvere quasi sempre la scuola ed evidenziare invece altri sintomi, come gli indicatori socio-economici, il contesto abitativo e quello familiare.
Sì professore, mi dice uno dei pochi genitori sopravvissuti al mio sproloquio, ma mio figlio si rivolge al salumiere di sessant’anni chiamandolo bro, lei lo capisce questo?
Senta, gli dico io, il fatto è che i ragazzi faticano a distinguere i contesti, per loro salumiere o partner di Fortnite non è che faccia molta differenza.
E allora?, mi dice il genitore.
E allora, gli dico io, se muore il contesto muore pure il lessico. In ogni caso, che ci possiamo fare? La lingua non è più prevalente, i testi ormai non si leggono e non si scrivono, con i testi si interagisce. Forse leggere e scrivere sono attività che stanno semplicemente perdendo d’importanza. Quando fu inventata la scrittura, alla memoria, alla capacità di immagazzinare parole a mente, accadde di vedersi sottrarre lo status di facoltà principale, fu una specie di rivoluzione, se ne parlò di sicuro in questi termini: che tempi signori miei, con questi papiri, i giovani si bevono il cervello, smettono di ricordarsi le cose, le scrivono, diventeranno scemi.
Nessuno è diventato scemo. Nessuno diventa scemo neppure adesso.
Sono le sei meno un quarto, fuori dalla scuola ci sono lo stesso buio e lo stesso caldo umido della Los Angeles di Blade Runner, una cosa come 19 gradi, a fine dicembre. Chissà che soluzione imprevedibile, geniale, impensabile troveranno i ragazzi per problemi come questo, chissà che s’inventeranno. Da una buca del cortile, un genitore mi afferra per una caviglia e mi trascina con sé dentro la voragine: mio figlio però scrive chissà senza l’accento grave, prof, qualcuno deve pagare per questo.






