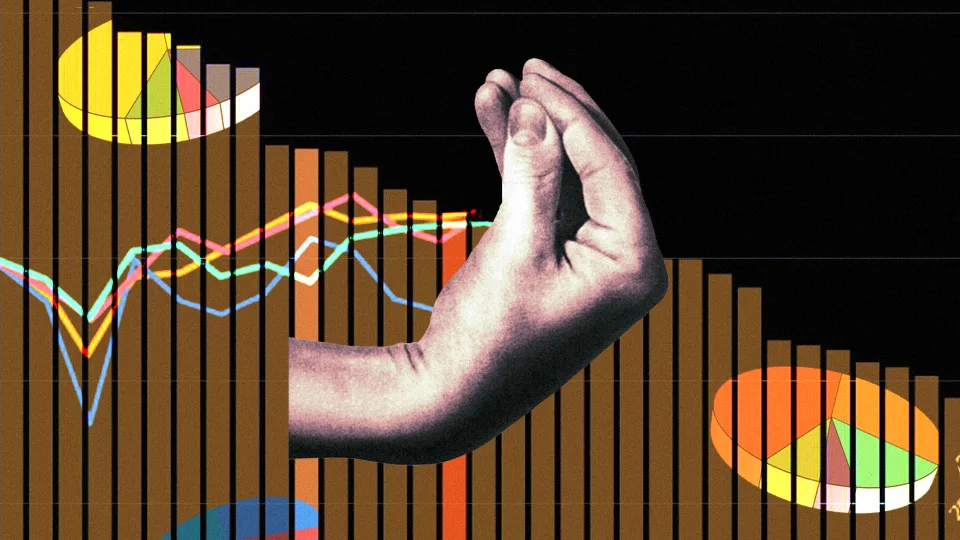L’uscita del recente "La fortuna di essere donna e altre storie per il cinema" ne i prestigiosi “Millenni” Einaudi permette finalmente di tracciare un bilancio su una delle più importanti sceneggiatrici nostrane. Un’artista riservatissima e dedita al lavoro collettivo che pare però aver lasciato traccia di sé nei tanti film scritti per altri.
Suso Cecchi d’Amico non ha mai ceduto alla tentazione dell’autobiografia. Pudore? Orrore per tutto ciò che sapeva d’autocelebrazione? Scarso interesse per le date (“Non sono il mio forte”, diceva)? Quale che sia stata la ragione, soltanto dopo gli ottant’anni (era nata nel 1914) si è decisa a confidare alla nipote Margherita d’Amico un po’ delle sue Storie di cinema (e d’altro), poi pubblicate da Garzanti nel 1996, con successo e numerose ristampe: l’ultima, per Bompiani, è uscita nel 2023. Nelle ultime pagine del libro confessa che le sarebbe piaciuto scrivere “un libro fiume, di quelli lunghi più di mille e cinquecento pagine, come i romanzi inglesi dell’inizio del Settecento”. Un grande affresco su trent’anni di vita italiana, dal fascismo al secondo dopoguerra, osservati da una prospettiva d’eccezione: il salotto di corso d’Italia 11, a Roma, dove, a partire dal 1924, il critico e scrittore Emilio Cecchi e sua moglie, la pittrice Leonetta Pieraccini, avevano l’abitudine di invitare la domenica i loro amici. Nomi come Bruno Barilli, Roberto Longhi e Anna Banti, Leo Longanesi, Alberto Moravia, Mario Soldati. È un vero peccato che questo romanzo non abbia mai visto la luce. “Ne sarebbe uscita “un’elegia accorata”, si giustificava lei, “io sono una persona allegra”. “E poi”, aggiungeva, “chi lo leggerebbe?”.
Sfogliando oggi il corposo La fortuna di essere donna e altre storie per il cinema (Einaudi, I Millenni, 2025, pp. 794) viene da pensare che il vero affresco di costume Suso Cecchi d’Amico l’abbia realizzato con i propri copioni. Il volume, curato da Caterina d’Amico e Francesco Piccolo, seleziona tredici titoli: una scelta a suo modo esemplare (anche se una cronologia e qualche notizia bibliografica in più avrebbero facilitato l’orientamento), in un corpus di opere che supera di gran lunga il centinaio. Quarant’anni di cinema, dal neorealismo in tutte le sue sfumature – la metariflessione di Bellissima, il rosa di Peccato che sia una canaglia, il nero quasi exploitation di Nella città l’inferno – al cinema di denuncia (Salvatore Giuliano), dal superspettacolo d’autore (Rocco e i suoi fratelli) alla commedia di costume (Speriamo che sia femmina), fino alle aperture internazionali di Oci ciornie (per Michalkov) e I pupi (per Scorsese, che non riuscì a trasformarlo in film).
Quattro sceneggiature, sei soggetti, un trattamento; ma anche un racconto focalizzato su un solo personaggio e persino una lettera. Scritti in solitaria, oppure a quattro, a sei, a otto mani, di volta in volta a fianco di colleghi come Piero Tellini, Francesco Rosi, Leo Benvenuti, Piero De Bernardi. A leggere con un po’ di attenzione, fra le righe dei materiali raccolti si cela anche una sorta di autobiografia indiretta. Così refrattaria a parlare di sé, Suso Cecchi d’Amico si rivela nella scelta dei soggetti, soprattutto di quelli inediti. È il caso, fra gli altri, di Kafès (la gabbia), proposto a metà degli anni Settanta addirittura a Zeffirelli, nel quale può riversare tutto il proprio interesse per la memorialistica d’epoca (in questo caso, la vita quotidiana delle donne nel Serraglio di Topkapı, a Istanbul).
Ma possiamo ritrovare Suso Cecchi d’Amico anche nei personaggi. Per riprendere il titolo del volume (tratto da uno dei suoi script), la fortuna di essere l’unica donna in un mondo di soli uomini (e tutt’altro che esente da un certo maschilismo) le ha dato, di fatto, ampio margine di manovra nella scelta e nella costruzione dei caratteri femminili: l’“onorevole” Angelina, interpretata da Anna Magnani nell’omonimo film (1946) di Luigi Zampa; la ladra Lina Stroppiani di Peccato che sia una canaglia (1954), costruita su misura per una quasi esordiente Sophia Loren (furono lei ed Ennio Flaiano, co-autore del soggetto insieme a Sandro Continenza, a imporla con vigore alla produzione e al regista Alessandro Blasetti: “L’avevamo vista passare a Cinecittà, bella, eccessiva, decorativa come un albero di Natale”); la figura dolente e tragica della prostituta Nadia del viscontiano Rocco e i suoi fratelli (1960) poi interpretata da Annie Girardot; la koinè di sole donne di Speriamo che sia femmina (1986) uno dei film più ariosi di Mario Monicelli, impregnato dell’intelligenza di un gruppetto di teste che, all’epoca, avevano visto e vissuto a lungo (e che infatti, come ricorda Caterina d’Amico, per questo motivo inizialmente nessuno voleva produrre).
Cinema e vita, insomma, procedono di pari passo, e non potrebbe essere altrimenti: “Appartengo a quegli anni in cui abbiamo illustrato la società che stavamo vivendo”. Una cronaca autobiografica per interposta persona (o forse per interposto medium), spassionata, a tratti minuziosa, a volte ilare e altre drammatica, più spesso malinconica. In fin dei conti, un’autobiografia che non stona nella più prestigiosa collana einaudiana, accanto alle Memorie d’Oltretomba di Chateaubriand, all’autobiografia epistolare di Byron o al Belpaese di Stoppani.
“A leggere con un po’ di attenzione, fra le righe dei materiali raccolti si cela anche una sorta di autobiografia indiretta. Così refrattaria a parlare di sé, Suso Cecchi d’Amico si rivela nella scelta dei soggetti, soprattutto di quelli inediti”.
Il cinema era arrivato presto in casa Cecchi. Babbo Emilio era uno spettatore assiduo e appassionato: andate a leggervi del suo incontro con Buster Keaton in Messico, oppure le pagine Corse al trotto dedicate ai “cinematografi poveri”. In seguito, per un paio d’anni (1932-33) era stato anche direttore artistico della Cines, che prima della fondazione di Cinecittà era stata la più importante casa di produzione in Italia. “Cecchi dice sì, Cecchi dice no”, ironizzavano gli amici, radunati ai tavolini del Caffè Aragno; ma Suso ricorderà che il padre “si occupò di cinema con l’impegno totale, assoluto, che metteva in qualsiasi cosa facesse”. I suoi gusti erano altri, però: “Avevo diciassette anni e avrei voluto essere come Joan Crawford e ballare come Ginger Rogers… I miei primi grandi amori cinematografici erano stati Charlot, Buster Keaton, il Douglas Fairbanks del Ladro di Bagdad e di Zorro”.
Il passaggio dall’altra parte dello schermo non fu però né immediato né segnato dalla canonica vocazione, quanto semmai da un bisogno concreto. Sposata dal 1938 con Fedele “Lele” d’Amico, musicologo figlio del critico teatrale Silvio, nell’immediato dopoguerra Suso si ritrova improvvisamente senza lavoro e con due bambini piccoli. È sola: il marito, che durante la Resistenza aveva militato nelle file dei cattolici comunisti, si ammala di tubercolosi ed è costretto a un lungo ricovero presso un sanatorio svizzero (le lettere fra i due sono state raccolte da Bompiani nel 2016, con il titolo Suso a Lele e la cura dei figli Silvia e Masolino). Lei si arrabatta facendo un po’ di tutto: fra le altre cose, accetta la proposta di lavoro di un avvocato milanese, certo Carlo Ponti, che all’epoca faceva il direttore di produzione per la Lux Film: le viene chiesto di collaborare a un copione tratto da Théophile Gautier sul quale sono già al lavoro Flaiano, Moravia e il regista designato Renato Castellani. La collaborazione ha vita breve, dal momento che il progetto naufraga nel giro di qualche mese; Castellani però la richiamerà dopo qualche tempo (“Gli sembravo più docile e ragionevole di Flaiano e Moravia”) per il suo film successivo, Mio figlio professore, che uscirà nel 1946 con grande successo.
Era nata una sceneggiatrice: anzi, “la” sceneggiatrice per antonomasia del cinema italiano. A proprio agio con i copioni e i registi più disparati, dai cosiddetti autori ai mestieranti, Suso lavorava senza risparmiarsi nell’unico salotto che c’era in casa (lo studio era appannaggio esclusivo del marito Lele: “Non ho mai avuto a room of my own, come auspicava Virginia Woolf”, diceva lei), destreggiandosi fra scadenze professionali ed esigenze di famiglia. Essere donna, per tornare al titolo del libro, non è necessariamente una fortuna, anche se lei, bontà sua, non sembrava farne un dramma: “L’unica gravidanza piuttosto visibile che ebbi fu la prima, con Masolino. Durante le altre due, fino al settimo mese non se ne accorse nessuno. Io non lo dicevo mai. Non volevo seccature tipo ‘si accomodi’, ‘non si stanchi’. Poi avevo bisogno di lavorare”.
Si schermiva un po’, invece, quando il discorso lambiva pericolosamente il suo status di autrice/artista: “Non si può ignorare che l’artista lavora da solo e per sé, mentre l’uomo di cinema… Che dirti? Non è arte”. E sceneggiare? È un’arte? È questo il non detto che serpeggia fra le quasi ottocento pagine di questo volume. Una domanda che sarebbe stato interessante porre a Pier Paolo Pasolini. In un suo celebre saggio definiva la sceneggiatura come una “struttura in movimento”, costituzionalmente ibrida: da una parte “opera integra e compiuta in se stessa”, dall’altra continuamente allusiva “a un’opera cinematografica da farsi”. Per quanto perfettamente concepita e sapientemente costruita, una sceneggiatura, in modo per certi versi simile ai grandi libretti d’opera di Da Ponte, Boito, Giacosa, è qualcosa destinato a rimanere inerte fintanto che rimane sulla pagina, destinata a prendere vita in un secondo tempo, ovvero una volta che viene tradotta in immagini.
Il cinema della modernità, poi, ha dichiarato guerra agli sceneggiatori. I “giovani turchi” della Nouvelle Vague volevano a ogni costo l’autore totale, e mal sopportavano la dicotomia regista-sceneggiatore: sono rimaste celebri le intemerate ai limiti del terroristico che Truffaut aveva riservato, dalle pagine dei «Cahiers du Cinéma», ad Aurenche e Bost, dioscuri della sceneggiatura francese con cui peraltro Cecchi d’Amico aveva collaborato. Non vanno meglio le cose oggi: morto il mito del regista-autore, da un po’ di tempo in qua si cerca di resuscitarne la forza demiurgica creando l’anti-mito dello sceneggiatore-autore. Come insinua il recente Mank di David Fincher, che muove dai presupposti (fallaci quando non palesemente falsificati) di Pauline Kael, senza Herman Mankiewicz non avremmo avuto Quarto potere. Orson Welles, da parte sua, avrebbe fatto spallucce: “E allora? Quello che conta è il film”, diceva a Peter Bogdanovich.
Nessuna Pauline Kael nostrana si è lanciata in difesa degli sceneggiatori italiani. Anzi, su di loro è circolata per lungo tempo una sorta di “leggenda nera”. Interpellato dal solito Truffaut ne Il cinema secondo Hitchcock, il mago del brivido, reduce da un’esperienza non troppo felice con Age e Scarpelli, liquidava in blocco la categoria con un laconico: “Come lei sa, gli italiani trascurano molto i problemi della costruzione”. Una frase ripresa come un mantra dagli emuli nostrani della politique des auteurs. Al resto hanno provveduto gli interessati. “Lo sceneggiatore è un tale che attacca il padrone dove vuole l’asino”, sentenziava sarcastico Flaiano, che questo mestiere lo fece quasi esclusivamente per ragioni alimentari, e che finì per polemizzare un po’ con tutti i registi con cui si trovò a lavorare, da Emmer a Fellini, fino a cullare il sogno di dirigere un film in prima persona (e ovviamente non ci riuscì).
D’altra parte, come saggiamente osservava Suso Cecchi d’Amico, “lo scrittore vero non può compiacersi nel lavoro di sceneggiatura”. Anche tra le figure apparentemente più affermate, comunque, non mancavano i travasi di bile. La recente pubblicazione in tre volumi dei Diari di Cesare Zavattini, che per oltre un quindicennio è stato di fatto l’incarnazione stessa dello sceneggiatore del cinema italiano, ha rivelato come, nonostante la fama e il riconoscimento della critica, il vulcanico poligrafo luzzarese si sentisse defraudato dei propri meriti dagli eccessi di protagonismo del suo regista di riferimento, ovvero Vittorio De Sica.
I titoli di testa di quegli anni parlano chiaro: sono almeno una mezza dozzina i nomi accreditati per ciascun film, con alcuni episodi entrati nella leggenda, come la scena d’amore di Fabiola (1948), per la quale Blasetti, in una sorta di delirio di onnipotenza, si spinse a consultare la bellezza di quarantasette sceneggiatori diversi. “Noi nei titoli ci mettiamo proprio tutti, anche chi non c’era”, spiegava Cecchi d’Amico, alla quale il lavoro di gruppo non dispiaceva affatto, anzi. “Ho fatto anche delle sceneggiature da sola, e direi con onore. Ma il ricordo di quei lavori non mi è caro come quello delle lunghe sedute con i colleghi, con le confidenze, le complicità, lo scambio di letture, il perdersi e il ritrovarsi, il momento del ‘dividemose i pezzi’…”. Sceneggiare per lei era questo: po’ ensemble jazzistico, un po’ bottega rinascimentale, un po’ officina per riparazioni. “Una volta”, ricordava, “con Flaiano ci divertimmo a immaginare la creazione di una bottega dello sceneggiatore. Come una piccola officina da meccanico, dove il cliente portava la sceneggiatura da rimettere in sesto o veniva a cercare qualche soggetto, magari d’occasione”.
Ecco, a ripercorrere attraverso i materiali raccolti in questo libro la lunga vita (è morta novantaseienne, nel 2010) e l’intensa carriera di Suso Cecchi d’Amico, ci si trova continuamente sballottati qua e là da una dialettica per certi versi inevitabile e irrisolvibile, antica quanto il cinema stesso: quella fra la singola intelligenza e il genio collettivo. Una dialettica che – per nostra fortuna – il libro non risolve. Ci prova, nell’introduzione, il co-curatore Francesco Piccolo, forse parlando un po’ troppo pro domo sua, ora appellandosi all’amalgama, ora alla bellezza del lavoro di gruppo, ora alle ragioni della Letteratura con tanto di maiuscola.
Soltanto verso la fine, non proprio di sfuggita ma quasi, Piccolo sembra ricordare che per Cecchi d’Amico e i suoi colleghi sceneggiare film era soprattutto un modo per guadagnarsi la pagnotta, all’occorrenza sgobbando parecchio. “È un mestiere. Le idee – va bene, ma sono un’altra cosa, l’idea è il soggetto. Ma poi bisogna lavorare”: parola di Suso Cecchi d’Amico. Che infatti si dichiarava “seriamente allarmata” di fronte al proliferare – ed era il 1996! – di “scuole, corsi, seminari, tavole rotonde, lezioni di sceneggiatura per corrispondenza”. “Che cosa auspichiamo?”, si domandava, “Un popolo di sceneggiatori?”. Tanto più che, secondo lei, “ciò che un maestro può insegnare si esaurisce in tre o quattro lezioni. Il resto non si insegna”; e concludeva, citando Napoleone Bonaparte: “Si potrebbe comporre un canto dell’Iliade o una tragedia di Corneille, avendo imparato soltanto le regole della metrica?”.
Un mestiere, dunque: forse è proprio questo che questa antologia finisce per celebrare. Non solo o non tanto la sua autrice e il suo magistero, né una stagione del cinema italiano che è, e resta, irripetibile (inutile rimpiangerla, lo dico agli eterni nostalgici: rassegnatevi, non tornerà più, è cambiato il cinema, è cambiata l’Italia), né tantomeno le ragioni dell’Arte o della Letteratura. Ma la dedizione quotidiana, la sapienza artigianale, la fatica autentica di chi, letteralmente, viveva di cinema.