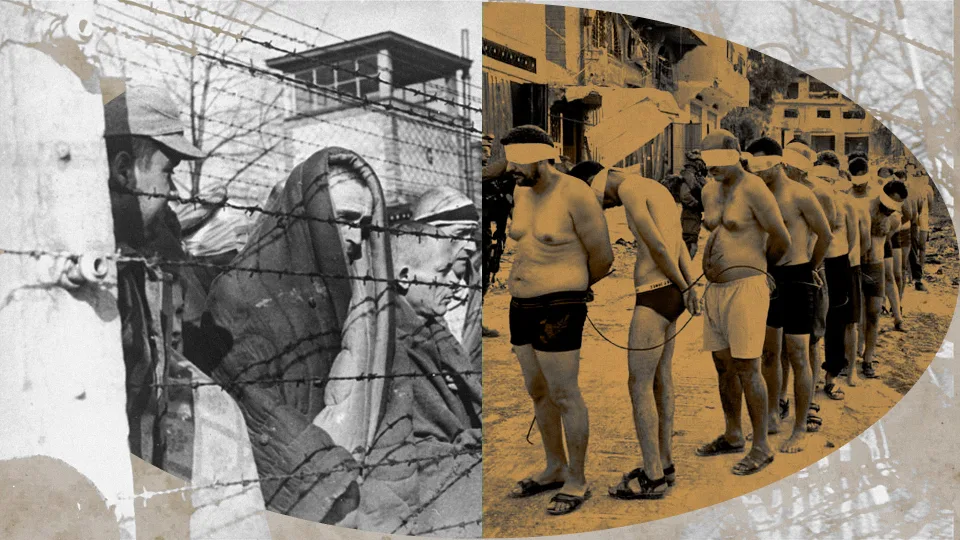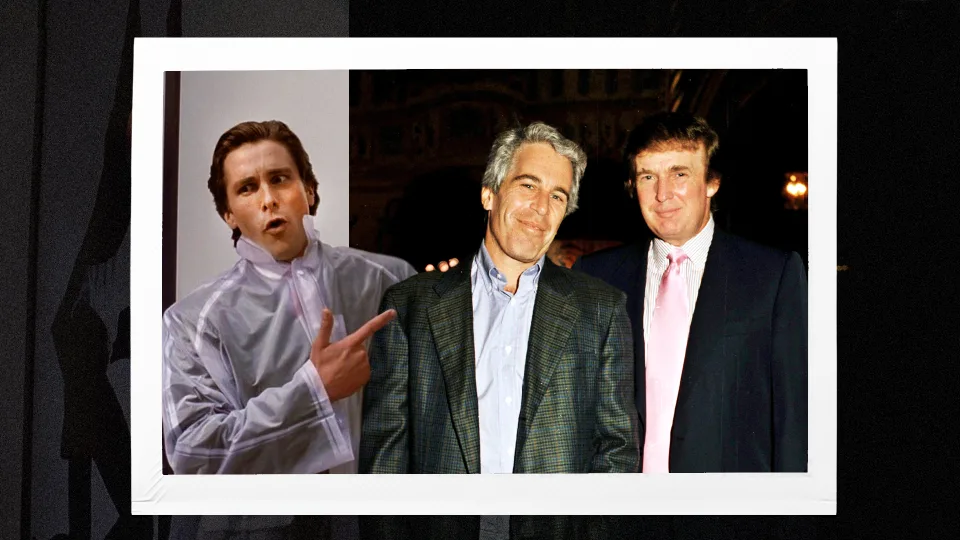In “Reykjavík, amore”, l’autrice islandese racconta cinque donne di fronte al cambiamento. Che ha le fattezze di un “angelo” texano.
Guðrún Eva Mínervudóttir è una delle più note scrittrici islandesi contemporanee. Nata a Reykjavík nel 1976, inizia a scrivere dopo la laurea in filosofia, viaggiando fra Olanda e Grecia. Esordisce nel 1998 con Il creatore, pubblicato in Italia da Scritturapura nel 2010, nella traduzione di Silvia Cosimini – che tradurrà anche tutti i suoi libri successivi. Nel 2011, con Tutto si risveglia con un bacio, vince il Premio Islandese per la Letteratura e nel 2019 le viene assegnato il Premio Islandese per la Letteratura Femminile.
Le sue storie, che hanno spesso al centro i margini, la femminilità, l’amore, sono intrise di elementi onirici e percorse da sottili distorsioni del reale: i corpi cambiano, si deformano, e il modo in cui Mínervudóttir ne racconta la trasformazione – permettendoci di esplorare la vulnerabilità umana da un punto di vista sia emotivo sia fisico – è di una delicatezza che inquieta.
Ci incontriamo in occasione dell’uscita di Reykjavík, amore (Iperborea, 2025, traduzione di Silvia Cosimini), il suo ultimo romanzo tradotto in italiano. Una storia corale e intima che raccoglie le vite di cinque donne, aprendo una piccola finestra sulla loro esistenza, dove i legami familiari e sentimentali si intrecciano con un’idea dell’amore come forza tellurica: qualcosa che ci muove, ci rompe, ci cambia. Ambientato tra le casette colorate di Reykjavík, fa della capitale islandese non solo lo sfondo delle storie, ma un personaggio a tutti gli effetti, con i suoi spazi che si dilatano e si contraggono secondo le emozioni dei protagonisti. L’appartamento, la strada, la città sono il riflesso delle geografie interiori, dove si consumano le piccole tragedie e felicità dell’esistenza.
Il titolo originale Austin, Texas gioca sulla somiglianza fonetica tra “Austin” e “ástin” (amore in islandese). Austin è anche il nome di uno dei personaggi del libro, l’unico che compare in più di un racconto. Giovane texano, si è trasferito in Islanda per aderire alla missione della comunità mormone. Lo descrivi come bellissimo, ma per il resto è una figura eterea, quasi immateriale. Chi è davvero e cosa rappresenta?
Si potrebbe pensare a lui come come all’Angelo della Fede, o all’angelo che riesce a spingerti fuori dalla tua zona di comfort. Il suo nome significa “l’amore” in islandese, quindi può anche rappresentare l’amore, ma l’amore spesso agisce come catalizzatore per il cambiamento nella vita delle persone. Si può dire che sia il Dio del cambiamento. Fa trasformare le persone. È il simbolo perfetto dell’amore.
E le cinque protagoniste? Ne racconti una piccola tranche de vie, ma è chiaro che le conosci benissimo.
Quando penso a un personaggio è come se riuscissi a percepirlo, come se sentissi che è una persona che conosco. In realtà, molti sono basati su persone che conosco realmente o che ho incontrato e di cui ho sentito l’energia, e immagino di avere un’idea di chi siano.
È come se ogni storia potesse essere un libro completo a sé stante.
Sì, è vero. Alcuni dei personaggi li ho effettivamente incontrati, come Austin. Ci siamo visti a una fermata dell’autobus e in quell’occasione gli ho chiesto se gli sarebbe dispiaciuto venire a casa mia qualche volta con il suo collega missionario, così potevo parlare con loro e conoscerli meglio perché ero una romanziera e avevo intenzione di usarli come personaggi nel mio libro. E loro hanno gentilmente accettato. Quindi, in quel caso, abbiamo avuto molte conversazioni profonde, specialmente con Austin. E così sono riuscita a conoscerli in modo da poter scrivere di loro senza preconcetti. Quello che volevo trasmettere al lettore era la mia conoscenza. Anche se i personaggi femminili lo sfiorano appena, il lettore dovrebbe provare la sensazione di averlo incontrato.
Com’è la comunità mormone in Islanda? È molto forte?
No, per niente. Ma ce ne sono alcuni, e quando li incontri li riconosci subito perché sono molto diversi dagli altri. La maggior parte delle persone trova umiliante essere avvicinata dai missionari: di solito ti fanno domande estremamente personali in pubblico – tipo “credi in Dio?” – e chi sente prova un po’ di pena per te.
Ma dopo l’uscita del libro, quando faccio le letture, alcune persone alzano la mano e dicono: “Dopo aver letto il tuo libro, sento che i miei pregiudizi verso i mormoni stanno diminuendo”. E ne sono molto felice. È questo il mio obiettivo? Non necessariamente, ma per me la buona letteratura riesce ad andare sotto la superficie del personaggio, e quando conosci davvero qualcuno è molto difficile giudicarlo. Ogni essere umano ha diversi strati ed è interessante, non necessariamente in superficie. Devi scavare più in profondità per accorgertene, e ciascuno è importante come parte della rete della vita. Se avessi scritto dei giovani missionari mormoni in modo stereotipato, come robot manipolati, mi sarei sentita una scrittrice fallita, perché sarebbe stata una scrittura superficiale. E non è quello che mi interessa.
“Quando penso a un personaggio è come se riuscissi a percepirlo, come se sentissi che è una persona che conosco. In realtà, molti sono basati su persone che conosco realmente o che ho incontrato e di cui ho sentito l’energia”.
Infatti ritrai tutti in modo molto umano e, a volte, umoristico.
Esatto. E grazie per aver sottolineato il tono umoristico, perché così poche persone si soffermano sull’umorismo nei miei libri, che invece per me è fondamentale. Lo sento sempre presente. E quando chiedo “Ma non l’hai trovato divertente?” rispondono “Oh sì, ho riso a voce alta per tutto il tempo.” Solo che è l’ultima cosa che menzionano.
I tuoi personaggi sono quasi senza filtri, sanno notare i loro difetti e riderne ad alta voce con altre persone.
Penso funzioni così anche nella vita: ci piacciono le persone un po’ indomite, a volte quasi scortesi, che non sono sempre compiacenti. Perché quando qualcuno è costantemente piacevole viene da chiedersi: chi c’è davvero dietro? Non riesci a vederlo, ha una maschera troppo spessa. Le persone che rivelano i loro veri colori le conosciamo prima e le troviamo più stimolanti, più interessanti. Vale anche per la narrativa. Secondo me, le persone con maschere sociali troppo spesse non funzionano bene come personaggi narrativi. Quando leggi, vuoi che la profondità sia accessibile, vicina alla superficie, altrimenti ti serve una voce narrante che spieghi tutto invece di permettere ai personaggi di rivelarsi completamente.
Una cosa che ho notato nel tuo libro è che, a differenza di molti scrittori islandesi, la natura non è tra i personaggi principali. Sappiamo di essere in Islanda perché ci sono alcuni piccoli dettagli come il nome delle strade, delle montagne, ma potrebbe essere ambientato ovunque.
È quello che mi ha detto anche Silvia [Cosimini, traduttrice dall’islandese, nda]. E sono davvero felice quando mi dicono che sono una scrittrice cosmopolita. Mi suona bene. Ho vissuto la maggior parte della mia vita in Islanda, soprattutto a Reykjavík. Però ho passato anche un anno ad Amsterdam, un anno in Grecia, sono stata all’estero. Credo che viaggiare sia essenziale per capire chi sei e cosa ti circonda quando provieni da un’isoletta piccola come l’Islanda. Ma in realtà queste storie cosmopolite nascondono molta natura.
Una piccola curiosità sulla traduzione: nella versione italiana i dialoghi hanno le virgolette, mentre in islandese no.
Volevo che fosse chiaro se i personaggi stavano parlando o meno. Non voglio distrarre il lettore dall’esperienza diretta di quello che gli sto raccontando obbligandolo a pensare “ma l’ha detto o l’ha solo pensato?”. Conosco i miei lettori islandesi e so quali strategie posso usare per rendere assolutamente chiaro – senza virgolette – se qualcuno sta parlando e chi sta parlando.
In Islanda, trovo le virgolette per i dialoghi un po’ old fashioned, ma non lo sono qui [in Italia], e mi fido completamente di Silvia – e di Iperborea – per capire se questo funziona anche per i lettori italiani. Ha una mente acuta e conosce molto bene la letteratura. Tutti quelli che incontro in Italia mi dicono quanto la amino e come traduca meglio di chiunque altro. Quindi è facile fidarsi di lei.
In una delle storie, una protagonista rivendica il diritto di non avere sempre un’opinione su questioni legate al femminismo. Alle donne spesso viene chiesto di pronunciarsi su questi temi, dando per scontato che debbano avere sempre posizioni forti. Cosa ne pensi?
È stato divertente esplorare questo tema. L’idea per questa storia è nata quando, a un evento, una ragazza mi ha chiesto la mia opinione sul male gaze. La domanda era così interessante e complessa che non avevo idea di come rispondere. Non ricordo nemmeno cosa le ho detto, ma tornata a casa ho pensato: “Come avrei dovuto rispondere? E perché dovrei avere per forza un’opinione su questo?”.
Era un evento organizzato da un collettivo femminista, quindi prima mi sono chiesta se fossi stata colta di sorpresa, se fossi arrivata “nuda” all’incontro, senza le mie opinioni addosso. Mi sono sentita un po’ a disagio, ma dopo averci riflettuto ho deciso, come fa il personaggio nella storia, che non è mio dovere avere un’opinione su tutto. E chi se ne frega degli uomini e del loro sguardo – non è un problema nostro.
Credo sia fondamentale ricordare che “Non lo so” è una risposta valida ed è davvero una buona risposta. È quello che cerco di insegnare a mia figlia: “Non lo so” può essere una risposta completa. Non dobbiamo sentirci obbligate a sapere tutto. Penso che nessuno si aspetti davvero questo da noi, quindi possiamo rilassarci.
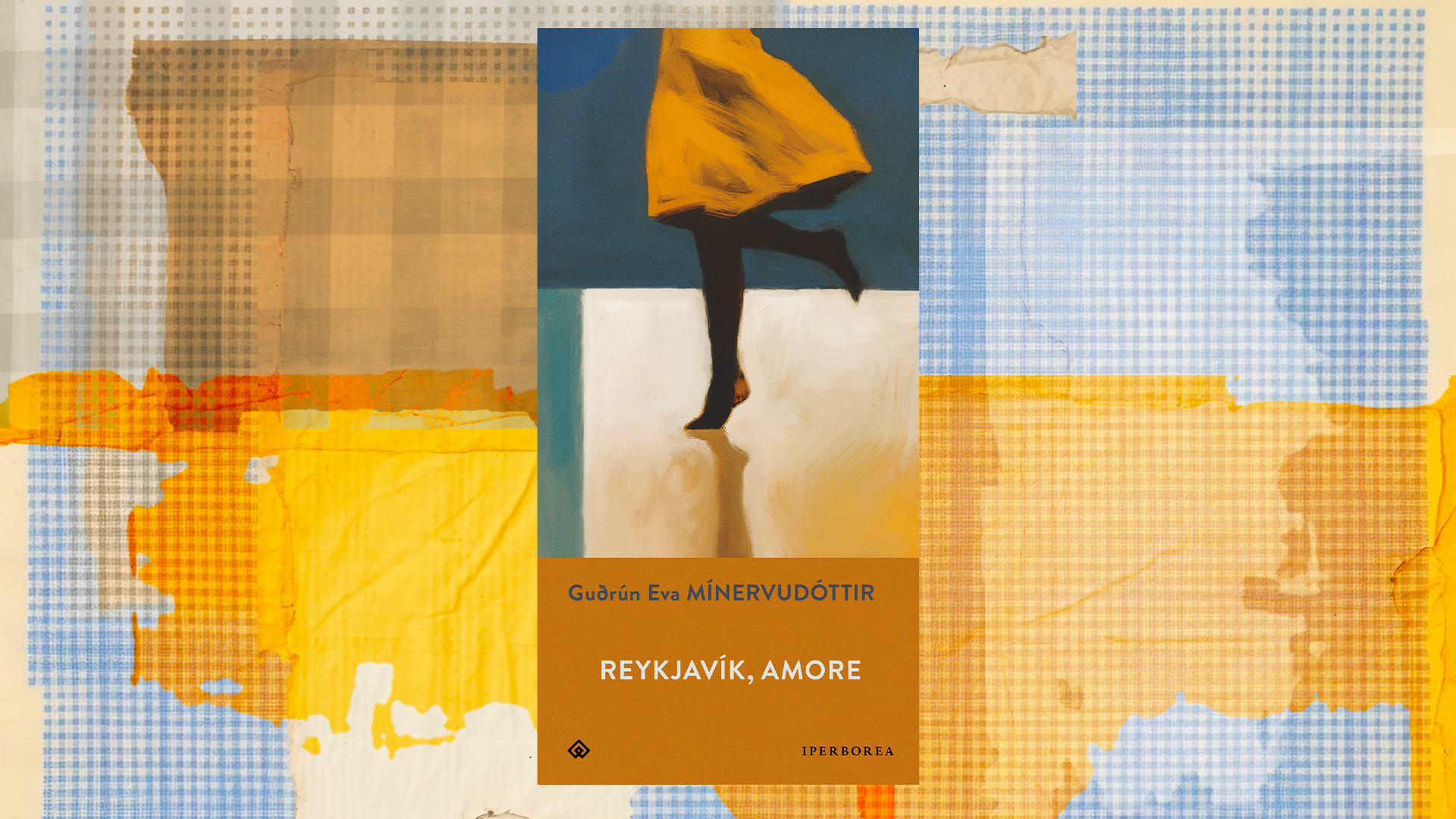
Un tema centrale del romanzo sono le relazioni amorose in tutte le loro forme e in tutte le loro fasi, dall’innamoramento alla fine. Cosa ti attrae di più nel raccontare l’amore?
L’amore ci fa perdere un po’ la testa, e sia l’edizione islandese che quella italiana del libro hanno “amore” nel titolo.
L’amore non è razionale. Anzi, può essere molto irrazionale a volte. Penso che abbia a che fare con Eros come catalizzatore del cambiamento, ma anche come entità invisibile, che va in giro e improvvisamente ti colpisce – le persone non ci possono fare niente. È come se ti distruggesse e ti ricostruisse allo stesso tempo, e tu devi semplicemente arrenderti a questo processo.
Mi vengono in mente le sirene nella mitologia greca. Odisseo si fa legare all’albero maestro della sua nave per non rischiare di saltare in mare e rispondere al loro richiamo. Ma è probabilmente l’unica persona nella storia – o nella storia delle idee, nel mito – a essere effettivamente riuscita a non saltare quando chiamata da questa forza così potente che è l’amore erotico o romantico.
In un passaggio scrivi “le relazioni d’amore sono come i falò. È bello scaldarsi intorno al fuoco, ma ogni tanto uno dei due innamorati, se non entrambi, deve avventurarsi nel buio a prendere la legna per tenerlo vivo.”
Credo che per noi oggi, come cultura, sia importante riconoscere che l’amore non è sempre destinato a durare in eterno. Spesso ci aiuta a crescere. Non è necessariamente il “vissero felici e contenti” delle fiabe.
Eppure tutti si sentono in imbarazzo se non hanno trovato il vero amore a vent’anni per poi restare insieme per sempre. Continuiamo a innamorarci, a naufragare e poi a dover ricominciare, e lo viviamo come qualcosa di cui vergognarsi, come se avessimo fallito nella “missione dell’amore”.
Mi piacerebbe poter trasformare tutto questo focalizzandoci su un altro aspetto. Quanto siamo coraggiosi a rimettere il cuore in gioco, ancora e ancora, dicendo “okay, speriamo che questa volta funzioni”? Va bene così. Ma se non dura, almeno sappiamo che cresceremo, capiremo meglio il mondo e le altre persone. Se riuscissimo a essere grati di tutto questo, sarebbe bellissimo.
L’amore si riflette anche nella famiglia, spesso in rapporti complessi, stratificati. Ognuna delle protagoniste porta con sé il vissuto, il bagaglio emotivo di altre persone che le sono vicine, e una delle scene più toccanti è quella di una giovane madre che, guardando i suoi due bambini bellissimi, si rende conto di non sentirsi alla loro altezza.
Non è straziante? Eppure quello è vero amore: volere che le persone crescano e vederle crescere, desiderare il meglio per l’altra persona. Forse il vero amore non è solo protezione e assenza di dolore, ma anche crescita e maturazione. Non a ogni costo, ma riconoscere nella crescita la cosa più preziosa che si possa sperare, perché in qualche modo lo è davvero.
Se vuoi solo preservare l’altro dal dolore diventa un amore soffocante, possessivo, non vero amore. Per me è fondamentale capire cosa sia davvero, riflettere e comprendere la sua natura, per non continuare a fare confusione e scambiare per amore dinamiche che in realtà sono tossiche.
Tutti questi racconti, anche quando hanno l’amore al centro, sono legati da un filo conduttore: l’esperienza della perdita.
Anche la morte, come l’amore, può essere trasformativa. Ho visto persone trasformarsi profondamente con la morte di una persona cara, come se tutta la loro personalità cambiasse. È incredibile.
Sembra che serva alla vita in modo simile all’amore romantico: distruggere i nostri ego così siamo costretti a ricominciare, a capire chi siamo davvero e a ricostruirci.
Non voglio raccontarla come un tabù, ma come un fatto della vita. So quanto possa essere isolante quando qualcuno sta morendo o ha appena perso una persona cara. Soprattutto quando un giovane perde un genitore e i suoi amici non sanno come affrontare la situazione, il telefono smette di suonare…
“Anche la morte, come l’amore, può essere trasformativa. Ho visto persone trasformarsi profondamente con la morte di una persona cara, come se tutta la loro personalità cambiasse. È incredibile”.
Una delle donne di Reykjavìk, amore è in fin di vita e quando incontra Austin ha un forte desiderio di comunicare con persone che sanno guardare la morte negli occhi. Austin può farlo perché rappresenta anche l’amore divino, non è interessato al lato materiale delle cose. Crede che siamo anime da salvare per essere al sicuro con Dio dopo la morte. Quindi le dice “Ah, intendi che stai morendo? Per noi questo non conta davvero, non cambia nulla.”
È questo sentimento liberatorio che la colpisce. Ovviamente lo accoglie, anche se non sente il bisogno di avvicinarsi alla religione. Ma ha bisogno di questo atteggiamento. Non fa parte della job description di un giovane missionario mormone fornire questo tipo di sostegno, ma la loro missione è essere utili nel mondo, fare del bene. Quindi in un certo senso è parte del suo lavoro, e lo sta facendo senza nemmeno rendersene conto.
Guðrún Eva Mínervudóttir sarà tra gli ospiti di Book Pride, Fiera Nazionale dell’editoria indipendente che si terrà a Genova negli spazi di Palazzo Ducale, dal 3 al 5 ottobre 2025.