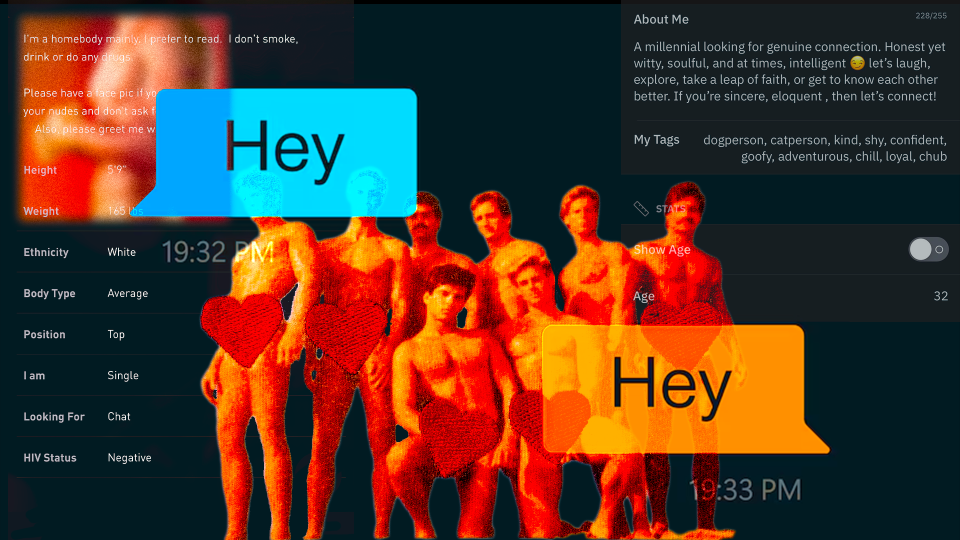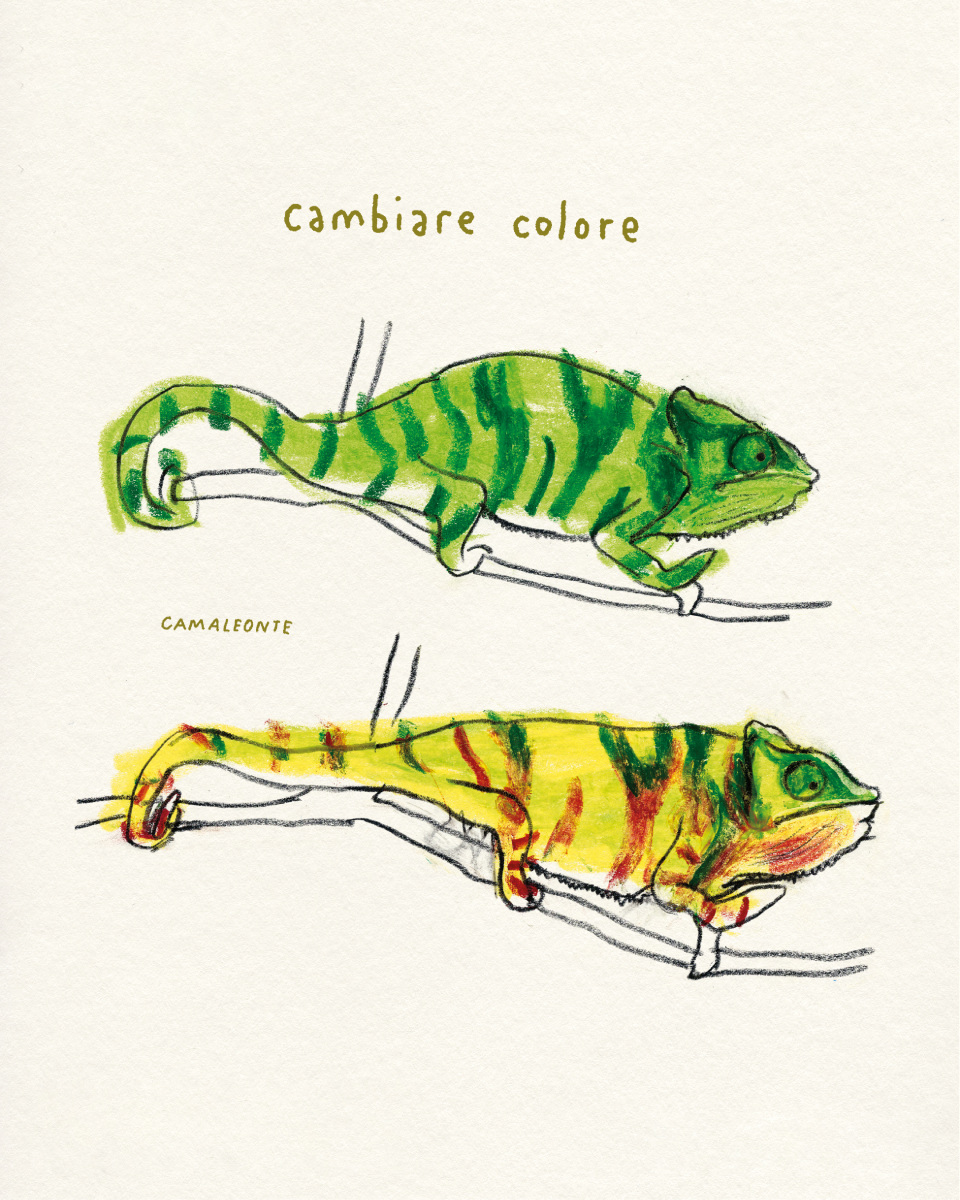Da pratica clandestina, svolta in condizioni e luoghi di emarginazione e degradazione, ora il sesso gay si può fare (anche) senza corpo. Cosa si è perso e cosa si è guadagnato in questa metamorfosi?
Per lunghissimo tempo il sesso gay è stata una pratica del tutto clandestina. Inutile tentare di quantificare con precisione: si potrebbe parlare di epoche e secoli, se non millenni, ma si dovrebbe affrontare per intero le diverse elaborazioni culturali della sessualità e del desiderio omoerotico.
Un’impresa troppo ambiziosa, che avrebbe bisogno di altri spazi. Focalizziamoci perciò sul periodo in cui inizia ad avere senso la parola gay: quando nascono una coscienza politica, un’attività militante, un vissuto anche esclusivo dell’omosessualità maschile. In genere si fissa l’inizio di tutto ciò al 1969, e quindi alla celebre rivolta di Stonewall che viene celebrata ogni anno nei diversi Pride; come sempre le cesure servono a fissare momenti-chiave, ma i fenomeni sono più fluidi. Ancora nei primi anni Settanta, che sono anche gli anni in cui personalmente mi affacciavo sulla scena, in Italia il sesso gay era ancora fondamentalmente clandestino, e confinato in luoghi non deputati, come i bagni pubblici delle stazioni, i cinema porno, i parchi, le spiagge.
La visione vulgata vede in questi luoghi un segno chiaro della degradazione e dell’emarginazione a cui erano destinati allora i maschi gay, e forse può anche essere vero. Ma c’era anche l’idea che la sessualità libera potesse riscattare i luoghi: che si potesse creare una poesia del degrado. Il rimando più ovvio e sublime è la poesia di Sandro Penna: è certo significativo che fra le più grandi poesie del Novecento italiano (non solo del Novecento, non solo italiano in realtà) siano dedicate a ragazzi visti e incontrati nei vespasiani.
Mi piace ricordare anche un racconto di Fabio Bo, intitolato per l’appunto Cinema porno, in cui il cruising nella sala semibuia, in cui si proiettano, paradossalmente, solo film porno eterosessuali, è rievocato con una nostalgia elegiaca; la stessa che traspare dal film Nuovo Olimpo di Ferzan Özpetek, anche se si tratta di un cinema con programmazione non pornografica. Nel caso invece di luoghi di cruising in contesti naturali non c’era certo la necessità di riscattare il degrado: fare sesso in un parco, nel verde, magari con una bella vista sulla Roma antica, come nel leggendario Monte Caprino, era quasi un modo di affermarne la naturalità, la bellezza, la poesia.
Ancora un ultimo aspetto da ricordare a proposito di questa fase clandestina: l’importanza dello sguardo. In quegli anni in cui non c’era ancora internet, e c’erano ancora pochi luoghi di ritrovo ufficiali, capitava ai maschi gay di incrociarsi per strada, di scambiarsi un sguardo magnetico prolungato oltre ogni prassi, di continuare a camminare per un po’ e poi di voltarsi; se entrambi si voltavano allora ci poteva essere solo un sorriso di riconoscimento, o uno scambio verbale per trovare un luogo dove avere subito un rapporto, o un appuntamento per il futuro. Questa poetica dello sguardo, che è durata anche nelle fasi non clandestine, è stata purtroppo spazzata via dalle app.
C’è un punto importante che finora è rimasto implicito: la compulsività. Che il collezionismo sia un tratto maschile, perfettamente esemplificato dal mito di Don Giovanni, e che invece la sessualità femminile tenda a non disgiungersi dal coinvolgimento sentimentale, è un’immagine culturale forte e molto radicata. Ci sono anche studi che sostengono una matrice biologica per questa differenza, direi poco credibile, ma non è il caso di affrontare qui una questione così complessa. Quest’opposizione generale fra maschile e femminile si ritrova anche nel mondo omosessuale: si tratta certo di tendenze dominanti, che conoscono innumerevoli eccezioni e sfumature, ma resta un dato innegabile, esemplificato anche da alcune battute scherzose che circolano da sempre nella comunità americana. A Provincetown, splendido luogo di villeggiatura alla fine di Cape Cod, si usa dire che una coppia gay e una coppia lesbica possono tranquillamente prenotare una sola stanza matrimoniale insieme, tanto non si incontreranno mai: i maschi tornano dalle notti selvagge alle prime luci dell’alba, quando le donne escono per andare a fare bird watching o altre pratiche di amore per la natura; oppure da parte femminile si dice, con forte autoironia, che una lesbica al secondo appuntamento si presenta già con il furgone per traslocare e vivere insieme.
“Ancora un ultimo aspetto da ricordare a proposito di questa fase clandestina: l’importanza dello sguardo. In quegli anni in cui non c’era ancora internet, e c’erano ancora pochi luoghi di ritrovo ufficiali, capitava ai maschi gay di incrociarsi per strada, di scambiarsi un sguardo magnetico prolungato oltre ogni prassi”.
C’è stato un periodo in cui questa compulsività gay maschile è stata rivendicata con orgoglio, come pratica identitaria, parte della più ampia liberazione sessuale che ha caratterizzato gli anni Settanta. Nelle prime marce di gay pride in Italia, quella a Pisa nel 1979 contro la violenza omofobica, ricordata nel documentario Pisa 1979-2009 e quella a Bologna, intitolata Orgoglio omosessuale, in cui poche centinaia di partecipanti (nulla a confronto delle centinaia di migliaia che sfilano ora) furono calorosamente accolti dal famoso sindaco comunista Renato Zangheri, ricordo che risuonava forte lo slogan “sesso selvaggio”, con la prima parola scandita per tre volte, destinato a sparire ben presto. Questa fase del sesso identitario si avvaleva anche di una serie di luoghi deputati di incontro, per nulla clandestini, che fiorivano in modo crescente negli anni Ottanta: saune, bar, discoteche, sempre dotati di dark room più o meno buie.
L’organizzazione impeccabile della comunità gay globale portò anche alla creazione di una guida apposita; la mitica Spartacus, ogni anno più voluminosa (oggi ovviamente è online, ma è anche molto meno usata), che includeva tutti i paesi del mondo, introdotti da un’utile guida ai diversi ordinamenti legislativi nei confronti delle persone omosessuali, e con un elenco dettagliato di tutti i luoghi di incontro, con i relativi servizi che offrivano, il tipo di clientela che avevano, compresi anche i cruising all’aperto, spesso bollati con la sigla AYOR, “at your own risk”: avvertimento importante, che spesso suscitava però desideri e curiosità inconfessabili. La guida Spartacus si comprava ogni anno, si portava sempre con sé nei viaggi, anche se si era in due, dato che le coppie gay tendevano a essere aperte.
Questa stagione euforica, che celebrava una libertà sessuale finalmente raggiunta, finì ben presto: l’AIDS la spazzò via in modo più o meno radicale. Negli Stati Uniti, forse perché più colpiti dalla tragedia, o perché più inclini a cambiamenti improvvisi, la metamorfosi fu drastica: si passò dall’epoca delle saune di San Francisco, in cui si potevano avere decine di rapporti in un solo weekend – e in cui pare che il grande filosofo e teorico della sessualità, Michel Foucault, abbia contratto il virus –; all’esaltazione della coppia casta e fedele, tutta protesa verso la paternità e verso un’integrazione piena nel tessuto sociale. Come il fumo, anche la promiscuità sessuale diventò improvvisamente un tabù: un relitto di un passato percepito come lontano. In Europa la reazione è stata un po’ diversa: molto più concentrata sulla difesa dal virus, sulla prevenzione e sull’informazione. La compulsività si è certo ridotta, ma non è stata cancellata o demonizzata, come avrebbe voluto una visione punitiva e moralistica della malattia, ampiamente discussa e contestata da Susan Sontag.
Non è stata la tragedia dell’AIDS a cambiare radicalmente la sessualità gay: l’hanno cambiata molto di più le innovazioni tecnologiche della svolta digitale. All’inizio internet ha offerto strade più efficaci e rapide per incontrare persone che condividono pulsioni, passioni e pratiche, ma ben presto, grazie alle app e soprattutto, oggi, ai gruppi Telegram, si è sviluppata una forte fascinazione per la dimensione virtuale, per la mediazione dello schermo. Si è giunti così al trionfo del cam sex, al paradosso di ragazzi che chiedono di realizzare online pratiche sia di sesso genitale, sia di bdsm, che hanno bisogno in realtà della presenza fisica; la banale richiesta di essere penetrato implica così un’azione realizzata da solo con strumenti meccanici e teleguidata dal partner attivo; una frase come “sculacciami in cam”, che si può trovare ripetuta in modo martellante, non ha ovviamente alcun senso, ma va intesa in una forma un po’ contorta: il master dovrebbe guidare e controllare una autofustigazione durante una videochiamata. Sono assurdi linguistici che svelano una metamorfosi radicale del desiderio e della sessualità.
A prima vista, il movente di questa trasformazione sembrerebbe di natura pratica, direi quasi di comodità: il sesso online significa non correre rischi, non dover viaggiare, non farsi coinvolgere troppo, non esporsi troppo, restare nell’anonimato. Ma certo non basta come spiegazione. Esistono poi fenomeni opposti, che radicalizzano la fascinazione per i corpi virtuali: in un universo in cui pochissimi mostrano il loro volto, ci sono persone che invece chiedono forsennatamente di essere esposte, proprio come i mariti esponevano le mogli nel famigerato, orrido sito; e lo fanno postando le proprie foto nudi, o anche in pose imbarazzanti o in atti sessuali, con relativa carta di identità e numero di cellulare.
Agli antipodi metterei il fenomeno – non esclusivo però della comunità gay – del ghosting: persone che instaurano rapporti online seri e coinvolgenti, e che spariscono poi totalmente, senza lasciare alcuna traccia, al momento del primo incontro reale. Non si può non ricordare anche il chem sex, pratica del tutto diversa ma che porta ugualmente a una smaterializzazione del sesso; gli incontri focalizzati sul consumo di droghe, se non degenerano in eventi tragici come nel celebre caso Varani, a cui Nicola Lagioia ha dedicato il romanzo La città dei vivi, si svolgono sempre, a quanto pare (non ne ho esperienza diretta) in una dinamica poco fisica e poco sessualizzata, dato che quello che conta è la festa (termine gergale che sta sostituendo il vecchio ‘sballo’).
Infine va richiamato, anche se di sfuggita, quanto tutto ciò abbia inciso non poco anche sulla prostituzione e sulla pornografia: basta pensare a OnlyFans, piattaforma digitale per abbonamento molto utilizzata in questi due campi.
Il segnale che più fa percepire un cambio di paradigma nella sessualità non solo gay è imbattersi su Telegram in ragazzi che a 24 o 25 anni dichiarano, talvolta con orgoglio, la loro verginità, o in ragazzi che si dichiarano bisessuali senza aver mai avuto un’esperienza reale né con uomini né con donne. Per la mia generazione questo era del tutto inconcepibile: non esistevano ragazzi gay vergini a 25 anni (età in cui si avevano alle spalle spesso già decine se non centinaia di esperienze) e se mai fossero esistiti non lo avrebbero dichiarato (altra cosa è il coming out tardivo: questo può avvenire a tutte le età). La matrice di questa metamorfosi non è moralistica o tradizionalista (anche se talvolta si dichiarano in attesa “dell’uomo giusto”). L’idea di base è che il passaggio dal virtuale al reale si debba fare gradualmente, con calma, e solo quando ne valga realmente la pena.
Come sempre, la reazione a queste metamorfosi prodotte dalla tecnologia non deve essere la nostalgia passatista o la lamentazione apocalittica. La soluzione migliore è intrecciare e ibridare i due piani, evitando le dicotomie troppo nette. D’altronde, vari studiosi di mediologia contestano la contrapposizione fra reale e virtuale: e in effetti noi viviamo ormai in un contrappunto continuo fra le due dimensioni, e non è affatto vero che la seconda sia il luogo dell’inautentico, del falso, dell’artificioso; le relazioni virtuali possono essere intensissime, profonde e anche bellissime.
Quello che sembra difficilmente accettabile è la cancellazione del corpo, della presenza fisica, e quindi della performance. Per fare un esempio tratto dal campo in cui mi muovo di più, quello estetico: è sicuramente un fatto positivo e prezioso che si possano trovare in streaming tanti film, registrazioni di opera, danza, teatro, o su internet tante riproduzioni di quadri, sculture, architetture, installazioni o altre immagini di vario tipo; è una ricchezza che avrebbe fatto impazzire di gioia un artista o un critico delle epoche predigitali; ma nessuna riproduzione può sostituire l’intensità estetica, l’ebbrezza che possono dare l’originale di un quadro, lo spettacolo dal vivo, il film visto in una sala buia sul grande schermo (quest’ultimo punto lo sottolineerei: trovo che la difesa dei cinema sia una delle battaglie culturali più importanti oggi). Allo stesso modo nulla può sostituire un rapporto sessuale fra due corpi in presenza.

La sessualità gay, sempre affiancata giustamente oggi ad altre tendenze non normative (pansessualità, transessualità, fluidità non binaria), ha ottenuto di recente una visibilità straordinaria, impensabile solo pochi decenni fa; per averne conferma basta dare uno sguardo ai reel dei social network, brevissimi segmenti di video provenienti da tutto il mondo, che non sono mai pornografici, ma spessissimo allusivi in modi più o meno maliziosi o ironici. Instagram, che ovviamente sa tutto di noi, me ne propone tantissimi, spesso di ragazzi particolarmente seducenti, nelle situazioni quotidiane più disparate. Siamo giunti dunque al polo opposto rispetto alla clandestinità da cui siamo partiti, ma è proprio questa disponibilità sovrabbondante ed euforica che si può trasformare talvolta nel suo contrario: nella spettralità.
Spettralità è un termine interessante e per nulla negativo: oggi esiste una corrente di studi che lavora su questo concetto (si è parlato infatti di spectral turn), applicandolo a categorie molto diversificate, come la smaterializzazione dei nuovi media o le immagini dei migranti. Già Roland Barthes affermava che ci innamoriamo sempre di un fantasma, e sulla fantasmaticità del desiderio la psicanalisi (soprattutto Lacan) ha detto cose fondamentali. È una componente che non dovrebbe intralciare però lo sviluppo di una relazione fra corpi e persone. Quello che trovo infatti inquietante è la spettralizzazione estrema di fenomeni come la spettralizzazione estrema: creare attese e desideri per frustrarli all’improvviso con un clic.