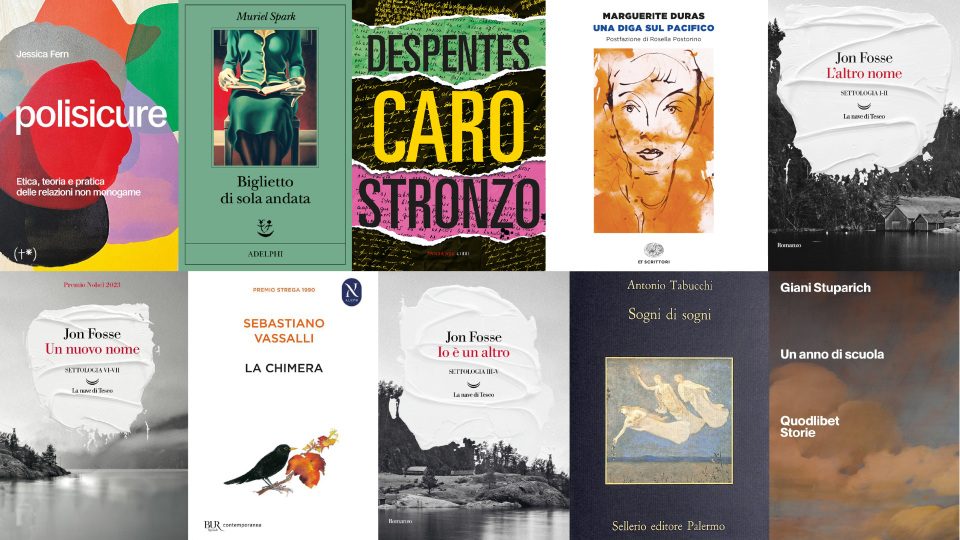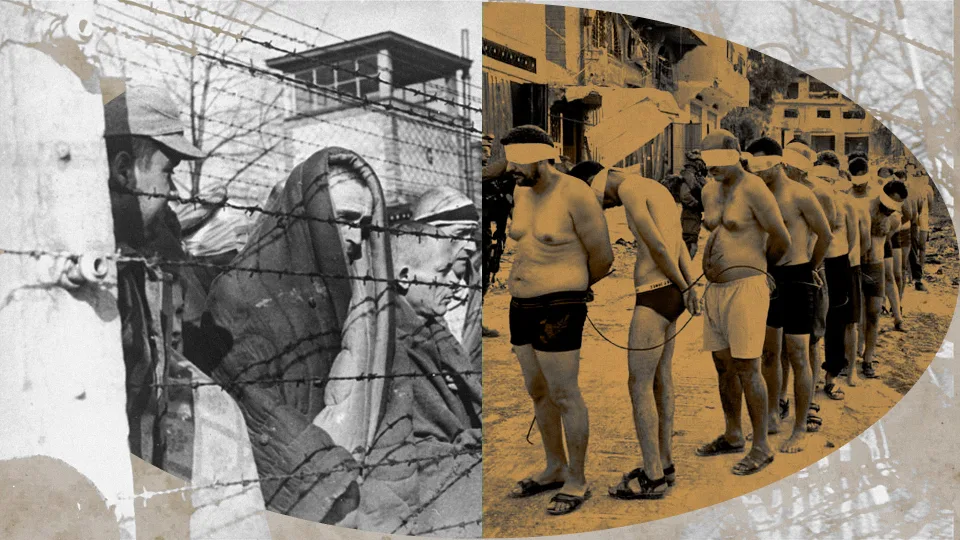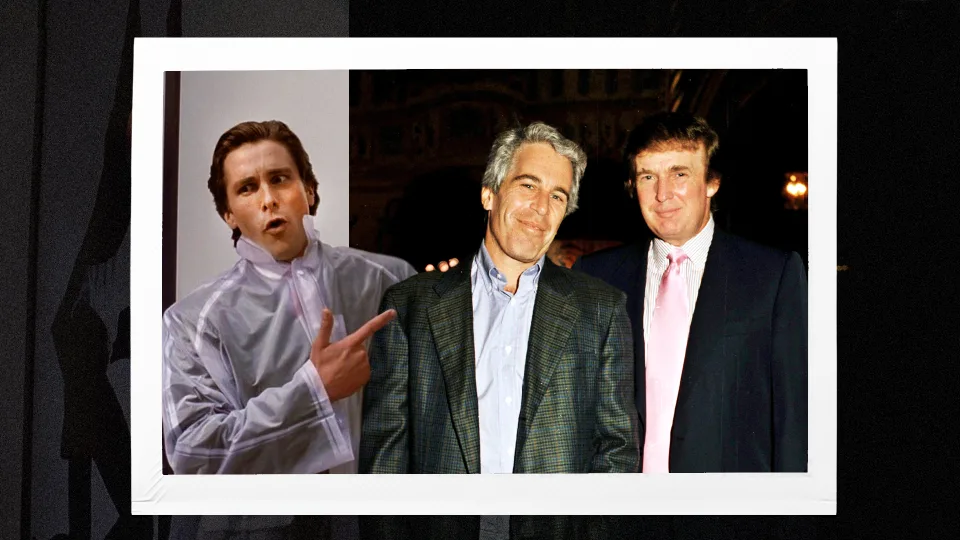Consigliati dalla redazione di Lucy, fra grandi classici, titoli da riscoprire, riedizioni o novità.
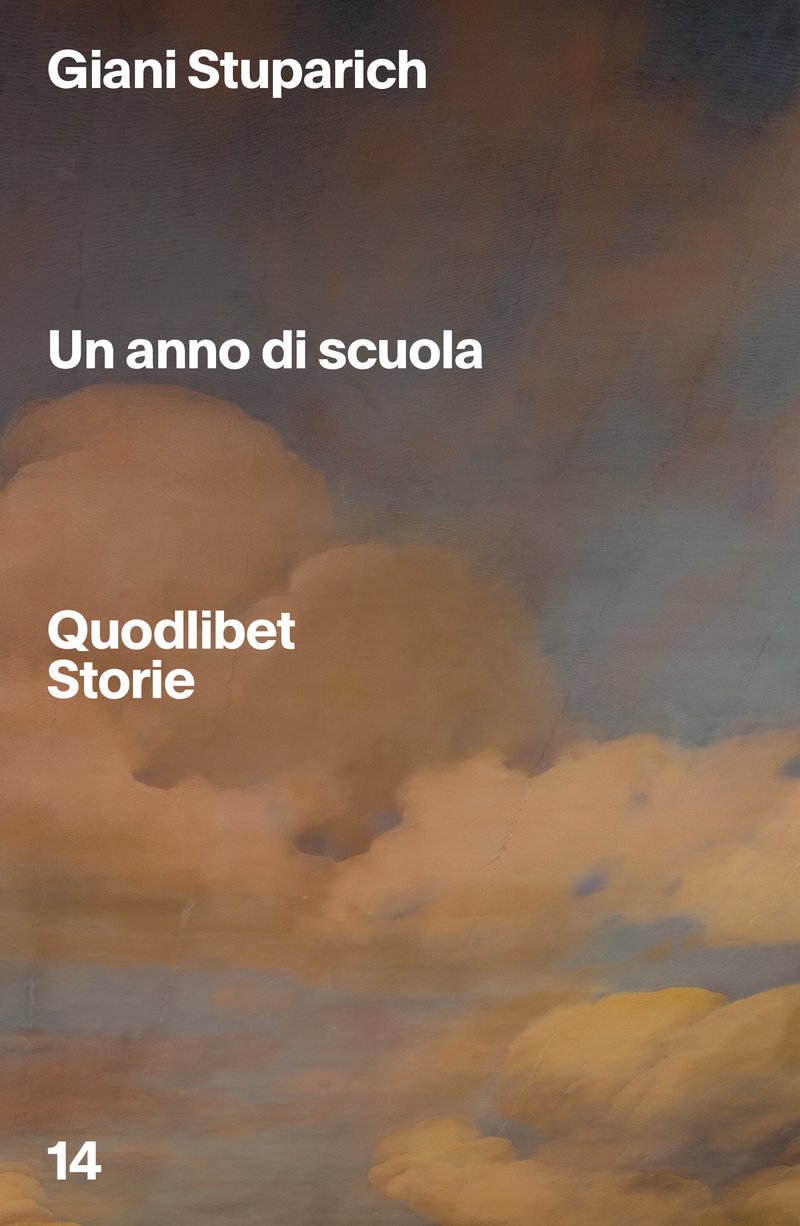
Emiliano Ceresi: Un anno di scuola di Giani Stuparich (1929; Quodlibet, 2017)
Tra i numerosi meriti di Quodlibet, rientra senz’altro il piano di ripubblicazione dell’opera di Giani Stuparich, scrittore obliato della nostra letteratura primonovecentesca. E d’altra parte in tempi di comunque non maggiore esposizione, il grande linguista Pier Vincenzo Mengaldo aveva giudicato il suo racconto, Un anno di scuola, felicissima novella in origine contenuta in una raccolta e poi valorizzata da Einaudi in un agile volumetto praticamente a sé (assieme con gli elegiaci Ricordi istriani) “un piccolo capolavoro”. La vicenda ha inizio giusto negli ultimi giorni d’estate quando la lieta brigata di un liceo maschile dell’impero asburgico si dà palpitante convegno, perfino rinunciando agli ultimi bagni, per spiare l’esito dell’esame d’accesso alla loro classe di Edda Marty, “prima donna che tentava la conquista d’un posto in quel ginnasio”. Oltre l’uscio, mentre la ragazza lotta col latino, i futuri compagni macerano sospirosi ruminando nei dubbi: “Sarebbe passata? Sarebbe stata loro compagna di classe? Quei giovani avevan sentito cose mirabili della sua intelligenza”. All’uscita, intanto, l’impatto è unanime: “Nessuno sapeva spiegarsi cosa avesse visto nei due grandi occhi […] che avevano acceso il sangue un po’ a tutti”. Fra gli aspetti più mirabili di questo racconto davvero aureo c’è lo stile assai ambivalente con cui è scritto. Da un canto Stuparich filtra una prosa affabile che riesce a descrivere con rinnovata gaiezza i gesti di un’età senza eguali. Il lessico, poi, risulta irresistibile perché d’antan (“monellerie”, “frizzi”, “sorsellinando” “abbaruffarsi” detto della sorella maggiore di Edda nei rapporti erotici coi maschi) secondo schietta volontà dell’autore che scelse di retrodatarne l’ambientazione al 1909 e di anticarne la lingua – il testo uscì invece nel 1929. Ed è a tutta prima comico lo spaesamento ingenerato dalla ragazza che con la sua voce incrina e poi scaravolta l’armonico equilibrio d’un coro di soli maschi – la classe “prova e riprova non s’accordava mai […] c’era in tutti una grande volontà d’indifferenza e di disinvoltura, ma nei fatti l’imbarazzo era evidente […] ognuno penava a riconoscere nell’altro l’antico compagno”. Al polo opposto di questa levità stanno gli effetti squassanti che la sua presenza ha sui compagni i quali reagiscono con impeti decadenti o decisamente ottocenteschi. Tanto più, dunque, attendiamo curiosi l’adattamento del racconto della regista Laura Samani che verrà presentato a Venezia nella sezione Orizzonti, e in particolare per la scelta di postdatarne la storia ai giorni nostri. Come ha scritto Montale, che di Stuparich favorì l’esordio, Un anno di scuola è anche il racconto di una cristallizzazione. Alla stessa metafora, seppure anni addietro, era ricorso Stendhal che nel suo trattato sull’amore paragonava le fantasticazioni tipiche dell’amante alle gemme che concrescono su un bastoncino immerso in un lago di sale. Ogni compagno di classe in effetti si innamora di Edda ma ciascuno, come ha rilevato Claudio Magris, lo fa a modo suo, col l’idioletto proprio, fisso a tempestarla con le sue personalissime cristallizzazoni. C’è chi si scherma dietro il “lei” nonostante la frequentazione quotidiana; chi le stampa contro palle di neve per malcelato interesse, chi, come Turez, da ilare assume “un grugno malinconico” o chi, come il timido Mitis, al suo cospetto è illuminato da fuochi d’artificio scoppiettanti di battute e doppisensi.
Se i condiscepoli coi loro strazi sono romantici attardati o frutti fuori stagione, Edda cova invece desideri a pieno moderni: ama i tuffi e le fughe laddove odia le convenzioni e i riti del provincialismo gretto: “ai costumi casalinghi e borghesi degli abitanti non si sarebbe abituata mai”. Nutre poi una relazione segreta con Antero, trasparente alter-ego dell’autore con cui per un’intensa parentesi salta le colonnine dei moli, scavalca siepi, stabilisce un contatto finalmente intimo presto falciato da incomprensioni e non detti. Mitis, altro invaghito annientato dagli struggimenti per un rifiuto, si spara infatti una pallottola in petto e, solo per un caso favorevole, non perde la vita. Edda, stretta allora tra il turbinio di affanni altrui e le pressioni della famiglia del ragazzo che ne incoraggia un fidanzamento forzoso, si ribella alla dedizione ricordandosi delle frasi che le consegnò la sorella Hedwig prima di morire per malattia: “Non credere agli uomini se prima non t’abbiano dato una grande prova […] t’attornieranno perché non sei una donna comune[…]; ma appena potranno, se tu cedessi loro, ti torranno la tua libertà”.
Dopo che la classe ha attraversato esaurimenti nervosi e presagi di morte, il finale è quasi da fiaba: un diluvio di grandine fa piovere “un tappeto bianco scrigliolante sulla città”, il liceo si trasforma in un’isola, i vicoli in rivi, e i maturandi si imbarcano su una nave per “salvare” gli insegnanti rimasti sul golfo-ginnasio in cambio della promessa d’una promozione. L’anno di scuola è terminato e a Edda restano parole di solo sconforto per la compagnia: “Non v’avete capita. Io volli essere semplicemente un vostro compagno, e voi m’avete sempre respinto e ricacciato nel mio sesso […] perché vi facessi del male”. Un’altra estate, certo diversa da quella su cui il libro si apre, può ora iniziare.
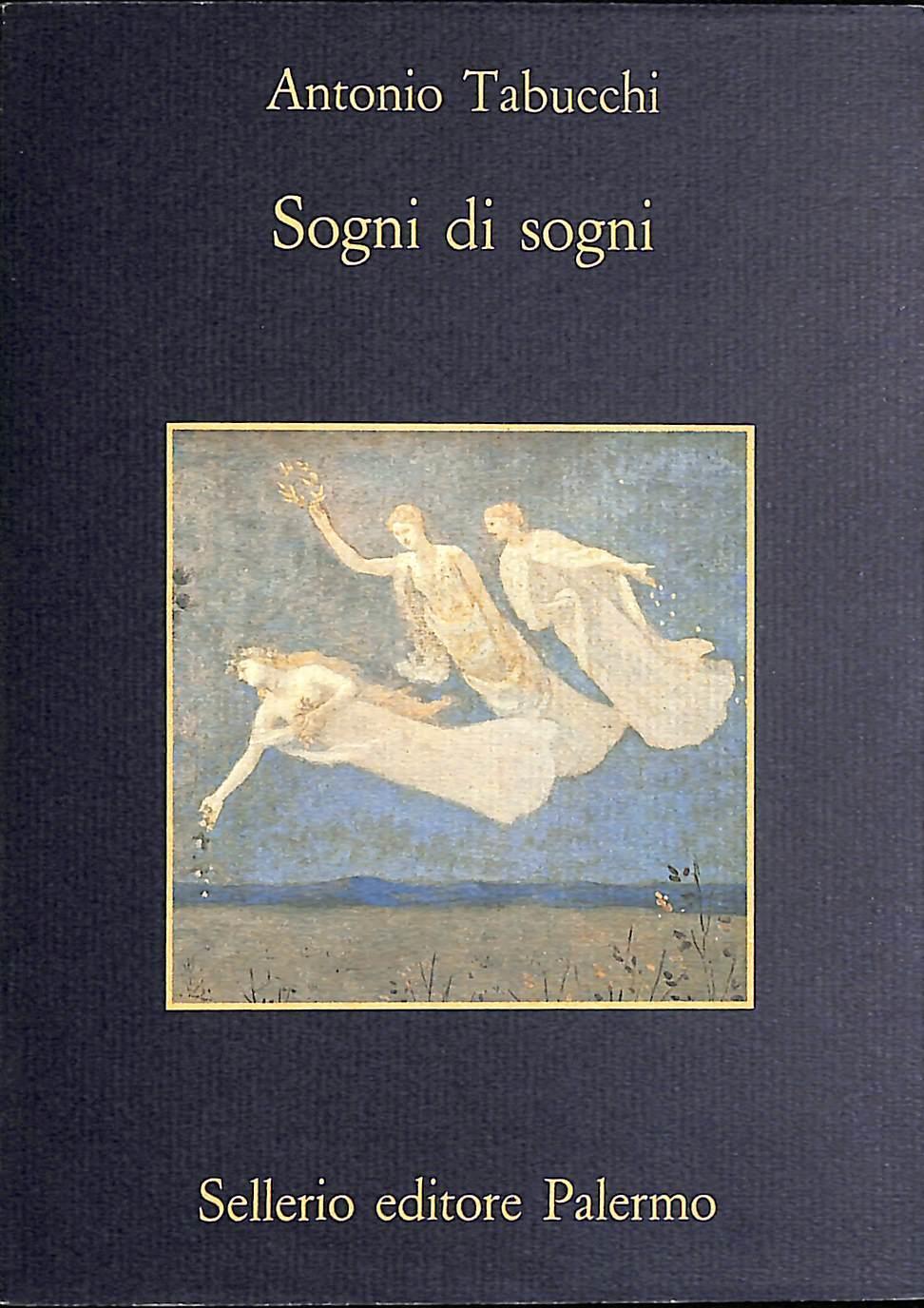
Nicola H. Cosentino: Sogni di sogni di Antonio Tabucchi (Sellerio, 1992)
Fra i libri della mia formazione, Sogni di sogni è l’unico che mi dimentico sempre di citare, o di consigliare agli altri. Stavolta per fortuna me lo sono ricordato. L’idea del libro è semplice: Antonio Tabucchi immagina i sogni di venti grandi personaggi del passato, da Dedalo a Sigmund Freud, e ne fa un gioco di citazioni e riferimenti, disseminando i racconti di riferimenti a opere, biografie e linguaggi.
Avendolo rubato (e mai più restituito) dalla libreria dei miei quando avevo undici o dodici anni, è in Sogni di sogni che ho letto per la prima volta nomi che poi mi sarebbero diventati familiari, come Toulouse-Lautrec, Majakovskij, Goya, Rabelais; è lì che ho scoperto che Apuleio era famoso per aver scritto di un asino, Coleridge di un albatros e Cecco Angiolieri qualcosa sul fuoco (perché l’asino, l’albatros e il fuoco, nel libro, sono elementi-chiave dei loro sogni. Funziona così anche per tutti gli altri).
Lo consiglio per diverse ragioni: la prima è che permette di essere discontinui, di leggere un sogno e poi passare ad altro, magari proprio a un libro diverso, prolungando il piacere per giorni, settimane, se si è molto lenti pure anni; perché Tabucchi merita di essere ricordato non solo per Sostiene Pereira e per il legame col Portogallo (sì, c’è anche il sogno di Pessoa) ma perché era uno scrittore libero, colto e fantasioso, e in questo libro si diverte così tanto e con tanta intelligenza che a tratti somiglia a Borges; infine, perché l’estate è il periodo perfetto per leggerlo, visto che in vacanza siamo propensi a ragionare per episodi (facciamo più caso alle albe e ai tramonti, mettiamo un po’ da parte la costruzione del futuro) e tutto ci sembra più vivido, a metà fra il languido e il feroce. Proprio come nei sogni, compresi quelli degli altri.
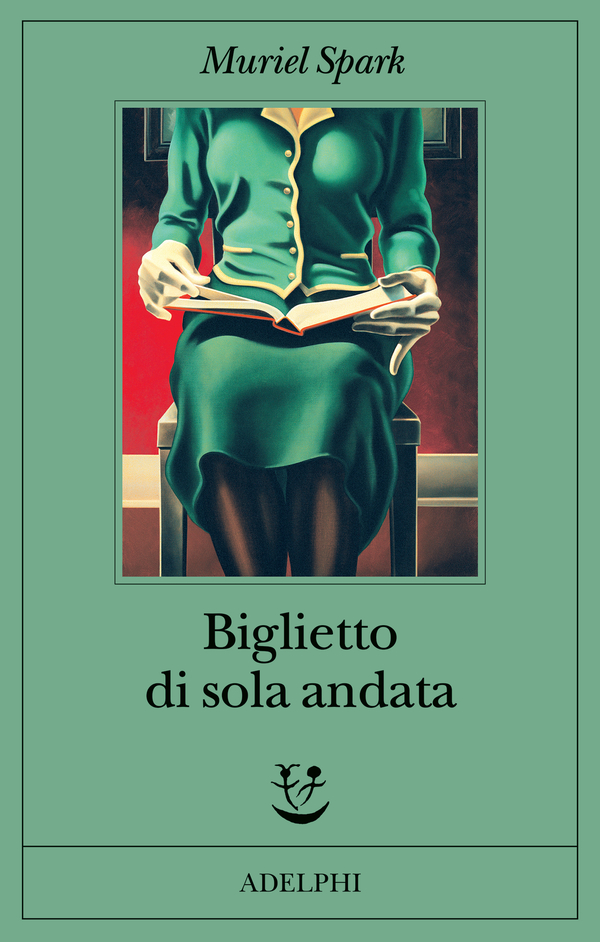
Lorenzo Gramatica: Biglietto di sola andata di Muriel Spark (1971; Adelphi, 2025. Traduzione di Monica Pareschi)
Divertente e crudele è Biglietto di sola andata (Identikit, nell’originale) di Muriel Spark, uscito questo mese per Adelphi – che ha già in catalogo molte opere della scrittrice scozzese.
Amara la sorte di Muriel Spark, da viva riverita come una delle più grandi scrittrici britanniche e collaboratrice fissa del «New Yorker», e da morta non dimenticata, ma certamente meno letta di quanto meriterebbe. Mancando alla sua produzione un grande libro – nel senso di torrenziale e convenzionalmente ambizioso, di quell’ambizione che permette, a chi la possiede, di incontrare con studiata furbizia un consenso più ampio e duraturo – ed essendo dotata di gusto per il paradosso e feroce ironia, non è difficile in fondo capire perché Spark sopravviva grazie al culto di lettori morbosamente devoti. Ma quello che Spark può offrire, compensa abbondantemente quello che forse non le è sufficientemente riconosciuto.
Biglietto di sola andata è una crime story ribaltata nello schema, dove l’omicidio è svelato molto presto, levando al lettore il piacere frivolo e chiassoso dell’ammazzamento che coglie di sorpresa. In compenso il lettore, via via che legge, attende di scoprire il movente, ma le sue supposizioni si riveleranno quasi sicuramente inesatte. E allora, tornando sui suoi passi, cercherà brandelli di indizi, seguirà piste dissestate, accumulerà dettagli nel tentativo di ricostruire un ritratto coerente dell’accaduto.
La difficoltà sta nel fatto che la coerenza non è una delle qualità che la protagonista del libro possiede. Facciamo la sua conoscenza in un grande magazzino, dove sta per acquistare un abito coloratissimo; cambia idea quando la commessa aggiunge, convinta di favorire la vendita, che il tessuto è antimacchia, sortendo l’effetto opposto. “Antimacchia? Lei crede che mi sbrodoli i vestiti? Le sembro una che non sa come si sta a tavola?”
Lise è una zitella – come il personaggio più famoso di Spark, Miss Brodie – sull’orlo di una crisi di nervi, o forse già scivolata oltre il bordo di quel precipizio che separa i sani (i conformisti) dai matti (che conformisti non possono esserlo). Nevrotica, infelice, lavora in uno studio contabile di un imprecisato Paese del nord Europa e veste con colori sgargianti, che abbina col gusto stridente di una daltonica, incurante degli sguardi di scherno che le vengono rivolti.
Obbligata dai suoi datori di lavoro a prendersi una vacanza, Lise va a Sud, in una imprecisata località italiana, probabilmente Napoli. Cerca l’uomo della sua vita e il pensiero di questa ricerca assume presto i tratti della mania. Lise ha le labbra “sigillate come la riga di un foglio di bilancio” o “come una riga in grado di cancellare tutti dalla faccia della Terra”, gli occhi come fessure e una risata che d’improvviso può accendersi isterica e prolungarsi eccessivamente, quel tanto che basta per mettere a disagio. Amabile e repellente, suscita negli altri sentimenti di paura, angoscia e tenerezza. Nelle mani di Muriel Spark, Lise è un burattino sballottato da tutte le parti, fino allo smembramento.
L’assurdo, sui toni dell’inquietante, abita il libro con una naturalezza che rende presto tutto (o quasi) plausibile. Biglietto di sola andata è giallo inusuale, referto clinico di una donna malata, racconto di una dissoluzione completa, ingegnoso carillon narrativo che diffonde una melodia sinistra che è difficile smettere di ascoltare.
(Dal libro è stato tratto il film Identikit, diretto da Giuseppe Patroni Griffi, scritto da Raffaele La Capria, con protagonista Liz Taylor e una comparsata di Andy Warhol all’aeroporto. Si può guardare qui).
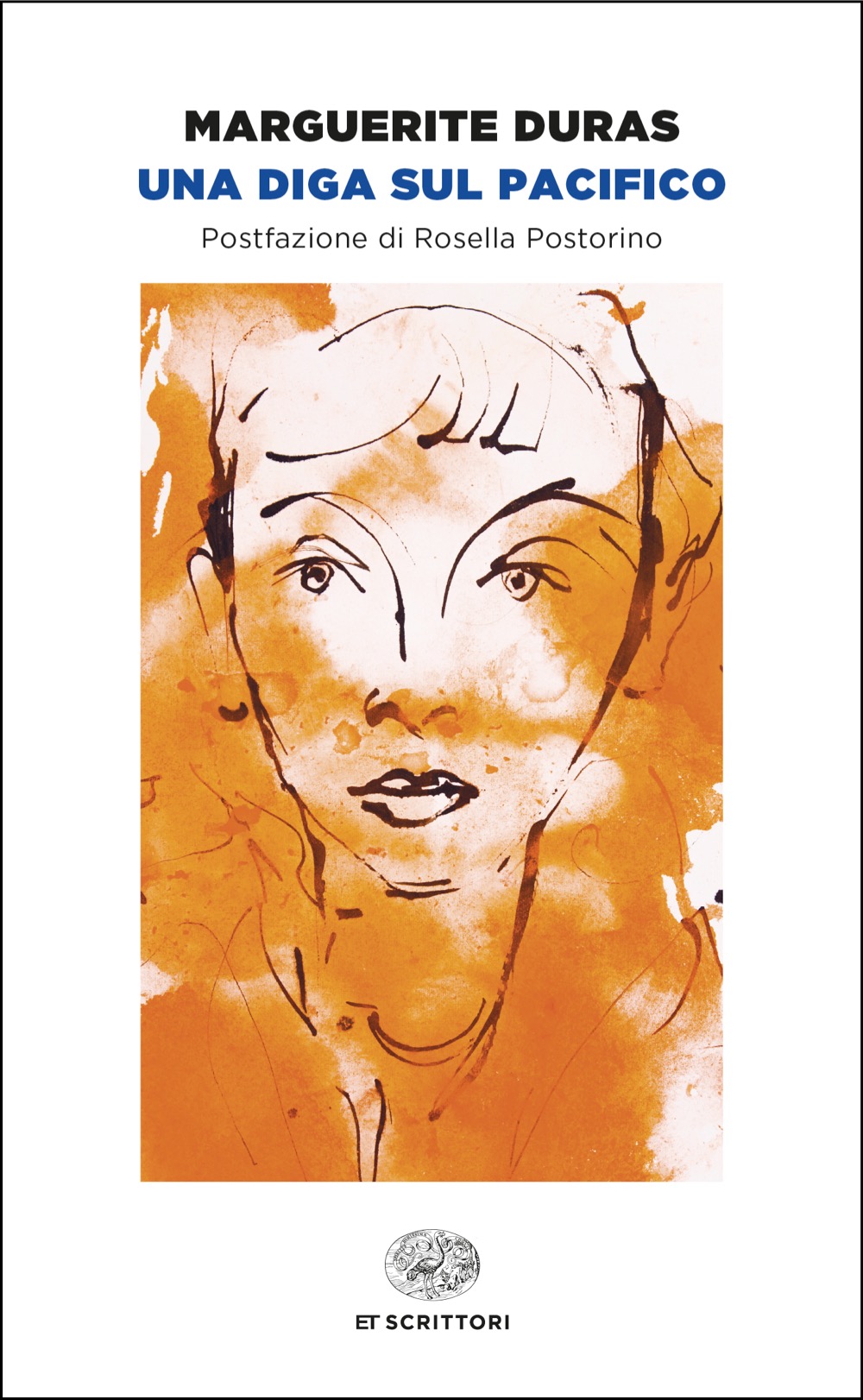
Irene Graziosi: Una diga sul Pacifico di Marguerite Duras (Einaudi, 1951; 2025. Traduzione di Giulia Veronesi)
Caro Elio, da tanto tempo non mi capitava di leggere un libro bello come il Barrage contre le Pacifique. L’ho letto in pochi giorni e non parlo d’altro (…) L’ho mandato a Natalia, che è in montagna. Intervieni anche tu, per favore, io sarei per un Corallo con grande lancio (…) È un gran bel libro senz’altro. Ciao
Questa è la lettera che Italo Calvino mandava a Elio Vittorini perché Una diga sul Pacifico di Marguerite Duras venisse pubblicato da Einaudi. Ancora oggi, dopo averlo letto, è difficile parlare d’altro.
Joseph e Suzanne vivono con la madre vedova in un bungalow nella foresta indocinese sul delta del Mekong. È il 1931. Sono coloni, sì, ma vivono nella miseria. La madre – che a differenza dei figli non ha un nome – era un tempo piena di vita, speranza e creatività. Ma dopo aver lavorato anni e anni per ottenere la concessione del terreno sul quale vivono e averlo scoperto impossibile da coltivare a causa dei monsoni che provengono dal mare e dopo aver tentato invano, in un ultimo afflato di speranza, di costruire una diga per arginare il Pacifico, qualcosa dentro di lei si spezza. Quando la si incontra, la sua speranza è frusta al punto da essersi fatta nevrosi.
Aveva amato smisuratamente la vita ed era stata la sua speranza infaticabile, inguaribile, a ridurla com’era, una disperata della speranza stessa. La speranza l’aveva logorata, distrutta, denudata a tal punto, che il sonno in cui riposava, e perfino la morte pareva non potessero più superarla.
E in effetti per tutta la durata del romanzo questa madre si adopera e si spende per obiettivi che sa in origine essere irrealizzabili. Come quando si prende cura di una bimba di un anno che le viene affibbiata da una donna del luogo che se ne vuole liberare.
La madre, che se ne intendeva, aveva visto fin dal primo giorno che non avrebbe potuto vivere a lungo. Tuttavia, chissà perché, le era venuta la fantasia di farle costruire una piccola culla da mettere nella sua camera e le aveva cucito dei vestitini. La bambina visse tre mesi. Poi un mattino, mentre la svestiva per lavarla, la madre si accorse che aveva i piedini gonfi. La madre non la lavò quel giorno, la posò nella culla e la baciò a lungo: “È la fine, – disse, – domani saranno gonfie le gambe e dopo sarà il cuore”. La vegliò i due giorni e la notte che precedettero la sua morte. La bambina soffocava e rigettava vermi che lei le toglieva dalla gola arrotolandoli attorno al dito.
La madre di Una diga sul Pacifico è la proiezione della madre di Duras – che infatti, letto il libro, non ne sarà felice – eppure è difficile non credere che questo passo del romanzo abbia anche a che fare con la morte del figlio di Duras stessa, avvenuta a due anni dalla nascita. A volte, ma forse è solo una mia idea, sembra che questa tristezza Duras la voglia diluire nella morte di tutti i bambini delle foreste:
Ne morivano così tanti che non li si piangeva più, e da molto tempo ormai non si dava loro neppure una sepoltura. Semplicemente, tornando dal lavoro, il padre scavava una piccola buca davanti alla capanna e vi adagiava il suo bambino morto. I bambini ritornavano semplicemente alla terra come i manghi selvatici dei monti, come le scimmiette della foce del rac.
Come accade con certi racconti di Doris Lessing (consiglio I racconti africani, Feltrinelli), anche tra le pagine di Duras si viene accecati dalle descrizioni luminose di questa natura feroce e bellissima che deve essersi impressa nelle retine dell’autrice quando era molto piccola e che, una volta abbandonata per tornare in Francia (o Inghilterra per Lessing), assume delle tinte nostalgiche ancora più abbaglianti.
E poi, ci sono Joseph – di cui ci si innamora come lo amano la madre e la sorella – e Suzanne, che si deve sposare troppo giovane, prima ancora di sapere qualcosa della vita. E di nuovo la madre, che è brusca e violenta con i figli e vuole che la figlia sposi un uomo ricco e disgustoso che la corteggia, ha un momento di disarmante dolcezza quando si rende conto che Suzanne, se sposasse il tremendo M Jo, dovrebbe pure andarci a letto. “E come fai”, le chiede timidamente, e lì si assiste sorpresi al sussulto apprensivo di una madre all’idea della figlia infelice e preda di un uomo disgustoso. Mi è sembrato, in quel momento e in molti altri, disseminati tra le pagine come segreti, di vedere un’altra donna, la versione alternativa della madre se la diga non avesse ceduto. Quest’altra madre avrebbe addirittura potuto permettersi di amare i suoi figli.
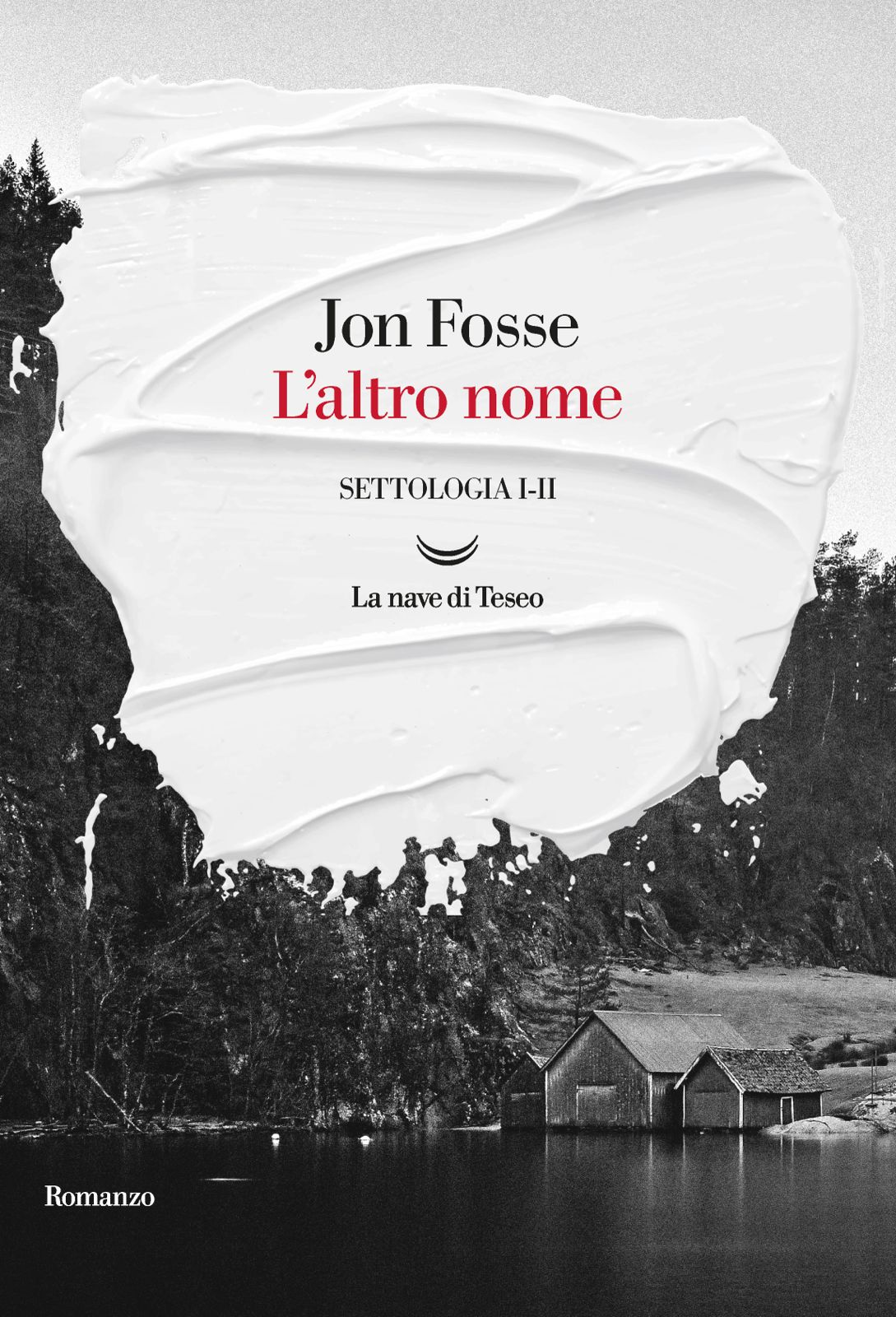
Nicola Lagioia: Settologia di Jon Fosse (La Nave di Teseo, 2021-2024. Traduzione di Margherita Podestà Heir)
Settologia è l’opera, divisa per l’appunto in sette libri, grazie a cui Jon Fosse ha vinto nel 2023 il Nobel per la letteratura. Fosse ha cominciato a scrivere all’inizio degli anni Ottanta (il primo volume di Settologia è invece del 2019) e si è occupato anche molto di teatro come drammaturgo. Qualcuno l’ha accostato a Thomas Bernhard per l’uso della lingua, ricorsivo e musicale, per il marcato formalismo.
In realtà Fosse, nato ad Haugesund, Norvegia, è molto diverso dallo scrittore austriaco. Più dolce, meno aspro e martellante, meno geometrico, poco arrabbiato con il suo paese (a differenza ovviamente di Bernhard), ma non per questo meno radicale. Anzi, forse di più. Il punto è: fino a dove siamo capaci di spingerci con la scrittura? E ancora: quando la sperimentazione non è più fine a se stessa ma necessaria per arrivare a dire, o evocare, azzardo dopo azzardo, cose che altrimenti il lettore non coglierebbe o neanche riuscirebbe a concepire?
Devo dire che la motivazione usata dall’Accademia di Svezia a proposito del premio inquadra piuttosto bene la cifra: “per le sue opere innovative e la sua prosa che danno voce all’indicibile”. Sembrerebbe che l’indicibile qui sia il “non ancora espresso” sulle emozioni umane. Ed è vero. Ma soprattutto, mi pare, a essere “indicibile” eppure “detto” da Fosse (in una maniera che non è mai direttamente politica, ancor meno di denuncia impegnata) è anche la capacità di illuminare una speranza in un mondo – devastato dall’uomo – che sembrerebbe non volerne offrire. Verrebbe da riprendere l’Eugenio Montale di Piccolo testamento: “ll tenue bagliore strofinato laggiù non era quello di un fiammifero”.
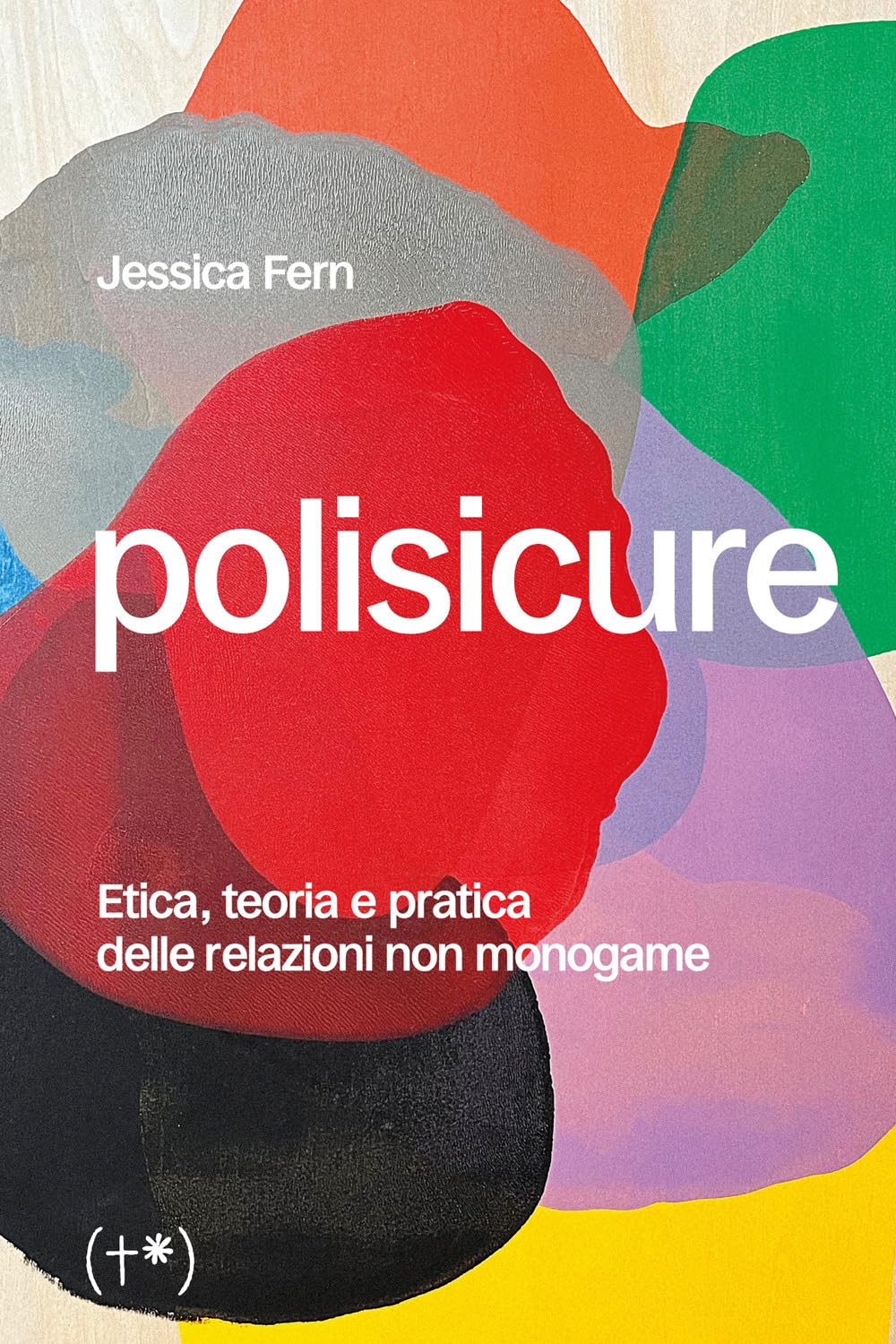
Irene Moro: Polisicure. Etica, teoria e pratica delle relazioni non monogame di Jessica Fern (Timeo, 2025. Traduzione di Assunta Martinese)
D’estate sono molte le cose che mettiamo – o cerchiamo di mettere – in pausa. Se siamo bravi o fortunati, riusciamo a sospendere gran parte delle nostre angosce, a rimandare i nostri esercizi. C’è qualcosa, però, che portiamo con noi anche in vacanza: le nostre relazioni. Che si tratti di partner fissi, di amanti occasionali, di amici o parenti, i rapporti con gli altri esseri umani ci seguono (o perseguitano) ovunque decidiamo di essere nella stagione più calda. E dato che il tempo a nostra disposizione si dilata, l’estate è forse un buon momento per chiederci qual è lo stato di salute dei nostri legami, cosa ci aspettiamo da essi, come vorremmo che cambiassero, e come vorremmo cambiare noi con loro.
Polisicure di Jessica Fern, pubblicato da Timeo lo scorso maggio, non è – solo – un libro sul poliamore e su tutte le possibilità relazionali al di là della coppia tradizionale e non è un libro contro la monogamia. Non è uno sforzo di convincimento del lettore, non vuole persuaderlo a liberarsi dall’imposizione monogama. È un’analisi meticolosa e precisa delle relazioni, di come ci definiscono e di cosa ci aspettiamo da chi è coinvolto nei rapporti che creiamo.
Chiunque, nella propria esistenza, fa esperienza di attaccamento ad altri: la teoria dell’attaccamento, elaborata dallo psicanalista britannico John Bowly e ripresa da diversi studiosi, quasi mai viene estesa a forme di relazioni diverse dalla monogamia. L’originalità del libro di Fern risiede anche in questo aspetto. L’autrice applica le diverse tipologie di attaccamento umano – sicuro, e quindi sano, o insicuro e quindi evitante, timoroso, disordinato – non solo alle dinamiche che si innescano con il o la partner primaria, ma a tutti i nostri legami, e persino al nostro rapporto con l’ambiente che ci circonda.
Fern, psicoterapeuta e teorica delle relazioni, fa tesoro della sua attività clinica, avvalorando la sua teoria con il lavoro svolto assieme ai suoi pazienti. Non dimentica, però, di mettersi in gioco in prima persona, offrendo il suo vissuto e la propria decostruzione al lettore.
Per questo Polisicure non si limita ad aprire nuovi spazi oltre al rigido schema di coppia, ma ci invita a prenderci cura delle nostre relazioni. L’autrice ci e si interroga, fornendo strumenti concreti per coltivare dei legami sicuri, sani e – se lo desideriamo – plurimi.
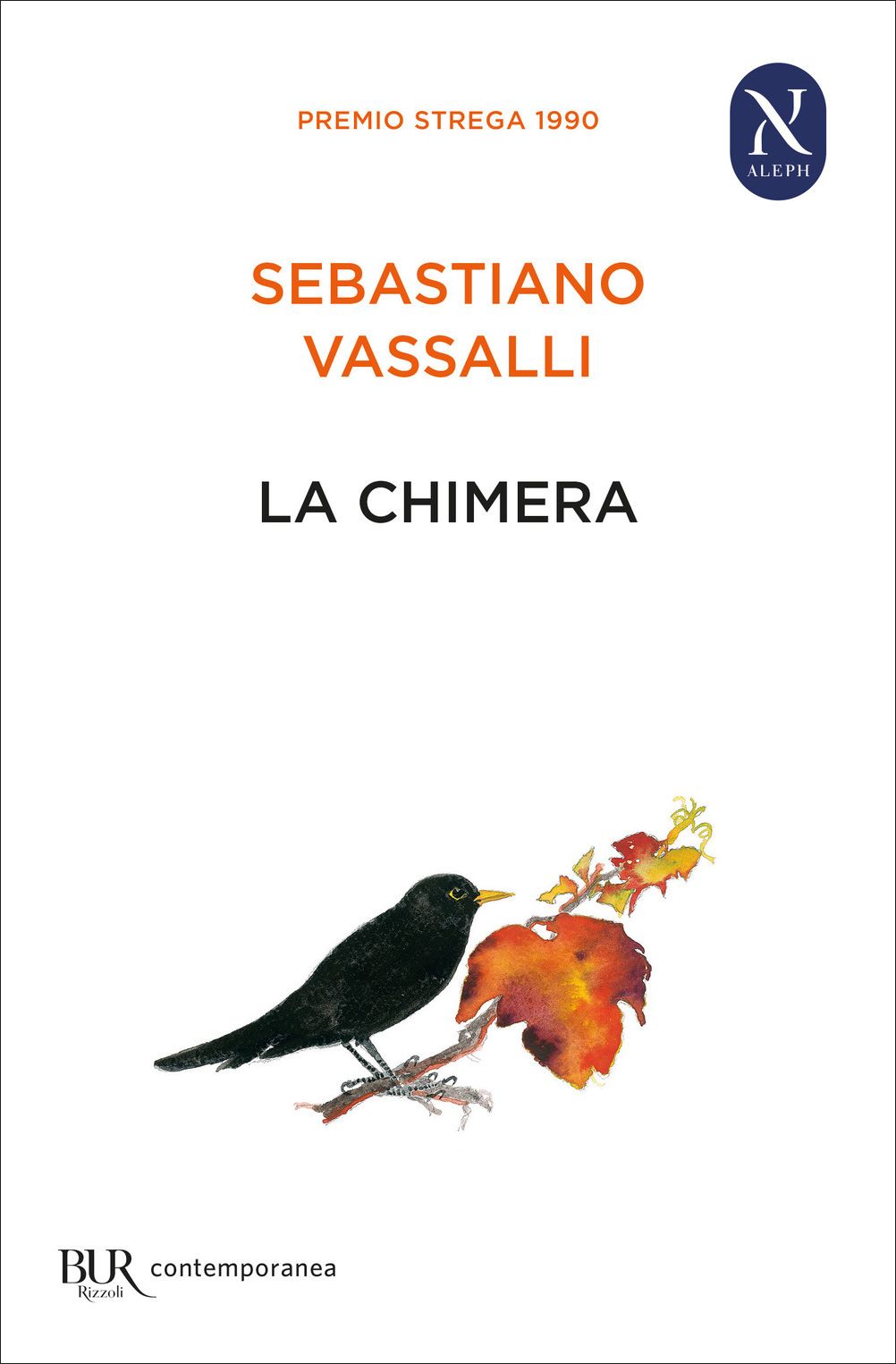
Elena Sbordoni: La chimera di Sebastiano Vassalli (1990; BUR, 2015)
“Dalle finestre di questa casa si vede il nulla. Soprattutto d’inverno: le montagne scompaiono, il cielo e la pianura diventano un tutto indistinto, l’autostrada non c’è più, non c’è più niente. Nelle mattine d’estate, e nelle sere d’autunno, il nulla invece è una pianura vaporante, con qualche albero qua e là e un’autostrada che affiora dalla nebbia per scavalcare altre due strade, due volte”.
Un merlo su un tralcio di vite. Questa era per Sebastiano Vassalli la rappresentazione perfetta del tempo e del suo scorrere: un attimo è lì, l’attimo dopo è volato via. Per questo insisté che sulla copertina della Chimera ci fosse “Il merlo della Pomposa” di Giuliano della Casa. E la spuntò. “Io avevo in mente questa immagine, e in casa editrice ne avevano in mente un’altra – un particolare di un quadro di Caravaggio. […] Dal punto di vista mio era scelta sbagliatissima: Seicento su Seicento. Diventa un cortocircuito. […] Alla fine me la passarono perché io all’epoca ero un autore di sicuro insuccesso”.
Il tempo è il protagonista assoluto de La chimera, il romanzo con cui Vassalli, di cui ricorre quest’anno il decennale dalla scomparsa, vinse il premio Strega nel 1990, entrando anche nella cinquina del Campiello. Ambientato nell’Italia settentrionale del ‘600 – di poco precedente alle avventure di Renzo e Lucia ne I promessi sposi –, La chimera racconta la storia di Antonia, un’esposta della Pia Casa di Novara, cresciuta con una rigida educazione monacale. Adottata da una coppia di contadini, Antonia si trasferisce a Zardino, da cui vede per la prima volta le montagne e in particolare il massiccio del Monte Rosa, la chimera di granito e ghiaccio che domina il paesaggio della pianura novarese. Zardino oggi è solo un luogo della memoria: sorto nei pressi della Sesia, scomparve con ogni probabilità sotto le acque di un’alluvione attorno al 1610. Ma Antonia non vedrà quel disastro: vittima di un destino crudele, viene ingiustamente condannata al rogo come strega.
Per raccontarne la storia, Vassalli si calò nell’epoca con rigore filologico: ricostruì il calendario dell’anno in cui si svolse la vicenda, consultò gli archivi dell’inquisizione di Novara e i testi coevi del vescovo Bascapé.
E lo consiglio proprio per questa immersione che consente nel passato. Dopotutto d’estate si viaggia, e leggendo La chimera si può viaggiare anche nel tempo.
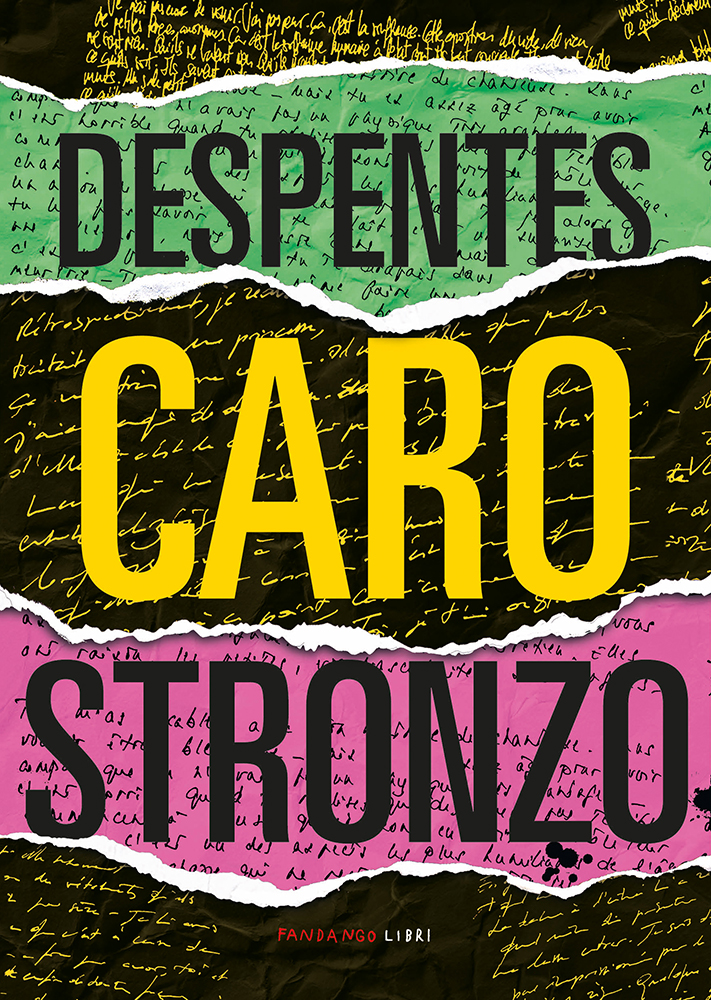
Mattia Venturi: Caro stronzo di Virginie Despentes (Fandango, 2023. Traduzione di Maurizia Balmelli)
È strano a dirsi, ma le due parole che compongono il titolo di questo romanzo epistolare sono anche quelle che danno il là all’amicizia improbabile ma autentica tra i due protagonisti. Un’amicizia che nasce sotto il segno di una stella infausta: Oscar, ex enfant prodige della letteratura francese, pubblica su Instagram un commento brutale su Rebecca, attrice cinquantenne, e quindi – come vuole l’etichetta – sul viale del tramonto. La mail di risposta che Rebecca gli invia comincia proprio con queste parole: “Caro stronzo”.
Da qui prende le mosse un duello di feroce sarcasmo che affonda le mani nei nervi scoperti del presente: il #MeToo, il conflitto tra i generi, la visibilità come risorsa e condanna, il corpo che invecchia, la maternità, la cancel culture. A interrompere il botta e risposta interviene soltanto la voce di Zoé Katana, ex ufficio stampa e attivista femminista che, sul suo blog, accusa pubblicamente Oscar di molestie. Oscar e Rebecca si scontrano, si accusano, confrontano le proprie solitudini e, facendolo, pian piano si avvicinano, cambiano attraverso il rapporto che stanno costruendo. Ecco che la schermaglia lascia il posto alla confessione, al racconto di dolori e dipendenze, delle insoddisfazioni – la figlia adolescente di lei, la carriera in declino per lui –, e il conflitto finisce per diventare un’inattesa alleanza.
Virginie Despentes, una delle voci più eversive della letteratura francese contemporanea, sceglie una delle architetture più antiche del romanzo per restituire una fotografia nitida del presente, affidandosi unicamente alla forza di una scrittura che si fa scambio, sfida, prossimità.
Caro stronzo è un romanzo rabbioso e tenero, che non si accontenta di soluzioni banali, che non concede scorciatoie, ma scavando a fondo alla fine, forse, lascia più domande che risposte.