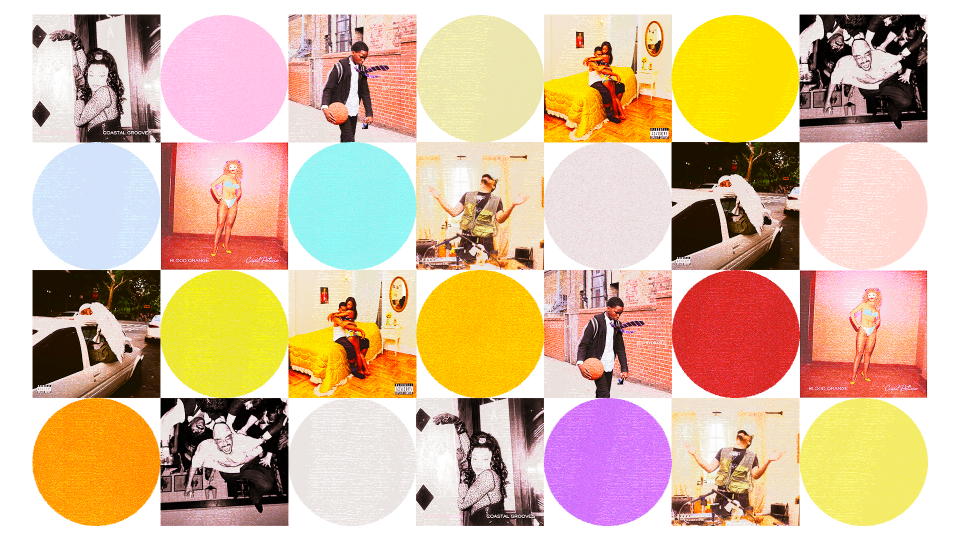I loro sono tra gli album più interessanti di questa stagione. Due lavori tra loro molto diversi ma accomunati dalla capacità di raccontare la complessità di essere maschi neri oggi.
Hanif Abdurraqib è un poeta e critico musicale afroamericano nato nel 1983 a Columbus nell’Ohio. La sua raccolta di saggi Finché non ci ammazzano (amorevolmente e pubblicata in Italia da Black Coffee nel 2021) parla di musica, politica, identità, famiglia, vita e morte in quella fase critica della storia statunitense in cui da una parte c’era un presidente nero e, dall’altra, persone nere, uomini e donne spesso giovanissimi, che venivano indiscriminatamente uccisi dalla polizia.
Soprattutto parla dal punto di vista di un giovane intellettuale nero (Abdurraqib aveva appena trent’anni quando scriveva quei pezzi per testate come il New York Times, Pitchfork ed ESPN) che s’interrogava, spesso usando la musica come cartina tornasole, sulla sua mascolinità, su cosa significasse essere un maschio afroamericano, oltre che un poeta, un giornalista e un critico in quel momento di esaltazione e paura.
Due album usciti quest’estate (Baby del produttore statunitense Dijon e Essex Honey del cantautore e produttore britannico Blood Orange) mi hanno riportato a uno dei saggi più belli di quella raccolta. S’intitola On Kindness, “sulla gentilezza”, e analizza un tema che a chi nasce bianco negli Stati Uniti o in Europa può facilmente sfuggire. Abdurraqib si chiede cosa significhi essere gentili, essere percepiti come gentili, miti, accondiscendenti per un maschio nero e americano della fine degli anni 2010. “Oggi mi viene detto molto spesso che sono gentile”, scrive Abdurraquib, “E me lo dicono più di tutti i bianchi (…) Di solito rido, scrollo le spalle e ringrazio a mezza bocca. Ma so, specialmente se a dirmelo sono persone che conosco poco, che ciò di cui si complimentano è l’assenza di qualcosa che percepivano, o che forse si aspettavano”. Ovvero la sua rabbia. “Ultimamente penso spesso alla rabbia dei neri”, conclude, “Soprattutto penso al sollievo che la gente prova quando una protesta sulle vite delle persone nere si allinea con la sua idea di manifestazione pacifica”. Chi ci guadagna da questa eterna facciata di gentilezza? È un tema molto attuale quello della rabbia di fronte all’oppressione, soprattutto quando da ogni parte si cerca di spiegare agli oppressi come sarebbe meglio che protestassero.
Il pubblico bianco non si aspetta gentilezza da un artista maschio e nero. Si aspetta solo la rabbia. E il machismo, i macchinoni, le armi, i soldi e le puttane. Tutti i luoghi comuni del gangsta rap che, soprattutto tra i bianchi e soprattutto in Europa, è diventato tutto il rap di default. In un saggio dedicato alla morte di sua madre, avvenuta nel 1997, Abdurraqib dà una sua lettura sorprendente del rap mainstream di quell’anno, il rap tronfio e grondante oro di Puff Daddy, il rap delle “shiny suites”, delle giacche dorate e dei gangsta sdoganati da Mtv. Anzitutto lo mette in prospettiva, ricordandoci che nasceva come reazione alle morti violente di Tupac Shakur e di Notorious B.I.G. e sorprendentemente legandolo, nella sua esperienza di giovane ascoltatore, alla perdita della madre. Ricorda che il rap cominciava a diventare un ascolto proibito per lui, per i suoi fratelli, i suoi amici. Sua madre era ancora in vita quando Tupac fu ucciso e, dal suo punto di vista di donna della middle class afroamericana, il rap era musica pericolosa, tossica, oscena. Quando uscì il singolo postumo di Notorius B.I.G. Mo’ Money, Mo’ Problems, la madre di Abdurraqib era appena morta e quel campionamento così scontato di I’m coming out di Diana Ross creava un ponte tra le generazioni, tra i vivi e i morti. Quel singolo girava ovunque, nelle radio bianche e nelle radio nere, e fece riflettere il giovane critico sulla potenza culturale e generazionale del campionamento: non era tanto Diana Ross, era quel suono pop-soul che riportava generazioni diverse di neri a un terreno comune, qualcosa di familiare.
“Il pubblico bianco non si aspetta gentilezza da un artista maschio e nero. Si aspetta solo la rabbia. E il machismo, i macchinoni, le armi, i soldi e le puttane. Tutti i luoghi comuni del gangsta rap che, soprattutto tra i bianchi e soprattutto in Europa, è diventato tutto il rap di default”.
Baby di Dijon e Essex Honey di Blood Orange sono due album gentili, realizzati da due uomini afrodiscendenti sensibili e colti. Uomini neri che non hanno paura di mostrarsi fragili o di parlare di famiglia, di disagio personale o di sentimenti: l’hip hop è nel loro dna musicale ma sono lontanissimi da un’estetica gangsta o machsita. Entrambi gli artisti sono estranei a beef, dissing e rivalità da pollaio e soprattutto entrambi i sono autori eclettici, stilisticamente inafferrabili e vagamente nerd. Baby è un concept album sulla paternità del suo autore (un po’ come lo era, nel 1976, Songs in the key of Life di Stevie Wonder) e Essex Honey è, di fatto, un’elegia per una madre morta da poco e per un luogo (un po’ come lo era, nel 1995 Maxinquaye di Tricky).
Dijon e Blood Orange non rappresentano tanto, come scrive qualcuno, una nuova mascolinità nera, ma più che altro sono gli eredi di un soul gentile e sofisticato sotto cui però può scorrere, come un fiume carsico, anche quella rabbia che facciamo tanta fatica a riconoscere. Blood Orange e Dijon non spuntano dal nulla: subito prima di loro ci sono stati Frank Ocean e Moses Sumney che hanno decisamente arricchito la palette di colori della mascolinità nera fino a includerci diverse sfumature di queerness. Ma prima ancora c’erano artisti nu soul come D’Angelo e Maxwell, l’uomo che ci regalò un’androgina e indimenticabile cover di This Woman’s Work di Kate Bush. Ma si può andare molto più indietro: al rapporto complesso e sfaccettato che Prince aveva col femminile e al rifiuto di diventare adulto di Michael Jackson, al soul come medicina per l’anima del reverendo Al Green o a Here my Dear, concept album del 1978 di Marvin Gaye sul suo divorzio amaro.
Essex Honey di Blood Orange è un album introspettivo e complesso che segue il filo dei ricordi della sua adolescenza passata in un’Inghilterra liminale, un po’ periferia suburbana arricchita e un po’ pittoresco quadretto campagnolo. Nel ricco vocabolario classista e sessista britannico essere una “Essex girl” vuol dire essere una ragazzona sempliciotta e un po’ volgare che dopo un paio di pinte si concede senza fare troppe storie. Quindi già dal titolo Devonté Hynes (questo il nome del cantautore che si nasconde dietro allo pseudonimo Blood Orange) fa un’operazione di deturnamento: si riappropria di un insulto e lo trasforma in qualcosa di gentile, di malinconicamente evocativo. Aveva fatto qualcosa di simile nel titolo del suo album precedente, Negro Swan (2018) che era una riflessione sull’arrendevolezza e la tendenza alla depressione tipica degli uomini neri e queer in un occidente sempre più spietatatamente razzista. Essex Honey è un viaggio a ritroso nel tempo che ha qualcosa di proustiano: a scatenare i ricordi d’infanzia è la mancanza della madre di Hynes morta nel 2023.
Se Tricky nel suo album Maxinquaye dava voce alla madre morta (la madre si chiamava Maxine Quaye) attraverso una musica che aveva qualcosa di rituale e faceva pensare a una possessione, Blood Orange fa qualcosa di diverso: segue un profumo, un tenue ricordo, una parola e, attraverso una musica frastagliata, piena di dettagli e di velature impressionistiche ricostruisce il suo mondo di ragazzo. Se Tricky faceva rivivere la madre, Blood Orange la cerca negli interstizi. Essex Honey, per essere un album così intimo, è pieno di collaborazioni, di feat. come si dice in un gergo discografico mutuato dall’hip hop: ci sono Caroline Polachek e Vini Reilly dei Durutti Column nello stesso pezzo (The Field), Ben Watt degli Everything But The Girl (in Scared of it), la popstar neozelandese Lorde (in Mind Loaded), tra i collaboratori dell’album compare anche la scrittrice Zadie Smith. Nonostante questo Essex Honey non sembra un album affollato.
Se nella tradizione hip hop i featuring vengono scelti per fare squadra, per creare connessioni tra crew, con criteri quasi da Risiko, Blood Orange li usa come pennellate di colore. Non gli importa che Lorde o Caroline Polachek siano riconoscibili per i loro fan, non le usa, come si fa in tanto pop industriale di oggi, come trofei o come occasioni di cross-marketing. A volte queste collaborazioni nascevano da incontri casuali in studio oppure Hynes aveva in mente proprio quell’artista per fargli fare quella singola cosa, come un regista. Quello che rende la musica di Blood Orange così interessante è la texture, quella consistenza diafana che è la media tra un modus operandi da produttore hip hop mescolato a una sensibilità melodica da cantautore indie. Alexis Petridis, nella sua recensione a cinque stelle sul Guardian, nota l’inglesità della musica di Essex Honey: “Il suo mood principale è quella malinconia così tipicamente britannica tra fine-estate e inizio-autunno… le sue melodie sono spesso splendide ma inevitabilmente tristi”.
Quella di Baby di Dijon (il produttore e cantante statunitense Dijon Duenas, nato in Germania da una famiglia di militari nel 1992) è un altro tipo di malinconia. È la pensosità di un uomo che, dopo essere diventato padre, fa un bilancio e si rende conto che paternità non significa necessariamente stabilità: anzi. Baby è il secondo album di Dijon dopo Absolutely, il suo debutto del 2021 tanto sorprendente da un punto di vista produttivo quanto ignorato dal mainstream. Se Devonté Hynes è un sofisticato cantautore indie pop con la sensibilità e la nerditudine da produttore hip hop, Dijon è un classico cantante soul con le orecchie rivolte al futuro. Se Blood Orange è un produttore raffinato, colto e pieno di sfumature, Dijon ama il rischio, cerca il glitch, il difetto, l’imperfezione e anziché cancellarla la cavalca, la fa sua. Il suo strumento è la voce che lui non ha paura di manipolare, campionare e filtrare.
Quando è uscito Baby in molti hanno paragonato la sua voce a quella di Prince. L’origine del suo falsetto è la stessa: quelle note di testa altissime dei cantanti gospel strappate alla chiesa e riadattate a un contesto soul e pop. Ma se Prince cercava la performance vocale perfetta (riascoltiamoci Adore o If I was your Girlfriend dall’album Sign O’ The Times del 1987) e usava la tecnologia dello studio per lucidare le sue linee vocali come se fossero argenti preziosi, Dijon ama sporcare la sua voce già naturalmente ruvida. Baby è stato giustamente descritto come un album estremamente sperimentale e le sperimentazioni più ardite Dijon le fa quando lavora sulla voce. Nell’album appare frenetico, a volte non si capisce neppure come faccia a prendere fiato.
Se Prince otteneva lo stesso effetto tra l’estatico e il delirante, lo faceva moltiplicando le sue voci e trasformando se stesso in un intero coro (in Adore, appunto), Dijon invece la voce la manda in pezzi, la disintegra accelerandola e rallentandola, la rende uno strumento indisciplinato molto umano. Brady Brickner-Wood in un suo profilo di Dijon uscito sul New Yorker scrive: “La natura frenetica e indomabile di Baby cerca di comunicare la follia del vivere con sentimenti grandi e travolgenti – emozioni difficili da mettere a fuoco. Il significato si accompagna al turbamento, l’esuberanza si confonde con l’impazienza, il desiderio si mescola alla disperazione. Anche i momenti limpidi e silenziosi vengono turbati da pensieri intrusivi, una fitta d’ansia che compare quando meno te l’aspetti”. Dijon non è un soulman assertivo o predicatorio: è travolto dai suoi sentimenti e, come dice Brickner-Wood: “Non ha paura di urlare finché ha voce in corpo”.
È per questo che sia Baby sia Essex Honey, pur venendo da due artisti neri con storie e provenienze diverse (Devonté Hynes ha anche sette anni più di Dijon Duenas) ci offrono una chiave per comprendere non tanto una fantomatica nuova mascolinità, quanto la complessità dell’essere maschi e neri nell’occidente di oggi. Soprattutto in due modi diametralmente diversi ci comunicano un vitalistico e combattivo senso di gioia. “La gioia da sola non ci può garantire sicurezza”, scrive ancora Hanif Abdurraqib “Ma può servirci da benzina quando la fatica della resistenza diventa troppa”.