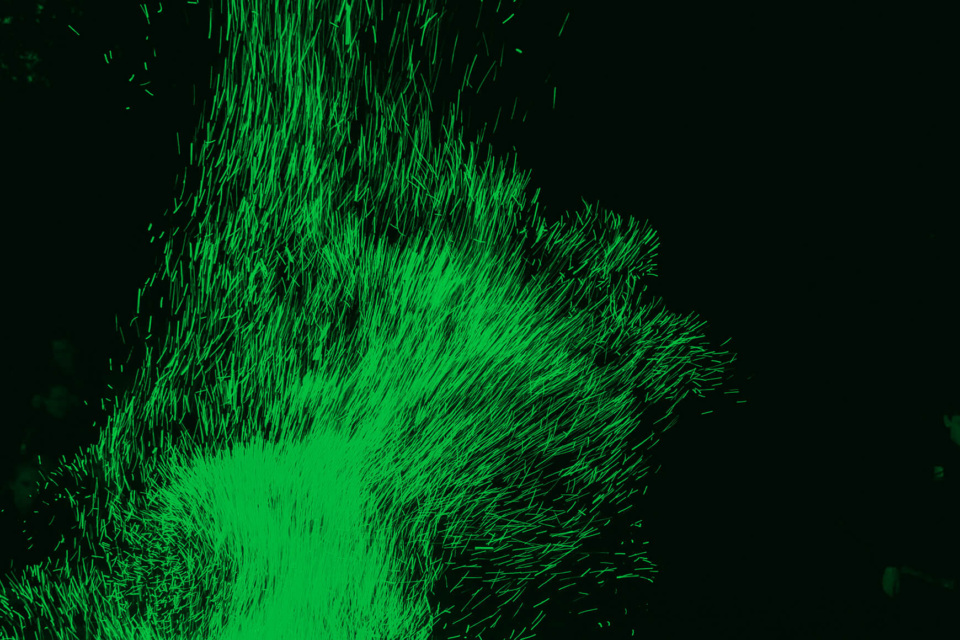Nell’epoca della sorveglianza e dell’iper-visibilità, tenere qualcosa per sé sembra diventato impossibile. Ma cosa succede se smettiamo di credere nella riservatezza? Ne abbiamo parlato con il sociologo Massimo Cerulo, autore del saggio "Segreto" (Il Mulino).
Ogni volta che ho promesso che avrei mantenuto un segreto mentivo. Non c’è quasi nulla di quello che mi sia stato rivelato negli anni – dall’infanzia alla vita adulta – che io non abbia in seguito riportato nel dettaglio a un’amica o a un amante, facendo precedere le mie rivelazioni dall’avvertimento solenne: “Non lo puoi raccontare a nessuno”. Mi sono chiesta spesso se questo aspetto costitutivo del mio carattere fosse dovuto soltanto a mancanza di buona volontà o se invece indicasse qualcosa di più pesante e profondo: il rifiuto di portare sulle mie sole spalle il segreto di qualcun altro, e il terrore del potenziale distruttivo che quel segreto, se scoperto, avrebbe sprigionato. Da adulta sono diventata più cauta con i segreti altrui, e con i miei. In senso più ampio, interrogarsi sui segreti significa domandarsi che cosa sia bene condividere, e cosa invece sia meglio tenere per sé – che si tratti di segreti nostri o di segreti che, invece, ci sono stati affidati.
Il sociologo Massimo Cerulo, professore ordinario all’Università Federico II di Napoli e chercheur associé al CERLIS (CNRS) dell’Université Paris-Cité, ha dedicato ai paradossi dei segreti il suo ultimo libro – intitolato, appunto, Segreto (Il Mulino 2025). Il saggio si inserisce nella linea della riflessione di George Simmel, sociologo tedesco secondo il quale i segreti rappresentavano un aspetto fondamentale tanto dell’identità personale quanto delle interazioni sociali, e raccoglie riflessioni che traggono ispirazioni sia dalla letteratura sia dall’esperienza personale sia dalle conversazioni svolte da Cerulo con i propri studenti. Rispetto a Simmel, il problema centrale con cui il saggio di Cerulo si trova a fare i conti è rappresentato dagli sviluppi contemporanei del problema della segretezza, in particolare quelli legati alla secolarizzazione e alla società digitale. Innanzitutto, si tratta di confrontarsi con la “cultura della sorveglianza”, definizione elaborata dal sociologo David Lyon, secondo il quale la sorveglianza degli individui, da parte delle istituzioni statali ma soprattutto delle aziende private, è penetrata grazie alla tecnologia in ogni aspetto delle nostre esistenze. In secondo luogo, ma non in misura minore, si tratta di fare i conti con quell’aspetto legato all’iper-condivisione di tutte parti più intime del sé, e di quella sfera della vita personale che nel Novecento veniva ancora considerata privata. In questo senso, la tesi principale di Cerulo è che la società contemporanea, seguendo una tendenza di matrice illuminista e democratizzante di richiesta totale di trasparenza, abbia dimenticato il senso più profondo e il ruolo dei segreti: abbiamo smesso non soltanto di saper tenere i segreti, ma forse anche di riconoscere la loro importanza.
La prima parte di Segreto è dedicata in gran parte alla confessione e alla sua scomparsa nelle nostre, ormai secolarizzate, società contemporanee. Come è stato rimpiazzato quel momento di chiarimento, richiesta di perdono e di lavoro etico sul sé? La cosa che più le si avvicina è la psicoterapia/psicoanalisi, ma allo stesso tempo il senso dell’operazione è inverso: non si chiede il perdono, ma solo di essere compresi.
Le racconto un aneddoto. Quando rientrai in università in Italia, a Torino, durante il mio orario di ricevimento iniziò a verificarsi una strana abitudine: dopo il primo mese di lezioni, iniziarono a presentarsi due-tre studenti “âgé” (over 40), che seguivano il mio corso di “Sociologia delle emozioni”. Si sedevano nel mio ufficio e iniziavano a raccontarmi di problemi della loro famiglia, con i figli o legati all’ambito sentimentale. Dopo venti-trenta minuti di monologo si alzavano, ringraziavano per l’ascolto e andavano via. Nessuna richiesta di chiarimento inerente ai temi del corso, soltanto la necessità di avere qualcuno, scientificamente riconosciuto, con cui confidarsi.
Il punto è che viviamo nella società dell’intervista, ma non dell’ascolto. Tutti vogliono parlare, esprimersi, postare, dichiarare la propria opinione. E, soprattutto, mettersi in mostra. Ovvero, apparire. Ma chi è capace di ascoltare? Pochissimi, in termini gratuiti e amicali. Ecco perché il ricorso alla seduta di analisi tocca oggi numeri importanti: si avverte la necessità del professionista che possa ascoltare quello che si ha da dire, quello che non si riesce a custodire dentro di sé, ma che, nello stesso tempo, non può essere confidato a un familiare o parente perché si correrebbe il rischio di incrinare l’equilibrio preesistente. La differenza con la confessione in termini cattolici sta nel significato che si dà a quello che si racconta: non si cerca l’assoluzione o il perdono, soltanto l’ascolto, la possibilità di tirare fuori un peso che attanaglia l’esistenza. Si tratta di quello che definisco “lavoro emotivo” sul proprio sé, ma che può essere svolto solo a patto che vi sia qualcuno pronto ad ascoltare i nostri racconti.
Storicamente le religioni si reggono, per molti versi, sui segreti: non solo il segreto del confessionale, penso anche ai misteri, a storie come quella del “segreto di Fatima”, o ai culti misterici… La secolarizzazione ha comportato in qualche misura una perdita rispetto al segreto?
Secolarizzazione vuol dire, in generale, che si crede molto meno al trascendente, a quello che va oltre ciò che si vede. E, dunque, anche ai segreti creati e narrati dalle religioni. Tuttavia, i segreti trovano nuovo spazio di diffusione in quella che è la religione contemporanea: l’utilizzo dei social media. Sul filo del digitale si creano, confidano, svelano e sviliscono, di continuo, diverse tipologie di segreti. Che sono “usa e getta”, legati alla società digitale che vive di notizie effimere, che durano pochi minuti. Poi devi scrollare, postare nuovamente, tornare a chattare. Ecco: i segreti religiosi erano eterni o immutabili, quasi non venivano scalfiti dal tempo. Oggi il tempo del digitale fagocita tutto ciò che dura più di qualche minuto. Georg Simmel e Walter Benjamin lo avevano previsto già nel Novecento: il presente viene spazzato via da un futuro impellente, che travolge le nostre attività quotidiane trasformandoci in esseri ansiogeni.
“Il punto è che viviamo nella società dell’intervista, ma non dell’ascolto. Tutti vogliono parlare, esprimersi, postare, dichiarare la propria opinione. E, soprattutto, mettersi in mostra. Ovvero, apparire. Ma chi è capace di ascoltare?”
Un altro aspetto che vorrei approfondire è quello produttivo del segreto, voglio dire l’aspetto che obbliga e che costruisce un legame. Nel suo saggio, come esempio, Lei cita il romanzo Confidenza di Domenico Starnone: nella storia i due amanti sono legati per sempre da un segreto che si sono confessati, quantomeno nell’obbligo reciproco di non rivelare quello dell’altro.
Nel romanzo di Starnone viene mostrato un esempio mirabile di quanto possa essere complicato custodire un segreto. Pietro, trentenne professore di lettere in un liceo romano, inizia una relazione con una sua ex studentessa, Teresa, dieci anni più giovane. Il rapporto dura circa tre anni e vive di una tale intensità che i due amanti arrivano all’ambizione di possedere l’intera identità dell’altra persona (e chi è stato innamorato sa bene quanto tale idea sia malsana). L’obiettivo cerca di essere raggiunto attraverso quello che definiscono il “gioco del segreto”. Una notte, al termine di una litigata per gelosia seguita da un amplesso, Teresa chiede a Pietro di sigillare una sorta di patto di sangue, un accordo che possa mantenerli per sempre legati, anche una volta che l’amore sarà finito: “Facciamo che io ti racconto un mio segreto così orribile che nemmeno tra me e me ho mai provato a raccontarmelo, e tu però me ne devi confidare uno equivalente, qualcosa che se si sapesse ti distruggerebbe per sempre”. Ecco: quando si confida un segreto, si è legati indissolubilmente al custode. A colei o colui che ha ascoltato la nostra confessione. Dall’altra persona si è sorvegliati per sempre e le si concede una parte della nostra libertà.
L’esempio tratto da Confidenza ci permette di riflettere su quanto un segreto possa sì costruire un legame, ma possa contemporaneamente anche lacerare l’individuo. Noi affidiamo una parte consistente della nostra esistenza al buon senso, all’intelligenza, o forse al silenzio di un’altra persona. Quello che ha importanza è la costruzione sociale della realtà che noi mettiamo in atto. Ci convinciamo che quella persona potrebbe distruggerci, se lo volesse, e iniziamo a vivere con una sottile cappa di angoscia che aleggia sul nostro futuro. Con una sorta di ricatto autoinflitto, anche se il custode non dovesse agire in tal senso.
Ho una domanda forse iperbolica: oggi, nei rapporti interpersonali, la verità e la trasparenza sono sopravvalutate? Alle volte, nelle relazioni di coppia o con gli amici ho l’impressione che si scelga di dire la verità più per liberarsi del peso di un segreto che per cura dell’altro. Tenere un segreto può essere invece un gesto di cura?
Mi trovo abbastanza d’accordo con la sua ipotesi. Intanto, la cura dell’altro nelle relazioni contemporanee è sempre più una merce rara. Negli anni della società ipercompetitiva, del fenomeno degli “hikikomori”, delle connessioni digitali che creano isolamento, mi sembra evidente il passaggio che sta caratterizzando la nostra quotidianità: dalla cura sui alla incuria sui, dall’essere una comunità (in linea puramente teorica) al trasformarsi in una sorta di monade, capitalisticamente concentrati nel pensare alla propria sorte, in un delirio di individualismo solipsistico che considera l’altro come un con-corrente e non come un simile, verso cui mostrare solidarietà e altruismo soprattutto se rischia di trovarsi in difficoltà. L’autocontrollo del proprio Sé si è allentato alquanto, si tende a scavalcare o sopravanzare l’altro, in una società occidentale in cui l’imbarbarimento del discorso pubblico e un surplus quotidiano di emozioni negative è ormai certificato da numerosi studi sociologici. Quello che mi pare evidente è uno sfilacciamento del legame sociale, travolto dalla disgregazione di quel sentire comune che sta alla base della comunità di individui alla quale tutti, volenti o nolenti, apparteniamo in quanto esseri umani e sociali.
Detto questo, la società è sempre ambivalente, ovvero si nutre di tendenze e controtendenze. Nei termini di cura del segreto, ciò si traduce in quei comportamenti che continuiamo a mettere in atto per tutelare l’altra persona, rispettarla, non farla soffrire. È il caso, classico, delle bugie bianche, sdoganate anche da Papa Francesco. Come risulta da una recente ricerca che racconto nel libro, molti studenti mi hanno confermato che preferiscono mantenere un segreto e mentire piuttosto che ferire un’altra persona cui tengono.
“L’esempio tratto da ‘Confidenza’ ci permette di riflettere su quanto un segreto possa sì costruire un legame, ma possa contemporaneamente anche lacerare l’individuo. Noi affidiamo una parte consistente della nostra esistenza al buon senso, all’intelligenza, o forse al silenzio di un’altra persona”.
C’è ovviamente una distanza immensa, su questo piano, tra il piano pubblico e quello privato: dalle istituzioni pretendiamo trasparenza e onestà, basta pensare ai leak degli ultimi 10 o 15 anni, citati nel suo capitolo conclusivo. Nel privato, invece, accettare che chi ci circonda e amiamo abbia dei segreti ci sembra inaccettabile – mentre mi piace molto quello che dice Édouard Glissant, al contrario, sull’avere un “droit à l’opacité”.
Con il richiamo al “diritto all’opacità”, siamo giunti alla funzione strutturante del segreto: la sua custodia e, soprattutto, la sua condivisione, forniscono agli esseri umani la possibilità di fare esperienza di vita, palestra di società, di agire all’interno di una interazione che inevitabilmente vivrà di parole e silenzi, frasi accennate o soltanto taciute, forme di empatia. Come l’onda del mare che lambisce e poi si ritira, chi custodisce un segreto si trova con i piedi sul bagnasciuga: mai completamente asciutti né del tutto bagnati, il custode è a metà tra il dire niente e il dire tutto, detentore di una conoscenza in attesa e vincolato al rapporto che lo lega alla persona che ha confessato il segreto. Un vincolo che potrebbe favorire sia una crescita della relazione, in termini di strutturazione dell’identità, sia una distruzione della propria autostima.
In tal senso, è il caso di ricordare come il diritto alla domanda e il diritto al segreto stiano entrambi alla base della relazione sociale e della vita in società democratiche. Io posso sempre chiedere, così come Tu puoi sempre non rispondere. È un rapporto basato sul rispetto delle altrui identità, opinioni, posizioni, scelte. Nonché dei corpi, che nella quotidianità vengono nascosti o svelati in base ai palcoscenici sociali su cui ci si trova a recitare e alle norme che regolano le rispettive performance. Chiedere o tacere, rispondere o svicolare, sono forme di interazione sociale che trasmettono precisi significati in riferimento al rapporto che si vuole costruire. Tuttavia, sembra che oggi molti abbiano dimenticato come il diritto alla domanda e il diritto al segreto facciano società: garantiscono un equilibrio della relazione che in tal modo si nutre di rispetto e dignità. Perché, se tutti aneliamo alla conoscenza dei segreti altrui, pochi tra noi sono capaci di custodirli.