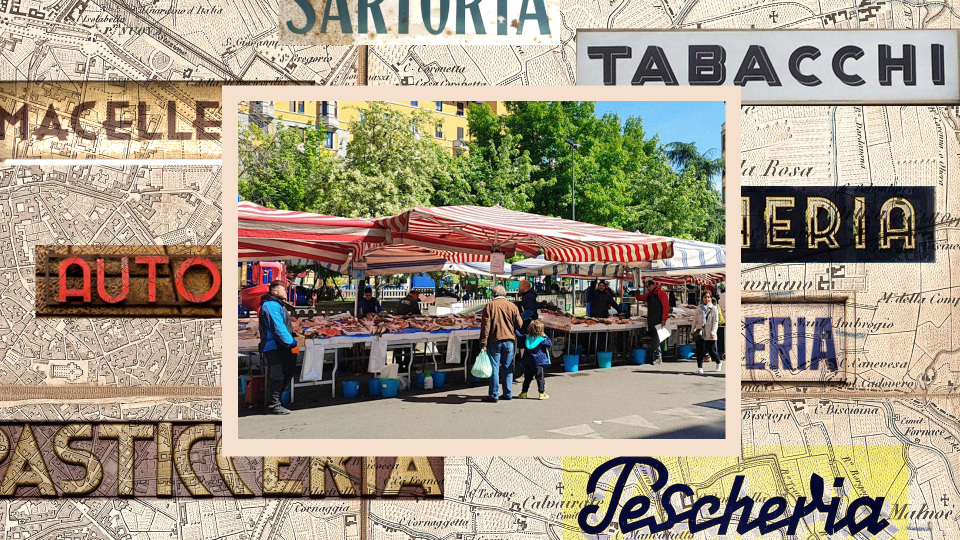E anche tutti quelli in cui hai abitato. Ecco perché è così difficile decidere dove vivere, o andarsene da una zona che ci piace: ogni volta che ci si trasferisce, si rischia mette in discussione la propria identità.
Di recente ho cambiato quartiere, da est a nord di Milano. Quello di prima si chiamava Acquabella, nome stupendo, mentre quello nuovo si chiama Gorla, e io non lo nomino mai: quando mi chiedono dove mi sono trasferito rispondo “sul naviglio della Martesana” (perché vicino casa c’è il naviglio omonimo, appunto). La cosa può destare ambiguità: di recente, un mio interlocutore ha capito che vivevo su una chiatta, e ha reagito con tanto entusiasmo che non me la sono sentita di deluderlo, di chiarire che sul naviglio significa vicino a un naviglio, così ho risposto educatamente a tutte le sue domande sulla fauna fluviale, nutrie, zanzare, cormorani. È che non ci riesco proprio a dire “mi sono trasferito a Gorla”, cioè da un quartiere a un altro. All’inizio pensavo fosse una questione di appeal fonetico – “Gorla” sembra il nome di un servo insolente della commedia dell’arte, o di un cattivo di Dragonball – ma credo che prenderla così larga, in realtà, sia stata una tattica del mio cervello per farmi acclimatare con il cambiamento. Come se fantasticare di abitare sull’acqua potesse ammorbidire la drasticità dello spostamento via terra. Invece, anche da questa chiatta immaginaria mi capita di pensare: che nostalgia. Quando succede, le nutrie fanno finta di non vedermi. Mi sa che le immalinconisco.
Ragazzo di Acquabella, uomo d’acqua dolce
Era prevedibile che trasferirsi mi avrebbe addolorato, ma non sapevo quanto. L’ho scoperto poche settimane fa, nel momento in cui il mio migliore amico, che per anni ha vissuto a Torino e ha sempre detto con un insopportabile paternalismo che noialtri sbagliavamo a vivere a Milano, che lui la detestava, che mai nella vita ci avrebbe trascorso più di weekend – “anzi perché non vi trasferite tutti a Torino?, anzi perché non torniamo tutti in Calabria?, il trend si è invertito, Milano è morta” – si è trasferito a Milano. E non in una Milano qualsiasi, ma nella “mia”, a trecento metri dal mio vecchio palazzo, pochi mesi dopo che me ne sono andato sul naviglio. Al di là del tempismo ridicolo – abitare finalmente vicini, ma in due linee temporali differenti –, l’emozione che è prevalsa sulle altre, in me, è stata la gelosia. Più forte di quanta ne abbia mai provata in amore. Così adesso tengo il muso al mio migliore amico. Non voglio andare a trovarlo, non voglio che mi chieda consigli, non voglio che mi racconti quanto si trova bene dove so già per esperienza che si troverà benissimo, non voglio immaginarlo mentre ripercorre le mie strade, entra nei miei negozi, familiarizza col mio meccanico, beneficia insomma di una vita che io ho avviato per lui, e che mi manca.
Ma perché mi manca, se dove sono adesso sto bene?
Mia moglie mi ha rimproverato. Ha detto che comportandomi così faccio una doppia brutta figura: “Non solo gli dai un’accoglienza pessima in città, ma sembri pure un rosicone”.
“Ma chi, io?”
Io, io.
L’ho invitata a specificare cosa volesse dire con “rosicone”, perché forse intendevamo due cose diverse, magari lei attribuiva al verbo “rosicare” sfumature semantiche più profonde, ma purtroppo no: intendeva proprio che sembravo invidioso. “E per cosa?” le ho chiesto. “Per un posto che evidentemente ti piaceva più di quello in cui stai adesso” mi ha risposto, un po’ delusa.
Non so come dimostrarle che non è così. Sul naviglio sto bene, sono felice, anzi, entusiasta. Siamo arrivati in questo quartiere proprio perché piaceva a me, a causa di un triangolo di ristoranti che adoro e che avrei voluto frequentare abitualmente. (Anticipo e comprendo le vostre perplessità: ma una coppia può comprare casa solo perché intorno ci sono tre buoni ristoranti? La risposta è: sì, se la metà di quella coppia sono io.) Ciò non confligge con la gelosia per il rapporto fra il mio amico e il mio vecchio quartiere, perché quando si tratta di luoghi non si è mai infedeli, secondo me, ma poliamorosi. Ci sono città, paesi, marciapiedi, perfino edifici che ci restituiscono un senso di appartenenza (reciproco) anche in assenza di legami formali, e queste città, questi paesi, questi marciapiedi si sovrappongono col tempo nella nostra identità, rendendo sempre più difficile rispondere alla domanda: “Di dove sei?”.
Ad esempio io non lo so, di dove sono. Calabrese di nascita, siciliano di origine e tradizione, milanese di elezione. Cosa conta di più? E da milanese elettivo, come può la mia nuova identità di uomo d’acqua dolce (della Martesana) cancellare per sempre quello che a Milano sono stato soprattutto e per anni, cioè il ragazzo di Acquabella? Se non so di dove sono non so chi sono?
In effetti sì, mi rode, perché poche volte mi sono sentito protagonista di qualcosa come del mio vecchio quartiere. Il mio personaggio di immigrato felice era in parte basato sull’aver scelto, per poi frequentare, quel bar, quel fornaio, quella libreria. Invece, se adesso chiudo gli occhi e ripenso alla mia vita di allora non vedo più me, ma il mio amico. Che la usurpa. Che, con le sue domande legittime ma insopportabili – “qual era il tuo barbiere di fiducia?:)” –, sta sporcando la mia nostalgia.
“Se non so di dove sono non so chi sono?”
Avremo sempre la Stadera
Ne ho parlato con la mia amica G., secondo la quale l’attaccamento ai luoghi in cui abbiamo vissuto dipende dalle storie di formazione a cui hanno fatto da scenario. “Il primo quartiere che ho davvero amato è anche il primo dove ho abitato da sola: Islington, a Londra. Inventarmi una routine lì è stata una parte fondamentale del processo di costruzione della mia identità e distacco dalla mia famiglia. Lì, avere dei posti miei voleva dire essere me e basta: non la ‘figlia di’, non la ‘fidanzata di’”.
G., per quanto ne so, è molto legata alle sue vite precedenti. Quando ci siamo conosciuti, tre o quattro anni fa, si era da poco trasferita da Milano nella provincia di Varese, e parlava apertamente delle emozioni contrastanti di cui si sentiva preda, quel misto di contentezza per i pro di una vita in paese – il verde, la quiete, i prezzi più bassi, una casa enorme, un giardino in cui il marito potesse grigliare la carne e il figlio correre, rotolare, invitare i compagni di scuola, sfidarli in gare clandestine fra Peg Perego – e la nostalgia per la Stadera, il suo quartiere a sud Milano.
“Mi batte il cuore ogni volta che sento nominare una via, un locale, un negozio che ha fatto parte della mia vita” mi ha detto G. “perché io appartenevo a quel posto, come in questo momento mi sembra di non appartenere a quello in cui mi trovo. Non ho mai lasciato la social street su Facebook del mio vecchio quartiere di Milano, ricevo ancora le email mensili con gli eventi del piccolo club vicino al mio appartamento a Londra. Quando hanno chiuso il mercato antiquario di Angel per trasformarlo in un centro commerciale, mi è sembrato di perdere un pezzo dei miei ricordi. È una sensazione molto diversa da quella che sento passando davanti alla mia scuola primaria, o al mio liceo. Non è nostalgia del tempo passato: è nostalgia dell’avere ancora una persona da costruire, dei pezzi di me che mi hanno offerto quei luoghi, lo stupore di scoprirsi”.
“Ci sono città, paesi, marciapiedi, perfino edifici che ci restituiscono un senso di appartenenza (reciproco) anche in assenza di legami formali, e queste città, questi paesi, questi marciapiedi si sovrappongono col tempo nella nostra identità, rendendo sempre più difficile rispondere alla domanda: ‘Di dove sei?’.”
Dal muto al sonoro
In quante case a cui non abbiamo più accesso, e su quanti marciapiedi che non calpestiamo più, sapremmo muoverci a occhi chiusi? E come possiamo non pensare che almeno in parte ci appartengano, che il semplice fatto di averli abitati o solo frequentati li renda per sempre un po’ nostri, o un po’ più nostri di chi è arrivato dopo?
Dopo avergli posto queste domande e più in generale l’intera questione, il mio psicologo mi ha detto una cosa che sapevo già, e cioè: “Lei la vive come se il suo amico si fosse fidanzato con una ex per cui prova ancora qualcosa”. Poi, per spiegarmi che ogni progresso genera un po’ di passatismo, si è impegnato a produrre analogie così ambiziose – “pensi alle carriere demolite per il passaggio dal muto al sonoro, dall’analogico al digitale…” – che mi sono distratto.
Certo, da che ho memoria cambiare casa o strada mi ha sempre turbato. Tanto che, a pensarci bene, ogni volta che mi sono dovuto trasferire, piuttosto che cercare un’altra casa nella stessa città ho cambiato direttamente città, anche se per brevi periodi. Milano è l’unica in cui abbia traslocato tre volte e senza fuggire momentaneamente (o durevolmente) da un’altra parte. Le motivazioni possono essere tante – economiche, storiche, sentimentali – ma credo di poterle riassumere dicendo che, se altrove avevo costruito la mia identità, a Milano ho cominciato a farla fruttare; a vivere, cioè, come l’uomo che ero diventato. Frequentando dei posti: bar, librerie, ristoranti, supermercati. Finché non ho cominciato a riconoscere delle facce e a farmi riconoscere. A dire con gli occhi: “io sono questo, e sono straniero, ma se state al gioco della reciproca familiarizzazione posso diventare di qui”.
È successo.
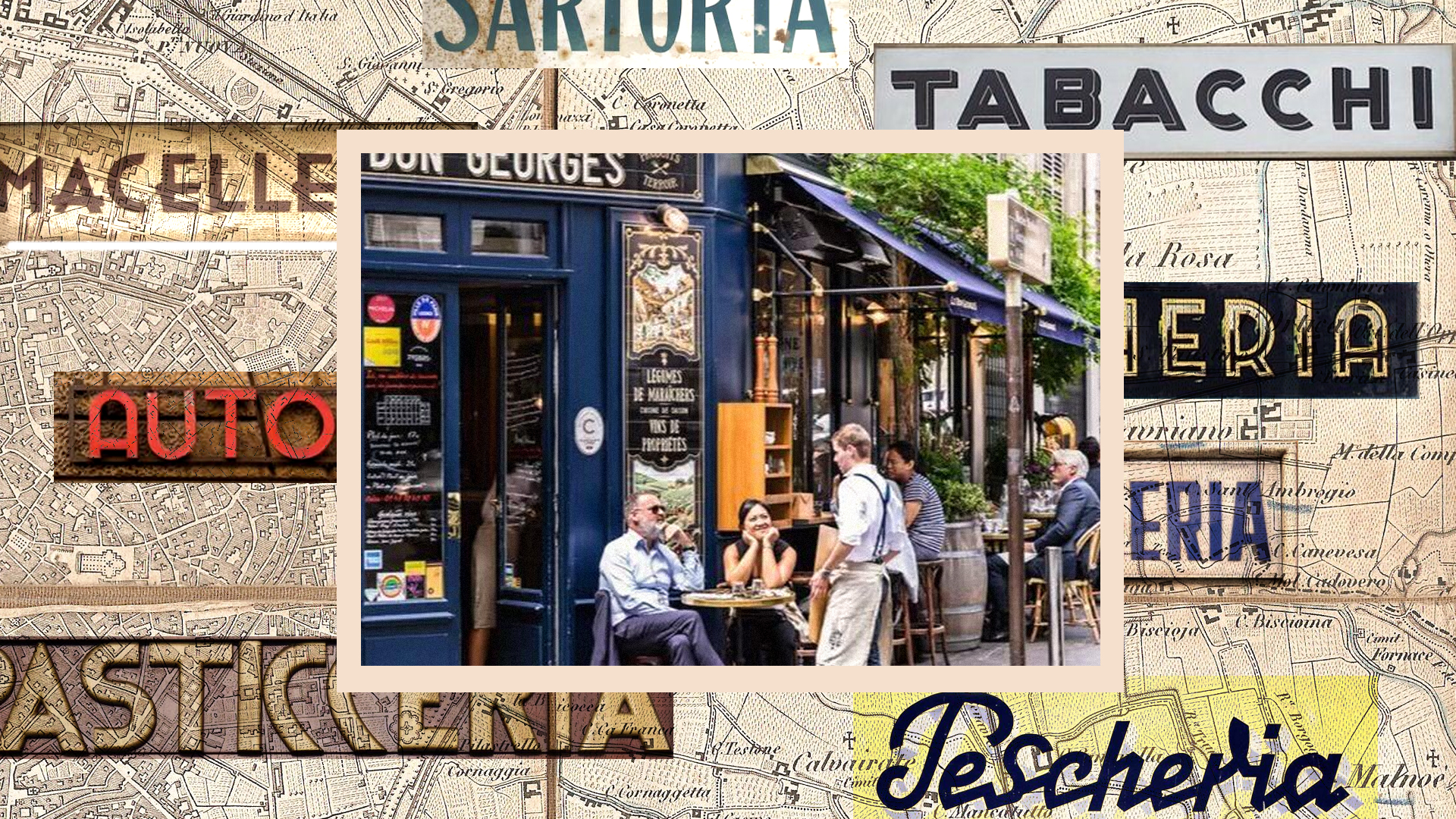
Il nome del cane
“La domenica, il ragazzo del bar sotto casa mi tiene da parte la veneziana per la colazione. E io se mi sento riconosciuta mi riconosco: prendere la veneziana la domenica, evidentemente, è una cosa da me, una cosa che faccio. Un quartiere serve anche a farti capire come sei fatta, cosa ti piace”. Me lo ha detto un’altra amica, A., che, “per testardaggine e fortuna” – e pur essendo una grande viaggiatrice – non si è mai mossa, abitativamente parlando, da Roma nord.
“Io ho con questa zona la mia personale storia d’amore infinita. Accetterei di cambiare città, continente, ma quartiere mai e poi mai. Questo qui lo amo, con tutte e per tutte le sue contraddizioni. E spesso lo odio. Ne sono gelosa. Insomma, mi comporto proprio come in una relazione: ogni tanto lo do per scontato, sono un po’ insofferente, ma proprio perché è ‘mio’ mi ritengo l’unica autorizzata a parlarne male. Se lo fa qualcun altro, divento la sua prima sostenitrice”.
Il compagno di A., D., si è invece trasferito a Roma nord da Roma sud, “quella più verace, come solo Acilia sa essere”. Quando le chiedo se a lui è pesato, ammette che all’inizio un po’ sì, “ma poi è arrivato il cane”.
Avere un cane e portarlo a spasso nel quartiere, mi dice A., ti regala un senso di appartenenza persino più forte. “Conosci ogni vicolo, scorciatoia, i locali con i biscottini alla cassa, sei parte di una comunità ancora più piccola e radicata. L’unico prezzo da pagare è che poi non ti conoscono col tuo nome ma con quello del cane”.
Place Identity
Il concetto di Place Identity è stato introdotto negli anni Settanta dallo psicologo ambientale Harold Proshansky, per definire “una sotto-struttura dell’identità personale costituita, in senso ampio, dalla cognizione riguardante il mondo fisico in cui l’individuo vive”. Per Proshansky, la Place Identity ha tre funzioni, la prima delle quali è il Riconoscimento, ovvero la capacità che ci permette di stabilire se un determinato luogo è sicuro, se fa per noi. Le altre sono il Significato (a che ci serve, quel luogo?, qual è il suo ruolo, il suo scopo, in relazione alle nostre necessità?) e l’Espressione (che è l’aspetto che ci spinge a personalizzare il più possibile un ambiente, se riteniamo che non ci rappresenti abbastanza).
Più di recente (nel 2014), in uno studio intitolato The Psicology of Place Attachment, Leila Scannell e Robert Gifford hanno parlato della Place Identity dicendo che “conferisce alla persona un senso di continuità, autostima, autoefficacia (la sensazione di essere in grado di realizzare le cose) e un senso di distinzione (rispetto a chi vive altrove). In questo modo, chi siamo può includere anche dove siamo. […] Gli studenti universitari si identificano con le loro scuole, e i residenti di contee, Stati, distretti, province e territori si identificano con queste giurisdizioni. A scale più piccole, molte persone si identificano con i propri quartieri, borghi, fattorie o anche case”. Spostarsi dal posto che sentiamo nostro, quindi, significa non soltanto perdere un orizzonte familiare, quanto una parte dell’idea che abbiamo di noi stessi e della nostra immagine, e doversi rimettere al lavoro per ricostruirla; per re-identificarsi, riscoprirsi e ripresentarsi al mondo.
“In quante case a cui non abbiamo più accesso, e su quanti marciapiedi che non calpestiamo più, sapremmo muoverci a occhi chiusi? E come possiamo non pensare che almeno in parte ci appartengano, che il semplice fatto di averli abitati o solo frequentati li renda per sempre un po’ nostri, o un po’ più nostri di chi è arrivato dopo?”
Forse è per questo che non conosco persone che dopo una certa età abbiano cambiato volentieri quartiere, se non quando il loro scopo era cambiare direttamente vita. Ed è ancora per questioni identitarie se molti miei coetanei hanno sempre più preoccupazioni legate al dove vivere, che si parli di città, strade o case, e che siano queste elettive, native o imposte dal lavoro: finché non sappiamo chi siamo, cambiare ci va bene, perché la ricerca di un posto che sia nostro è speculare alla ricerca di risposte su di noi; ma quando riteniamo di averle trovate, queste risposte, allora pretendiamo di fermarci, nella speranza, dopo esserci finalmente capiti, di poterci conoscere a memoria, come le strade che percorriamo ogni giorno. (Il fatto che non sempre sia possibile è un problema che l’umanità si porterà appresso fino all’estinzione: quando vivremo su Marte, l’hobby più diffuso sarà guardare video della Terra che esplode, rimpiangendola a ogni sbuffo di fumo.)
La teoria degli ex amori
Tragicamente, il mio amico ci ha poi invitati a cena per vedere la casa nuova. Ho accampato scuse, ma alla fine siamo dovuti andare. Una volta arrivati nel quartiere mia moglie era contenta, io molto innervosito, e più vedevo belle novità – per esempio, c’è una nuova libreria – più il mio nervosismo peggiorava. Tanto che, quando siamo arrivati dal mio amico e dalla sua compagna, ho dato loro giusto il tempo di farci fare un giro della casa e poi ho vuotato il sacco: “Sentite, è tutto molto bello, ma ve lo devo dire: a me venire qua dà fastidio”.
“Spostarsi dal posto che sentiamo nostro, quindi, significa non soltanto perdere un orizzonte familiare, quanto una parte dell’idea che abbiamo di noi stessi e della nostra immagine, e doversi rimettere al lavoro per ricostruirla.”
Loro si sono rabbuiati, convinti di aver fatto qualcosa di male; lei ha persino annusato l’aria per verificare che non ci fosse cattivo odore. Ma prima che potessi riassumere tutta la storia – la chiatta, le nutrie, l’amica G. e l’amica A., la Place Identity come sottostruttura dell’identità personale eccetera – mia moglie è corsa ai ripari spiegando che avevo nostalgia del quartiere, e avrei preferito tenermene alla larga. Nessuno dei presenti, lei compresa, capiva il ragionamento: non avrebbe dovuto farmi piacere, piuttosto, tornare in un luogo in cui ero stato così bene, e avere di nuovo accesso a una parte di Milano che, in questo modo, tramite i miei amici, sarebbe stata ancora un po’ mia? (“No”.) Ne è seguita una discussione lunghissima, alla fine della quale qualcuno, non mi ricordo chi, forse il fantasma di Proshansky, ha detto che è molto bello avere degli ex quartieri, così come è bello avere ex amori, perché servono a ricordare parti di te che, progredendo, smetti di vedere; la loro influenza su di noi ha valore nel presente, finché li vivi e li abiti, così come ha valore nel futuro, proprio per far sì che un’identità non cancelli l’altra, e che il ragazzo di Acquabella non venga mai veramente rimpiazzato dal ragazzo della Martesana, e così via. Non ho trovato nulla da obiettare.
Dopo cena, mi sono forzato a fare una lista di riferimenti utili nel vicinato: il mio ex barbiere, le mie pizzerie preferite, un’ottima rosticceria, il meccanico più gentile… E sono stato meglio. Questo – ho pensato in seguito, in strada, osservando le saracinesche abbassate dei negozi che amavo, e che stavo “cedendo” ai miei amici – è l’unico modo perché l’esperienza di quel quartiere dia ancora frutti. Evidentemente, l’ho vissuto, amato e imparato a memoria perché, oltre me, anche qualcuno che amo fosse un po’ meno sperduto.
Pleasantville
(C’era questo film degli anni ’90, Pleasantville, molto carino, ve lo consiglio, in cui oltre i confini della città eponima non c’era niente. È un topos ricorrente, accade anche in altri film, in alcuni libri: la città-isola, la città assoluta. Per me, il mio vecchio quartiere è stato a lungo così. Una barriera fra quello che ero sicuro fosse la mia vita, la mia storia, e l’avventura, il dubbio, le strade non prese. Non ci si poteva perdere, a Pleasantville. Non si poteva dubitare di sé. Ma c’era una contropartita: tutti vivevano in bianco e nero. Perché solo oltre il confine, solo accettando lo smarrimento, iniziava il technicolor.
Devo consigliarlo alle nutrie.)