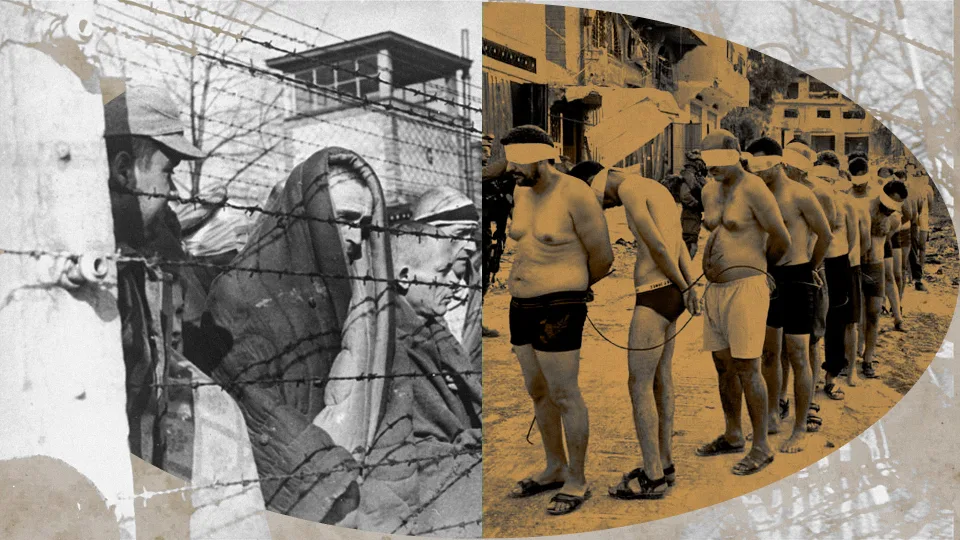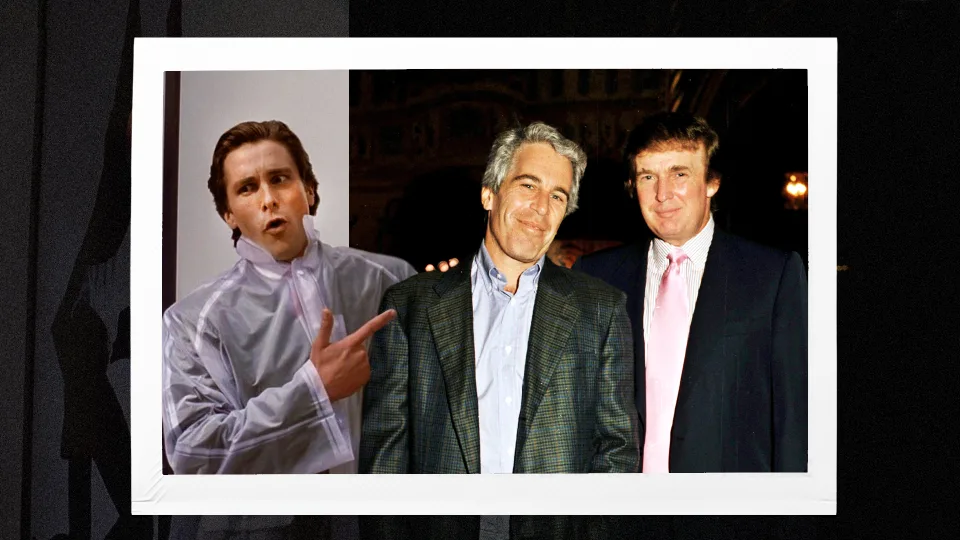Prolifico e veloce nello scrivere, Simenon è stato molto più di un grande giallista: cantore della provincia, ha raccontato le emozioni umane con l’acume di un moralista del Seicento e con la profondità di uno psicologo.
È stupefacente e pressoché unico il caso di uno “scrittore di genere” che esca prepotentemente dal proprio genere. L’hanno notato ammirati molti critici: i libri di Simenon sono delle autentiche tragedie moderne, borghesi, sì, ma congegnate secondo regole classiche. Quanto alla sua prolificità (più di 400 titoli), ha qualcosa di addirittura leggendario, tanto più in quanto legata a una inverosimile velocità di scrittura.
Stiamo parlando ovviamente dello scrittore belga di lingua francese Georges Simenon (1903-1989), il più profondo erede di quel romanzo poliziesco nato nella seconda metà dell’Ottocento e sviluppatosi fino ai giorni nostri. Amante degli pseudonimi (una ventina solo agli esordi), l’autore inaugura la sua produzione più nota nel 1931, con l’invenzione del commissario Maigret. Prosegue poi la serie componendo contemporaneamente i cosiddetti romans durs, ossia senza la presenza del suo celebre eroe: saranno questi ultimi che considererà la sua vera eredità di scrittore.
In Simenon, come ha spiegato Anne-Marie Jaton, nel corso della vita più banale irrompe un elemento di tensione che, in un drammatico crescendo, sfocerà in una crisi, raramente catartica e più spesso semplicemente catastrofica. Il non senso e l’assurdo vengono rappresentati nella loro tragica quotidianità. Il rapporto fra gli esseri e in particolare fra uomo e donna rivela improvvisamente il suo insondabile mistero: un mondo sicuro crolla per un passo falso, un bicchiere in più, un uomo di troppo nel letto di una donna senza speranza, o semplicemente per una subitanea quanto inspiegabile presa di coscienza del vuoto sul quale è costruita un’esistenza.
La psicologia, tanto deprecata da molti teorici del Novecento, nell’opera di Simenon si rivela di estrema efficacia. Non per niente in una recente intervista, il regista francese François Ozon – che ha molto praticato il genere del thriller psicologico – ha dichiarato: “Simenon era molto bravo a creare atmosfere, e unico nel descrivere la vita delle cittadine di provincia, dove hai la sensazione che tutto sia perfetto, ma dietro le finestre chiuse succedono cose strane, a volte terribili. Non gli interessa il plot poliziesco […], gli interessano le relazioni tra persone, la psicologia, la complessità e il buio che c’è nell’animo umano.”.
Sempre secondo Jaton, Simenon ricorderebbe Balzac per la pratica della registrazione oggettiva dei fatti, per la varietà dei milieux, dei mestieri e delle professioni evocati, oltre che per la vastità della produzione. Ma lo stile risulta sempre essenziale e asciutto, caratteristica che rende i suoi intrecci drammatici ancora più efficaci. Ambientati prevalentemente in Francia tra gli anni Trenta e Cinquanta, oppure nelle Fiandre, alcuni anche in America o in Turchia, i racconti non alludono mai alla situazione sociopolitica dell’epoca, e tale mancanza di agganci con la storia ha non poco contribuito alla sottovalutazione dell’opera di Simenon, almeno in un momento in cui la necessità dell’impegno politico era avvertita come particolarmente urgente.
Credo sia bene passare a una precisazione. La fama di Simenon non fu solo di pubblico, per via del commissario Maigret, ma anche, cosa assai meno nota, di critica. I suoi estimatori furono molti e illustrissimi, come dimostra questa piccola rassegna. Troviamo innanzitutto uno tra i massimi pensatori del Novecento, Walter Benjamin: “Leggo ogni nuovo romanzo di Simenon”. Poco più in là, abbiamo il premio Nobel André Gide: “Considero Simenon un grande romanziere, forse il più grande e il più autentico che la letteratura francese abbia oggi”. A dir poco sorprendente, poi, il giudizio del severissimo Cèline: “Ci sono scrittori che ammiro moltissimo: il Simenon dei Pitard, ad esempio, bisognerebbe parlarne tutti i giorni”. E per restare in Francia, un altro Premio Nobel, Francois Mauriac: “La sua arte è di una bellezza disarmante”.
Ma gli apprezzamenti non si fermano qui. Spostandosi negli Stati Uniti, ci imbattiamo ad esempio in Ernest Hemingway: “Se siete bloccati dalla pioggia mentre siete accampati nel cuore dell’Africa, non c’è niente di meglio che Simenon”. Viene invece dal cinema, il giudizio del venerato, sulfureo regista Jean-Luc Godard: “In lui si realizza la felice unione tra Dostoevskij e Balzac”. Il tutto, senza dimenticare un altro americano, Henry Miller, e tre italiani quali Alberto Savinio, Leonardo Sciascia e Alberto Arbasino. Rispetto a questa autentica pioggia di elogi, mi viene in mente un solo detrattore, ancorché di gran pregio: Jean Paul Sartre.
Il romanziere, si è detto, era belga come l’artista René Magritte, che pure non incontrò mai, sebbene qualche critico si sia interrogato sulla singolare vicinanza, a un passo dall’anagramma, tra Magritte e Maigret: da un lato il pittore di una pipa che non è un pipa, dall’altro il commissario che la fuma continuamente. Quanto alla portata della produzione di Simenon, che prima di esordire fece ricorso a una ventina di pseudonimi, stiamo parlando di circa quattrocento romanzi redatti nel corso di circa quarant’anni, oltre a migliaia di racconti e articoli. Si è favoleggiato di capitoli scritti in poco più di tre ore, e di romanzi ultimati di una decina giorni. A questo proposito, si racconta di una telefonata di Hitchcock al romanziere: “Monsieur Simenon è impegnato nella stesura di un romanzo”, dice la segretaria. E Hitchcock: “Okay, attendo in linea”.
E così arriviamo alla leggenda di Georges Simenon nella “gabbia di vetro”. Secondo alcune fonti (in seguito smentite), lo scrittore avrebbe accettato la scommessa propostagli per 50.000 franchi da Eugene Merle, spregiudicato editore di successo nella Parigi degli anni ’20: scrivere un libro intero in mezzo alla strada, sotto gli occhi di tutti, rinchiuso in una specie di campana di vetro. Anticipando i protagonisti dei nuovi format televisivi, decisi a vivere sotto il perenne e invasivo sguardo delle telecamere, Simenon avrebbe insomma accettato di esporre la sua attività creativa alla curiosità dei passanti, in un denudamento allo stesso tempo provocatorio e sacrificale. Altri hanno suggerito invece una versione secondo cui l’autore, sulle prime entusiasta, si sarebbe pian piano convinto che il progetto era soltanto una esibizione da circo, senza alcun vero interesse letterario. In effetti, sebbene quasi certamente falsa, la notizia di una simile performance resta oltremodo significativa, e fa comprendere quanto profondo fosse il senso di sfida insito nell’opera di questo narratore prodigioso. Il termine non sembra davvero eccessivo, pensando alla sua capacità di creare intrecci e atmosfere, climi e personaggi, a un ritmo addirittura inconcepibile.
“L’hanno notato ammirati molti critici: i libri di Simenon sono delle autentiche tragedie moderne, borghesi, sì, ma congegnate secondo regole classiche”.
Affascinante anche il suo rapporto con Federico Fellini, come si vede da una sua lettera del 9 novembre 1976: “Fratello, sono due gli uomini che chiamo in questo modo, e l’altro è Jean Renoir. In due diverse forme d’arte noi perseguiamo lo stesso fine: una più profonda conoscenza dell’uomo, per non dire dell’umanità. Ed entrambi lo facciamo in un modo che si potrebbe definire anti-intellettuale. Siamo come spugne, assorbiamo la vita senza saperlo e la restituiamo poi trasformata, ignari del processo alchemico che si è svolto dentro di noi”.
È molto importante questa relazione tra la prolificità di Simenon, e la sua rivendicazione di immediatezza; sembrerebbe alludere a una spontaneità priva di rigorosa coscienza critica, o comunque a un atteggiamento anti-intellettualistico. Simenon e Fellini si sentono infatti come minatori alle prese con un reame sotterraneo, ignoto, misterioso, che esplorano senza disporre di alcuna mappa, ma solo andando a tentoni, brancolando, seguendo la propria bussola interiore.
Il 15 luglio 1985, sempre rivolto al regista italiano, Simenon aggiunge: “A chi mi chiedesse che cos’è un creatore (ecco la parola giusta!) risponderei senza esitazione. ‘Guardate Fellini’. Perché sei tu il prototipo dei creatori. Tu non hai mai imitato nessuno. Non ha mai seguito le mode. Non hai mai adattato l’opera di uno scrittore, di un poeta o di uno sceneggiatore specializzato. Né tanto meno hai seguito i consigli “imperiosi” dei produttori o tenuto conto dei gusti mutevoli del pubblico. Tutti i tuoi film sono diversi, perché riflettono le tue preoccupazioni, le tue angosce, se non addirittura le tue ossessioni del momento”.
A proposito di incontri, resta incredibile la mancata visita dello scrittore belga a Carl Gustav Jung, che lo aveva invitato nella sua casa in Svizzera sin dal 1977. È stato detto che Simenon volle tenersi a distanza da un “vicino” che pure leggeva e ammirava (abitavano entrambi in Svizzera). Se lo scrittore espresse più volte il desiderio di visitarlo, quest’ultimo lasciò molti dei suoi romanzi fittamente annotati. In ogni occasione era sorto un impedimento: da qui l’ipotesi per cui ci fossero motivi di vario tipo, consci o inconsci, per cui il narratore desiderasse e al tempo stesso temesse l’appuntamento. Infine, nel giugno 1961, Jung morì. Maurizio Testa, ideatore del blog Simenon-Simenon, ha suggerito di mettere in relazione questo strano caso di procrastinazione con alcune delle risposte che Simenon dette nell’intervista del 1968 ai cinque medici e psicologi di “Médicine et Hygiene”. Una pista ermeneutica di estremo interesse, a cavallo tra letteratura e psicanalisi.
Ma terminiamo con l’annuncio di una mostra tuttora in corso presso la Galleria Modernissimo di Bologna, a cura di Gian Luca Farinelli e John Simenon, con scenografie di Giancarlo Basili: Georges Simenon. Otto viaggi di un romanziere (10 aprile 2025 – 8 febbraio 2026). Il visitatore è invitato a seguire i suoi stessi viaggi, le sue carte, i film tratti dalle sue opere, le fotografie che realizzò durante i suoi reportage in Francia, in Europa, in Africa, in tutto il mondo. A riprova di come il massimo cantore della provincia francese partisse da un orizzonte sterminato, per poi restringere il campo dei suoi studi, proprio come un moralista francese del Seicento, ai minimi, delicatissimi meccanismi delle passioni umane.