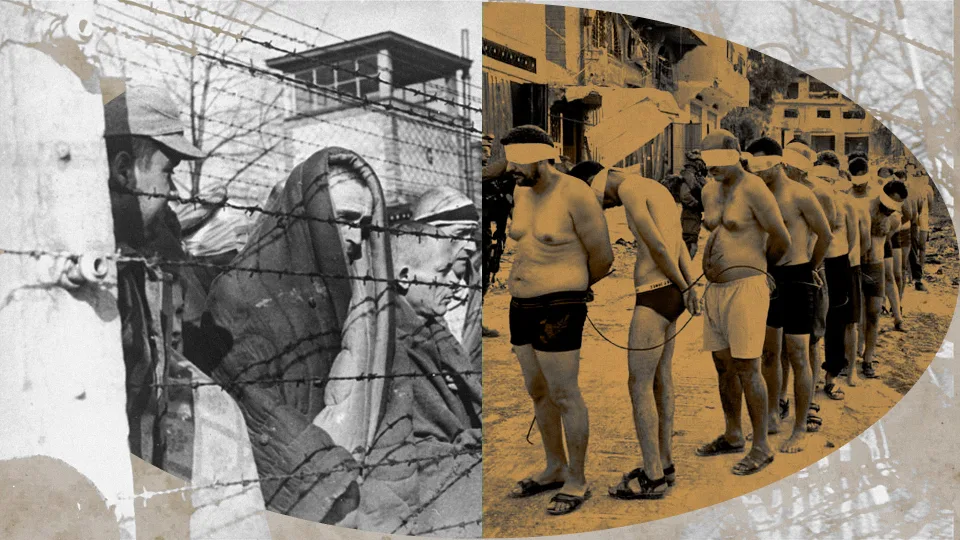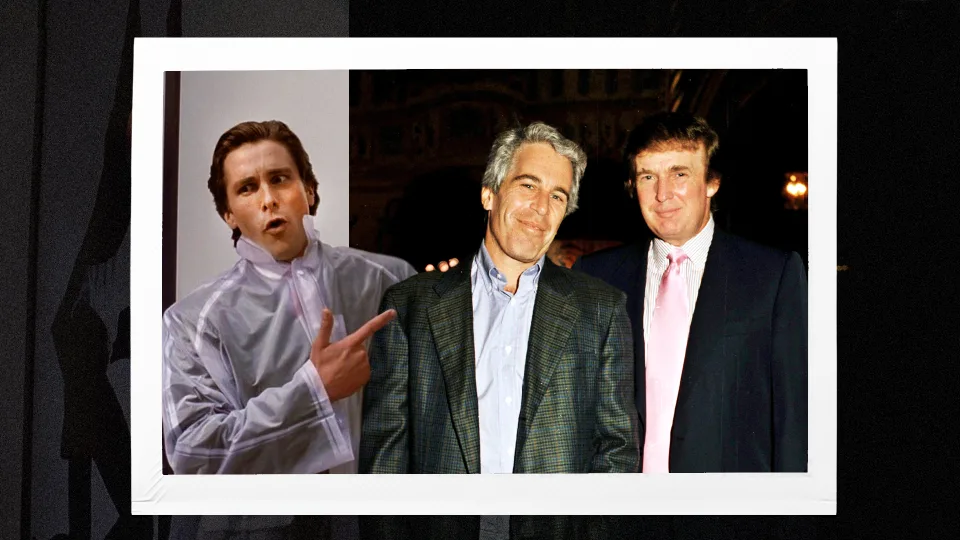Il critico musicale inglese è stato uno degli intellettuali più lucidi nel capire le direzioni in cui andava la cultura del suo tempo, tra cui il rap. Ma quanto di quelle analisi resta valido per capire la musica d’oggi?
Un’inquadratura aerea dello stadio mostra il Caesars Superdome di New Orleans, illuminato a festa per il cinquantanovesimo Super Bowl. Una voce femminile fuori campo annuncia l’inizio dell’attesissimo halftime show offerto dalla National Football League, mentre sul tetto è proiettato un gigantesco logo Apple. La musica si fa enfatica, il punto di vista dello spettatore sembra precipitare all’interno della mela morsicata e attraversarla come in un tunnel psichedelico. D’improvviso ci si ritrova dentro lo stadio, immersi nell’oscurità. Al centro del campo è stata allestita una struttura colossale a forma di joystick da videogioco. A introdurre lo spettacolo compare Samuel L. Jackson travestito da zio Sam che proclama l’inizio del “great American game”. È il preludio all’ingresso di Kendrick Lamar. La telecamera stringe su una Buick GNX, ferma al centro del campo. Sul cofano, inginocchiato, appare lui, uno dei rapper più influenti del XXI secolo, il primo a essere protagonista assoluto dell’evento televisivo più visto dagli americani (nel 2022 era toccato infatti a una formazione corale: Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J Blige, 50 Cent, Eminem e Kendrick Lamar). Per quindici minuti Lamar rappa senza fare sconti al pubblico, dando vita ad una sorta di meta-performance, in cui la critica all’America bianca che attraversa tutta la sua opera, si trasforma in un atto “televised”, come dice lui stesso, citando e insieme smentendo il celeberrimo brano “The Revolution Will Not Be Televised” di Gil Scott-Heron.
Difficile immaginare cosa avrebbe pensato Mark Fisher dello show di Kendrick Lamar al Super Bowl e, più in generale, della produzione del rapper mainstream più socialmente impegnato della sua generazione. Fisher, scomparso nel 2017, ha fatto in tempo a vederne l’ascesa ma non ne ha mai scritto. Eppure, uno spettacolo così intriso di contraddizioni avrebbe sicuramente stimolato la sua capacità di intrecciare fenomeni culturali apparentemente distanti dentro una visione del mondo lucida e radicale. Per Fisher la musica non era mai soltanto estetica: come pensatore marxista era infatti incline a leggerla come un sintomo politico, sociale, affettivo. Nelle sue analisi, il rap occupava un posto particolare, osservato con rigore e senza indulgenze. A differenza di altri critici, anche radicali, Fisher non si limitava a rilevarne le ambivalenze prodotte dalla sua commercializzazione; ne osservava piuttosto le incongruenze profonde, mettendo l’accento sulla sua natura intrinsecamente postmoderna e, per certi versi, neo-liberista.
Una parte significativa della produzione di Mark Fisher si è concentrata sull’analisi delle conseguenze sociali, culturali e psicologiche prodotte dall’accettazione passiva dell’esistente che domina la nostra contemporaneità. Nel suo saggio più noto, Realismo Capitalista (2009), l’autore mostra come il neoliberismo abbia colonizzato e incorporato l’intero orizzonte del pensabile, imponendo l’idea che non esistano alternative possibili. Fisher definisce il realismo capitalista come “un’atmosfera che pervade e condiziona non solo la produzione culturale ma anche il modo in cui vengono regolati il lavoro e l’educazione, e che agisce come una specie di barriera invisibile che limita tanto il pensiero quanto l’azione”. Secondo il critico teorico britannico, la vittoria di questo paradigma risale agli anni Ottanta, con l’affermazione a livello globale delle politiche economiche e culturali neoliberiste. È proprio in questa fase che il rap si sviluppa e inizia a entrare nell’industria discografica: non a caso il suo primo grande successo commerciale, Rapper’s Delight, esce nel 1979, lo stesso anno in cui Margaret Thatcher diventa primo ministro del Regno Unito.
In Realismo Capitalista, Mark Fisher dedica diverse pagine all’evoluzione dei generi musicali tra gli anni Ottanta e Novanta, mettendo in relazione il successo del rap al parallelo declino del grunge. A suo avviso, la morte di Kurt Cobain, leader dei Nirvana, “ribadì la sconfitta e l’incorporazione delle ambizioni utopico-prometeiche del rock”. La cultura capitalista, scrive Fisher, tende infatti a incorporare preventivamente ogni gesto sovversivo, neutralizzandolo dall’interno. In questo quadro, le aree culturali “alternative” o “indipendenti” non fanno che riproporre in forma ciclica e sterile vecchi atti di ribellione, come se avvenissero per la prima volta. La morte di Cobain nel 1994 segnava, per Fisher, il punto di massima impasse di questa dinamica: il cantante era consapevole di essere parte dello stesso spettacolo contro cui si ribellava, “che su MTV niente funziona meglio che la protesta contro MTV”. Con la sua scomparsa, il rock si trovava già in fase discendente, lasciando spazio all’ascesa dell’hip hop, una musica che, secondo Fisher, incorporava in maniera esplicita il paradigma del realismo capitalista.
“Una parte significativa della produzione di Mark Fisher si è concentrata sull’analisi delle conseguenze sociali, culturali e psicologiche prodotte dall’accettazione passiva dell’esistente che domina la nostra contemporaneità”.
Le ambizioni sovversive del rock sarebbero state dunque soppiantate dal discorso “realista” dell’hip hop. Analizzando l’insistenza del rap sul concetto di realtà (“keep it real”, “realness”, “be real”), Fisher cita – sempre in Realismo Capitalista – le riflessioni del giornalista Simon Reynolds. Secondo Reynolds, il rap è certamente un’arte che riflette con precisione la realtà del tardo capitalismo — fatta di instabilità economica, razzismo istituzionalizzato e crescente sorveglianza poliziesca sui giovani — ma questo attaccamento al “reale” sancisce al tempo stesso la morte del “sociale”. Per Fisher, dunque, ogni speranza ingenua che la cultura giovanile potesse trasformare il mondo è stata sostituita di fatto l’accettazione di una versione brutalmente riduttiva della realtà. L’uso stesso del termine “real” nell’hip hop non sarebbe altro che il segno di questa resa: la conferma ideologica di aver tolto ogni illusione sentimentale al mondo per mostrarlo nella sua essenza: quella di una guerra permanente tutti contro tutti, di un sistema fondato sullo sfruttamento e sulla criminalità generalizzata, senza alcuna possibilità di cambiamento.
In un articolo del 2009 per «New Statesman», Fisher prova a tracciare un quadro dell’evoluzione dell’hip hop e di come questo sia arrivato a incarnare il paradigma del realismo capitalista. A suo avviso, il rap aveva innanzitutto disciplinato la scioltezza del funk e le sue astrazioni, come se sotto la pressione del nuovo regime economico — Ronald Reagan salì al potere nel 1981 — il corpo fluido del funk si fosse irrigidito.
Al posto del delirio psichedelico di quest’ultimo, lo sguardo del rap si fissò sulla strada, fino a trasformare l’aderenza alla realtà in un codice esistenziale. I gruppi militanti come i Public Enemy rappresentarono per Fisher un fuoco di paglia. Lungi dall’aprire una nuova stagione di hip hop politicizzato, la loro esperienza segnò piuttosto la fine di una lunga sequenza di musica nera popolare e politica. Certo, l’hip hop impegnato socialmente sarebbe rimasto, ma non avrebbe più raggiunto quel livello di popolarità. Il successo di artisti come Schoolly D, considerato uno dei padri del gangsta rap, avrebbe piuttosto indicato la direzione futura.
In questa prospettiva, Fisher si è soffermato sul gangsta rap, il sottogenere più controverso e insieme di maggior successo nella storia dell’hip hop. Privo di qualsivoglia ambizione trasformativa, il gangsta rap si caratterizza per un racconto in prima persona della vita nel “ghetto”, unito all’aspirazione individuale di arricchirsi e uscirne il più rapidamente possibile. Per Fisher, questa rappresentazione “spogliata” della società costituisce uno dei tratti distintivi del realismo capitalista: un mondo in cui la politica è assente e resta solo l’economia, ridotta a pura lotta per la sopravvivenza. Le affinità tra rap e cinema gangster — da Scarface a Il Padrino, da Quei bravi ragazzi a Pulp Fiction — non sono, nella sua lettura, meri richiami estetici, ma la manifestazione di una visione del mondo che rivendica la fine delle illusioni, proponendosi di mostrare le cose come stanno, senza mediazioni. In entrambi i casi infatti proprio l’esibizione che entrambi hanno fornito di una realtà “senza compromessi” ha fatto sì che venissero cooptati dall’economia tardo capitalista, dove lo sfoggio di autenticità si è dimostrato un valore particolarmente redditizio. Dunque un fenomeno come il gangsta rap, secondo Fisher, “non si limita a riflettere le condizioni sociali preesistenti (come molti dei suoi sostenitori pretendono), né di quelle condizioni è nientemeno che la causa (come invece replicano i suoi critici): piuttosto, il circuito attraverso il quale hip hop e società tardo capitalista si alimentano a vicenda è uno dei modi in cui il realismo capitalista si trasforma in una specie di mito antimitico.”
Fisher si è però interessato anche ad altre traiettorie dell’hip hop più recente. Ha osservato con lucidità come il culto del “reale” abbia trovato continuità in una nuova forma di malinconia, legata all’edonismo vuoto del capitalismo digitale. In un articolo pubblicato nel 2013 sulla testata «Electronic Beats», lo studioso riflette su figure come Drake e Kanye West, analizzando la relazione tra rap, depressione e crisi dei modelli maschili. Racconta di come una tristezza segreta si nasconda dietro il sorriso forzato del XXI secolo, una malinconia che affiora dentro l’edonismo stesso. Drake e Kanye, sottolinea l’autore, sono entrambi ossessionati dall’esplorazione del vuoto miserabile al cuore dell’ultra-ricchezza. Questo tipo di mania è d’altronde la stessa che muove rapper nostrani come Guè e Sfera Ebbasta, a dimostrazione di quanto la commercializzazione del rap abbia prodotto tendenze simili sparse su tutto il globo. Non più mossi dalla spinta al consumo vistoso tipica dell’hip hop degli anni Novanta, i rapper contemporanei si abbandonerebbero a un ciclo dissoluto di piaceri immediatamente accessibili, da cui emergono frustrazione, rabbia e disgusto di sé. Una malinconia che, secondo l’autore, troverebbe la sua rappresentazione più compiuta nella sofferenza digitalmente manipolata di 808s & Heartbreak di Kanye West. In questo disco, il rapper e produttore riesce a dare voce, attraverso la tecnologia, a un dolore profondamente contemporaneo: quello generato dalle promesse di benessere non mantenute dal tardo capitalismo, in cui la soddisfazione di un bisogno coincide immediatamente con la nascita di un altro, senza più un orizzonte valoriale in grado di guidare l’agire umano. Ne scaturisce un album introspettivo e minimale, dalle sonorità electro-pop, attraversato da un senso di rimpianto e da un livello di autoanalisi inedito per l’hip hop dei primi anni Duemila.
A Drake, Fisher dedica una recensione del disco Nothing Was the Same, pubblicata nel 2013. La sua tesi è che la malinconia che attraversa l’opera del rapper canadese non sia soltanto quella tipica dell’ultra-ricco che scopre come la ricchezza non basti a garantire la felicità. Drake, osserva Fisher, indossa le sneakers di chi ha dovuto risalire dagli abissi, pur non avendo mai davvero dovuto affrontare quel percorso. Proprio per questo la sua malinconia è ancora più profonda: gli è stato negato persino quel fugace momento di soddisfazione che si prova una volta raggiunta la cima della torre, subito prima che subentri la consapevolezza che nulla potrà sostituire il brivido della scalata. È da qui che nasce il senso di pesantezza che per Fisher impregna il disco, e che affonda le sue radici in ciò che descrive come “le confusioni di una generazione di uomini di fronte a imperativi contraddittori — la consapevolezza post-femminista che trattare male le donne non è cool, insieme al bombardamento burroughsiano di pornografia sempre disponibile”. La vera cifra di Drake, per Fisher, risiede dunque in questa incertezza: una mascolinità eterosessuale contemporanea che sa che il gioco patriarcale è ormai terminato, ma che non riesce ancora a rinunciare ai piaceri e ai privilegi che quel gioco ancora gli garantisce.
Nonostante gli scritti di Mark Fisher sul rap risalgano a più di dieci anni fa, le sue riflessioni restano sorprendentemente attuali nel panorama politico e culturale contemporaneo. Il rap continua a essere uno dei generi più ascoltati al mondo, e il suo attaccamento al “reale” — così come il suo sguardo nei confronti delle donne — non sembra essere mutato in maniera sostanziale. Al contrario, molti segnali indicano il compimento della traiettoria di commercializzazione del genere iniziata nei famigerati anni Ottanta. Come racconta Jason England, in un articolo pubblicato su «The Defector»: “A 50 anni, l’hip hop si trova a fare i conti con se stesso: ha raggiunto la sua crisi di mezza età. Ha accettato il lavoro in azienda, comprato la Ferrari, lasciato la famiglia e scaricato le app di incontri. Ha trovato nuove compagnie e continua a uscire nei club, ma nessuno ha il coraggio di dirgli che forse non è più il più figo della stanza. Ha anche fatto la cosa tristemente cliché di spostarsi a destra con l’età.” L’evoluzione del rap contemporaneo lo ha trasformato dunque in un linguaggio globalizzato, capace di colonizzare la cultura pop fino a esserne sostanzialmente assorbito. Oggi è sempre più difficile tracciare un confine netto tra ciò che è rap e ciò che è pop, così come riconoscere nel primo una qualunque spinta radicale.
Tuttavia, anche se il rap forse non possiede un autentico potenziale emancipatorio, continua a offrire alle giovani generazioni uno spazio in cui dare voce ad ansie, speranze e rabbia, mantenendo viva una forma di espressione capace di rappresentare le contraddizioni del presente. Se è vero, come sostiene Simon Reynolds, che l’attaccamento del rap al “reale” finisce per sancire la morte del “sociale”, offrendo una visione disincantata e riduttiva della realtà, è altrettanto importante sottolineare quanto questo postulato sia ingannevole. Innanzitutto, nessuna forma di narrazione si limita a “fotografare” il reale: ogni racconto lo interpreta, lo costruisce, lo orienta. Allo stesso modo, il rap — come qualunque altra espressione culturale — non si limita a rappresentare il mondo, ma lo influenza attivamente, contribuendo a modellare il modo in cui lo percepiamo e lo comprendiamo. In questo senso, anche quando molti rapper adottano una visione neoliberale e rinunciano a ogni ambizione trasformativa, il genere continua a esercitare un impatto concreto sulla realtà che lo circonda. Nel contesto italiano, ad esempio, il successo commerciale del rap nell’ultimo decennio ha avuto un impatto profondo sulla società, portando alla ribalta una scena musicale multirazziale. Nonostante questa scena abbracci spesso la stessa visione scarnificata della realtà che abbiamo descritto precedentemente, ha provocato una reazione di rigetto da parte di una parte consistente della società italiana, incapace di accettare fino in fondo la diversità che il rap oggi rappresenta. In questo scontro non emergono soggetti radicali o rivoluzionari, ma proprio in queste fratture si possono forse intravedere i germi di un conflitto sociale più ampio, che nella rappresentazione che il rap offre della realtà trova, ancora una volta, il proprio spazio di tensione e possibilità.