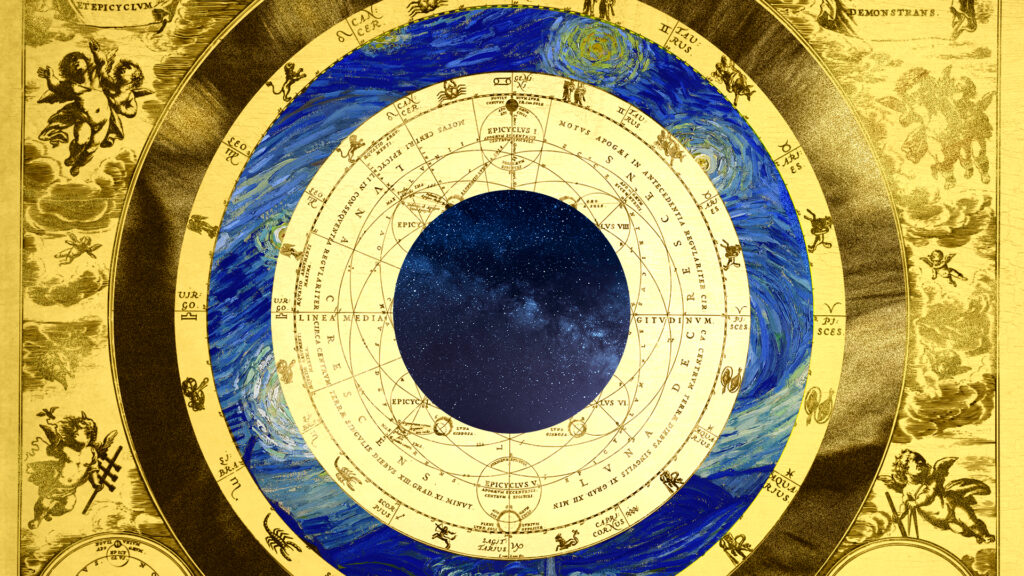Emiliano Ceresi
“The Room Next Door” ci mostra l’Almodóvar che verrà

04 Settembre 2024
Dopo una lunga carriera ricca di successi, il grande regista spagnolo ha scelto di girare a 74 anni il suo primo film in lingua inglese. Che, tra affinità e distanze con le opere del passato, sembra indicare un nuovo passo.
Due giorni fa è uscito nelle sale “The Room Next Door”: ne avevamo scritto da Venezia dove Pedro Almodòvar ha poi vinto il Leone d’oro.
Fa un po’ specie parlare di prime volte per un regista con la filmografia di Pedro Almodóvar, eppure così è per questo The Room Next Door presentato in concorso alla Mostra del cinema di Venezia.
Infatti, se non si contano i corti recenti, questo per Almodóvar è il primo lungometraggio girato in lingua inglese, fuori cioè dalla sua area sentimental-linguistica d’elezione: quella ispanofona.
E del resto lo stesso regista, prima ancora di iniziare le riprese, era parso consapevole dell’azzardo: “Per me è stato come affrontare un nuovo genere […] La mia insicurezza è scomparsa dopo la prima lettura al tavolo con le attrici, con lo scambio delle prime indicazioni”. Secondo Almodóvar però “La lingua non sarebbe stata un problema, e non perché padroneggiassi l’inglese, ma per la totale disponibilità di tutto il cast a capirmi e a rendermi facile capirli”.
Più che nella scrittura dei dialoghi, molto meditavi e meno melodrammatici o scattosi del solito, Almodóvar, come i registi che escono dagli ambienti in cui si muovono da sempre, pecca qui forse di un po’ di oleografia – facile pensare a Woody Allen con la sua cartolina di Piazza di Spagna in To Rome with love . Il suo istintivo amore per New York, su cui certo avranno pesato i molti capolavori cinematografici che l’hanno celebrata nel corso del tempo, lo porta, a tratti, verso il bozzetto.
Ecco le transizioni col ponte di Brooklyn ripreso a diverse ore del giorno, i diner con milkshake e topping di panna & amarena candita annessa, il bowling retrò (sebbene in flashback nostalgici e posticci), unite a quel kitsch insistito che è invece il suo contrassegno più riconoscibile e riuscito.
Almodóvar comprensibilmente ama la metropoli e costantemente la cerca e ricrea anche dalle finestre di appartamenti, invero più “simili a showroom“, che inquadra – e questa evidenza è però così smaccata da equilibrare e rendere apprezzabili i suoi cedimenti più folcloristici.
E chissà se c’entra l’approdo negli Stati Uniti, poi, nell’aver accelerato, con questo film, il distacco decisivo che nell’ultimo torno di tempo il regista ha impresso alla sua maniera. Ai contrasti cromatici e ai rossi squillanti – molti ricorderanno il gazpacho-vermiglio nella cucina smaltata di Donne sull’orlo di una crisi di nervi con cui aveva vinto il premio alla sceneggiatura a Venezia – subentra qui una fotografia più satura e crepuscolare, certo in linea coi toni della vicenda. Più che ad accentuare la nevrosi, la luce sembra mirata piuttosto ad aggiustare un’atmosfera di sospensione inquieta, come tra i figuranti di People In the Sun, il quadro di Hopper (pittore americano par excellence) viene citato a un certo punto.
Tuttavia, nei film di Almodóvar, resta nei decenni una costante: le protagoniste sono spessissimo donne, perlopiù amiche, sempre disposte al reciproco supporto. Accade anche in quest’ultimo che vede al centro due attrici grandissime: Tilda Swinton, nel ruolo di Martha, un’ ex reporter di guerra, e Julian Moore nelle vesti invece, simmetricamente rovesciate, di Ingrid, scrittrice d’autofiction col terrore insuperato della morte – “per me è innaturale” confessa a una sua lettrice durante un firmacopie.
Venuta a sapere da un’amica, accorsa in libreria, che l’ex collega ha un tumore, Ingrid si precipita in ospedale dove Martha sta curando il suo cancro con una terapia sperimentale e appare ancora ottimista, per quanto provata.
Le due iniziano così a ripercorre il loro passato comune: si sono infatti conosciute negli anni Ottanta a «Paper», un magazine cui entrambe hanno collaborato per un breve ma significativo tratto delle loro vite.
La prima parte del film si regge, di fatto, su una loro delicata conversazione fatta di ricordi, confessioni, rivelazioni, che nel tempo si sposta, senza troppa discontinuità nel montaggio come nelle inquadrature, dalle stanze d’ospedale agli appartamenti, dalle panchine dei parchi ai bar dei cinema.
Si scopre così, per gradi, come entrambe non siano davvero intime dal momento che non conoscono aspetti decisivi delle rispettive vite. A parlare è più che altro Martha che rivela di avere un rapporto guastato con la figlia, avuta giovanissima da un reduce del Vietnam poi suicidatosi in preda alle allucinazioni post-trauma, e a cui non ha mai saputo motivare le ragioni del suo distacco.
In realtà Martha non sembra avere particolari rimpianti per via dei propri atti mancati (“Non potevo dirglielo”) e le parole d’amore le riserva tutte per il proprio lavoro:“Le cose accadevano la notte qui”; “Ricordi?” e sorge il dubbio che il regista stia parlando dei suoi anni di libertà artistica dopo la fine della dittatura franchista. E d’altronde il lavoro è anche il filtro attraverso cui Martha guarda alla propria malattia parlandone in termini di “guerra” – e però senza adornarla di quella volontà “mitizzante” che Susan Sontag, in un suo notissimo saggio del 1979, associava alla retorica bellica intorno ai tumori.
Per Martha lavorare nelle zone di guerra significava soprattutto stare in compagnia – ed è per questo che intende affrontare la malattia con Ingrid, proprio come facevano i fotoreporter al suo fianco durante i conflitti. Forse, a rendere più agevole la loro prossimità sui divani in cui si confessano, avvicinate dallo zoom che le abborda prudente, è proprio questo loro essere amiche pur senza conoscersi del tutto.
A Ingrid, che è testimone questa lunga confessione, spettano quasi tutti i piani di ascolto e l’attrice è perfettamente calibrata nel rendere con delicatezza la commozione per ciò che non riesce a elaborare.
Le cure per Martha, però, non funzionano come sperato e la reporter decide di farla finita: dopo una vita passata ad attraversare il pericolo non sopporta il malfunzionamento del suo corpo, i guasti nella memoria, le falle nell’attenzione. Come con le sue trasferte di lavoro, la giornalista non vuole compiere questo gesto da sola e chiede a Ingrid di accompagnarla – per esaudire la sua volontà ha bisogno però che qualcuno stia “nella stanza accanto”. Le due partono insieme per una casa “stile Frank Lloyd Wright” in New England, che Martha ha affittato per un mese e inopinatamente il film trova qui, al netto della consueta solennità del registro, inneschi comici spesso molto riusciti.
Il giorno di arrivo Martha dimentica la pillola con cui intende togliersi la vita come fosse un mazzo di chiavi e le due sono costrette a fare retromarcia dopo aver disfatto i bagagli; non solo le interazioni con l’esterno vengono viziate dal pensiero della morte, ma anche le incomprensioni tra loro riescono felici quando grottesche o addirittura spettrali (“Ti sembra giusto arrabbiarti perché sono ancora viva?) oppure, con esorcismo apprensivo: “Attenta a uscire, fa freddo”.
Se molto convincente risulta il discorso che si instaura tra loro, lo svelamento degli appetiti erotici che non viene meno neppure nei momenti più estremi, il racconto dei rimorsi e quello dei ricordi, meno persuasivo appare il modo in cui entrambe dispiegano citazioni letterarie nel corso delle loro conversazioni.
È un rischio in cui si incappa spesso nei dialoghi: quello di appiattire i capolavori letterari nella resa discorsiva. Accade qui con un passaggio dei Dubliners, ma la stessa pecca si intravedeva, per mezzo di Faulkner, in Every Thing Will Be Fine, film di un grande autore come Wim Wenders.
E lo stesso vale per il personaggio interpretato da John Turturro, che è stato amante di entrambe e le cui battute risultano in alcuni frangenti forse troppo venate di apodittica ideologia per risultare credibili nella loro depressiva assenza di requie. Anche qui è più pregnante il fatto che il personaggio rifiuti le domande in coda alle sue conferenze sul cambiamento climatico per risparmiare un tempo di cui non sa come disporre. In questo caso deve aver pesato per Almodóvar, e certo lo si perdona di questo, il desiderio del regista di toccare immediatamente aspetti per cui avverte urgenza, ma che altrove scioglie con maggiore armonia.
Infatti il film riesce efficacissimo quando parla di autodeterminazione ed eutanasia senza nominarla (“Voglio morire pulita e asciutta”). E quando investe nella possibilità della voce o del dialogo nel momento in cui viene meno la possibilità dell’arte, Ingrid lamenta di non riuscire a leggere il suo adorato Hemingway, paradosso che è raccontato da un film: in questo è l’ideale prosecuzione di Talk to Her, come del recente Human voice.
Nonostante il Leone d’oro, The Room Next Door non verrà probabilmente ricordato come l’apice di Almodóvar, forse come un film di passaggio (non è il Dolor y gloria di questo tempo), qualcuno all’uscita dalla sala l’ha detto “minore”; ma più come una pellicola che, in certi affioramenti, ribadisce lo stile unico del regista, e tanto più nel cambiamento.
Su tutto, particolarmente, in questo: spicca la capacità di Almodóvar nel dirigere le attrici (per una volta non feticcio) in una recitazione diversa perché più attinente al copione, insieme a quella nell’allestire un teatro di agnizioni con un finale, audace, stavolta sì, soprattutto nel rimescolamento della ripresa letteraria.
Con grande curiosità si attende allora quello che da qui d’ora in poi potrà germinare – nel giardino di un regista di 74 anni, così rigoglioso di fiori variopinti, – e in cui pure sembra che si sia appena cominciato a innestare. I 17 minuti di applausi con cui la proiezione è stata accolta sembrano dirci qualcosa, dunque, dell’impazienza per ciò che si è intravisto in questo avvenire.
newsletter
Le vite degli altri
Le vite degli altri è una newsletter che racconta di vite che non sono la nostra: vite straordinarie, bizzarre o comunque interessanti.
La scriviamo noi della redazione di Lucy e arriva nella tua mail la domenica, prima di pranzo o dopo il secondo caffè – dipende dalle tue abitudini.
Contenuti correlati