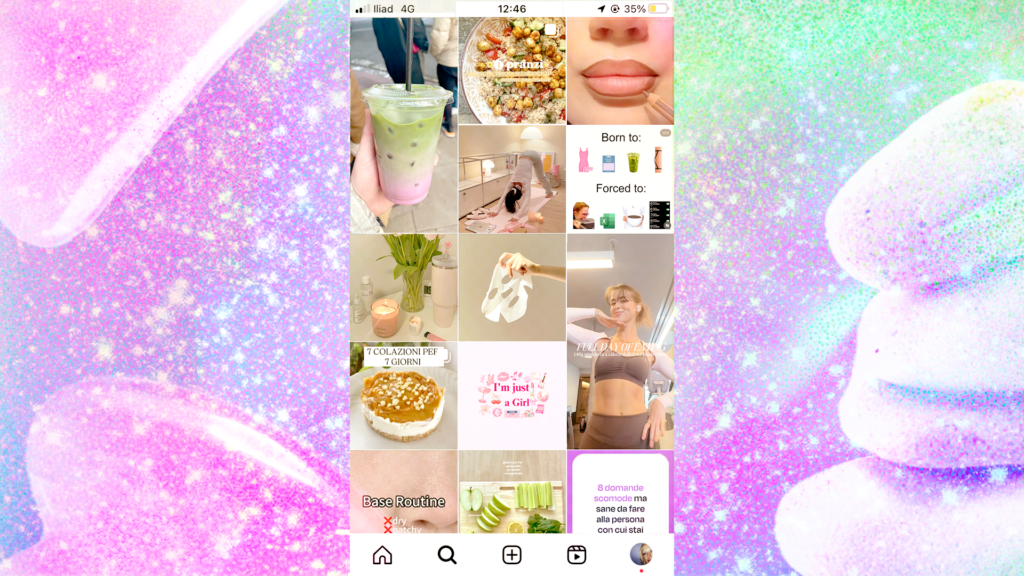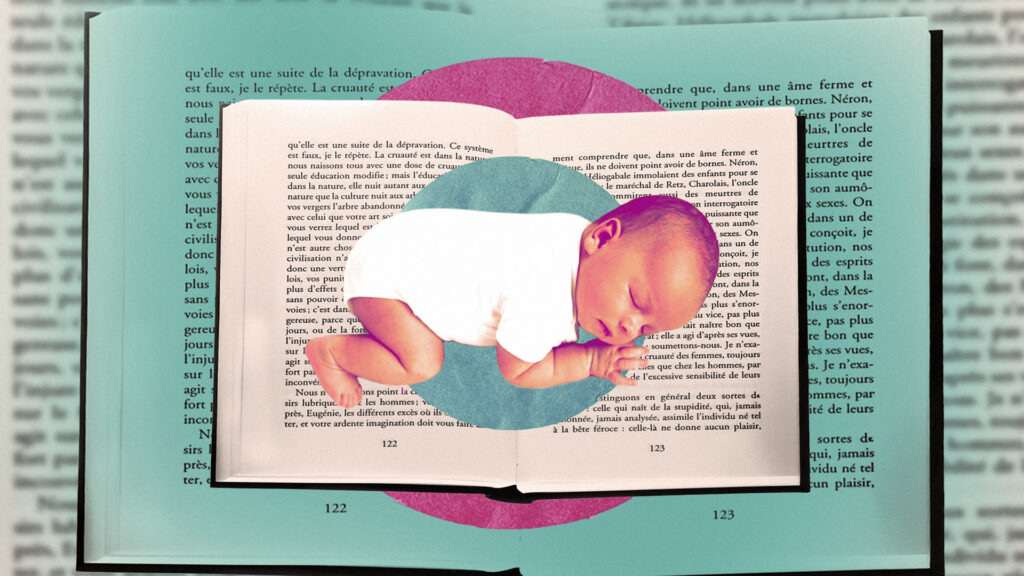Lorenzo Gramatica
Una vita per il cinema. Intervista ad Alberto Barbera

26 Agosto 2024
Il direttore della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia si racconta: gli inizi a Torino, i viaggi in giro per il mondo alla ricerca di film, le gioie e i momenti difficili a Venezia, dove la nuova edizione della Mostra, tra Guadagnino, Salles e molti giovani, promette tante sorprese.
A un mese dall’inizio dell’edizione 81 della Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia, il Lido è diverso da come me lo aspettavo. Non un paesaggio dechirichiano, con le bianche architetture razionaliste a stagliarsi sul mare, popolato giusto da qualche gabbiano riflessivo sfuggito alla ressa veneziana. Nelle mie fantasie, mi immaginavo di camminare verso l’Excelsior (uno dei due storici grandi alberghi di inizio Novecento, l’unico ancora in funzione perché l’altro, il Des Bains, è da anni lasciato lì, malinconicamente, a marcire) in completa solitudine, in una desolata passeggiata da film di Antonioni.
E invece, attorno ai luoghi dove ogni anno si svolge la Mostra, è tutto un accatastarsi di assi di legno, travi che penzolano, fili scoperti, con operai che invitano alla ritirata e chiedono permessi. Supplico dei vigili urbani affinché mi concedano il passaggio attraverso una zona timidamente recintata dove stanno potando alberi sofferenti, per non fare il giro largo – sono in ritardo di cinque minuti, in mano un tramezzino alla polpa di granchio comprato per la strada. I vigili, vedendo forse l’espressione spaesata, il ruminare e il deglutire patetico, acconsentono pietosamente con un cenno.
Il Lido, contrariamente alle mie aspettative un po’ naïf, è un cantiere. Normale: manca poco, tutto deve essere perfetto. Sono lontani i tempi della grande disorganizzazione, del “buco” – che è il titolo di un film di Jacques Becker, ma qui al Lido si riferisce solo alla voragine che per sette anni, dal 2009 al 2016, è rimasta, come una cicatrice, a deturpare l’area dove sarebbe dovuto sorgere il nuovo Palazzo del Cinema –, dei critici scontenti che si vendicavano del cibo scadente e della scarsità di servizi in articoli di fine Mostra più simili a rese dei conti che a equilibrati bilanci finali. Con Alberto Barbera – direttore prima dal 1999 al 2001, e poi dal 2012 ad oggi – le cose sono cambiate in modo significativo: Venezia è diventata via via più rilevante tra i festival mondiali, rivaleggiando alla pari con Cannes, e più attraente per il cinema hollywoodiano, per i produttori e per il mercato. Anche il pubblico di appassionati è cresciuto molto. Tutto questo senza tralasciare i film che, come dimostrano le edizioni di questi anni, rimangono al centro. Barbera ne è consapevole, ci tiene a dirlo, è felice di sentirselo dire.
L’appuntamento con lui è al Palazzo del Casinò, anche questo affollato, con un lento e metodico viavài di maestranze. Con le tapparelle abbassate e i calcinacci per terra ha l’aspetto di una villa un po’ dimessa e occupata saltuariamente da squatter.
La scala elicoidale che porta agli uffici di Barbera sembra quella da cui scende, nel finale di Sunset Boulevard, Norma Desmond. Ma certo Barbera ha un sorriso più rassicurante e sornione. Spalanca le braccia accogliente e porge la mano, che stringe con presa energica – viene alla mente Romano Prodi, che chiedeva ai suoi collaboratori di tirargli pugni in pancia per sfoggiare gli addominali d’acciaio e l’insospettabile fisico da sportivo, nascosto dietro l’aspetto bonario da curato.
Barbera è giovanile nell’aspetto, indossa polo blu, pantaloni cachi, scarpe da ginnastica in tela. I modi sono gentili, addirittura premurosi – hai mangiato? Caffè? Vuoi riposare un attimo?
Il suo ufficio è ordinato, arredato senza troppi fronzoli o chincaglierie. Alle pareti, qualche poster delle passate edizioni della Mostra, e una terrazza con vista sul lungomare: voltando lo sguardo a destra ecco l’Excelsior, di cui si intravede la lunga passerella che conduce al mare.
L’ufficio del direttore dà su un’altra stanzetta, regno di Angela Savoldi, sua storica assistente, con lui anche al Museo del Cinema di Torino, che Barbera ha diretto dal 2004 al 2016 – prima, molte cose: i ruoli nell’associazione A.I.A.C.E., la rubrica di critica cinematografica a «La Gazzetta del Popolo», la direzione del Festival Internazionale Cinema Giovani, oggi Torino Film Festival.
Per Barbera questa è la prima edizione dopo il cambio di rotta alla Biennale. Dopo i molti mandati in armonia e simbiosi con Paolo Baratta, e dopo gli ultimi anni con Roberto Cicutto, questa è la prima Mostra con Pietrangelo Buttafuoco alla Presidenza. Il vento è cambiato, ma è presto per dire come.
Dai molti film visti e dalle tante responsabilità artistiche e gestionali che il suo ruolo comporta, deriva anche una discreta stanchezza, che Barbera ci tiene a sottolineare prima di cominciare. Ma si fa per dire, forse per cortesia o understatement, perché poi stiamo lì due ore a parlare e, quando racconta dei film e dei registi che ama, si illumina, gesticola molto, si sporge sulla sedia. Se non fosse per me, che ho il treno di ritorno per Milano, la sensazione è che continuerebbe ancora e io finirei per dormire nell’atrio, tra i calcinacci e la polvere, come uno squatter.
Come nasce il tuo amore per il cinema?
Mio zio faceva il cassiere nel cinema parrocchiale del mio paese, nel biellese. Quando avevo cinque anni, una domenica, sono andato a trovarlo con mio padre. Siamo entrati in sala e appena vista la prima scena – una scena di tensione – sono scappato per la paura. Davano un film di cappa e spada, che ai tempi non capivo bene cosa significasse. L’emozione è stata così forte che è scattato subito il desiderio di tornare, di vedere di più. A sei anni, già andavo al cinema tutte le domeniche o quasi, a volte accompagnato da mia nonna, più raramente dai miei genitori. Ma più spesso andavo da solo.
E lì hai capito che avresti voluto lavorare nel cinema o col cinema?
Come tutti i bambini, volevo fare l’attore. Poi, verso i quattordici anni, ho capito che il regista era più importante dell’attore, che era quello che comandava. Alla fine del liceo ho cercato di convincere mio padre a mandarmi al Centro Sperimentale di Cinematografia. La sua risposta: “Non ci pensare neanche. Prima fai l’università, poi fai quello che vuoi”. Però il mio obiettivo era quello, lavorare nel cinema.
E quindi, dalla provincia di Biella vai a Torino.
Dopo due o tre anni di università, vengo a sapere che l’A.I.A.C.E. (ndr: l’Associazione Italiana Amici Cinema d’Essai) cercava ragazzi per fare le schede che venivano distribuite gratis all’ingresso delle proiezioni dei film in prima visione. Ho cominciato così. Visto che i cinema d’essai proiettavano soprattutto film stranieri, era abbastanza facile trovare articoli e interviste ai registi su riviste francesi e inglesi. Le traducevo, le montavo, le editavo. Ho frequentato pochissimo l’università perché tutto il tempo lo passavo in sala. La maggior parte dei film di Hitchcock e della Nouvelle Vague li ho visti nei cinema di terza e quarta visione dei quartieri popolari torinesi.
Prima cotta cinematografica?
A quattordici anni, sempre in un cinema parrocchiale: I 400 colpi di Truffaut. Un film che mi ha segnato perché mi ha fatto scoprire il cinema d’autore. Con Truffaut ho avuto accesso a un’altra dimensione.
E l’università? Cosa ricordi?
Gli unici seminari che seguivo erano quelli di letteratura moderna e contemporanea, e quelli di estetica di Vattimo. Nel suo corso c’era anche Rondolino, che teneva i seminari sul cinema, con cui poi mi sono laureato.
“La prima volta che sono entrato in un cinema c’era una scena di tensione e sono scappato per la paura. L’emozione è stata così forte che è scattato subito il desiderio di tornare, di vedere di più. A sei anni, già andavo al cinema tutte le domeniche”.
Vattimo e Rondolino sono esponenti di un mondo critico, intellettuale e di una Torino in cui il cinema era un’arte ancora fortemente in dialogo con le altre discipline. Su loro iniziativa nasce il Festival Internazionale Cinema Giovani, per cui poi lavorerai tanti anni.
Assolutamente sì. Torino era una città relativamente provinciale, ma non nella dimensione culturale, con una storia cinematografica enorme. Originariamente era la capitale del cinema muto, ma ha perso questo primato alla fine della Prima guerra mondiale, quando il cinema si è spostato a Roma per ragioni finanziarie e politiche. Quella che si è consolidata lì invece è una tradizione critica, grazie alla nascita di riviste come «Il Nuovo Spettatore cinematografico» e «Ombre Rosse»… E poi il Movie Club. In tutta Italia, i cineclub sono stati fondamentali nel far progredire il rapporto tra critica e cinema. Oltre al Movie Club di Torino c’erano il Film Studio a Roma, l’Obraz a Milano, il Lumière a Bologna… Erano esperienze veramente all’avanguardia, nate sull’impulso di alcune riviste di tendenza che stavano cambiando la critica cinematografica, con la scoperta di nuovi autori ma anche con la rilettura del cinema classico del passato. C’era un fermento culturale che oggi è impensabile.
Tu a cinque anni vedi un cappa e spada che ti terrorizza e ti affascina in modo fatale. Qualche tempo fa una critica molto brava che tu conosci bene, Emanuela Martini, mi ha detto: “Le uniche persone con cui posso parlare di cappa e spada sono Alberto Barbera e Goffredo Fofi”.
[Ride] Sì, ai tempi quello era un genere popolare. In quegli anni c’erano i cappa e spada, c’erano i peplum… Ho visto tutti i peplum italiani al cinema.
Qualche anno fa hai anche portato a Venezia Maciste alpino restaurato.
Certo. Bellissimo, pazzesco Maciste alpino. Poi sono arrivati i western all’italiana, il cinema d’autore, la New Hollywood, il New American Cinema Group. Il cinema di genere, popolare, quello d’autore, coesistevano senza contraddizioni. Nessuno diceva “No, non bisogna andare a vedere il peplum o il western perché c’è la nouvelle vague o il nuovo cinema brasiliano”. Il cinema era il cinema, nella sua totalità. Era il filtro attraverso il quale rapportarsi al mondo.
La tua è stata un’educazione al cinema in sala senza troppe gerarchie, onnivora.
Moltissime delle cose che ho imparato non le ho imparate leggendo, ma andando al cinema. Tu vedevi un peplum e imparavi la storia di Roma, guardavi un western e scoprivi la conquista del West. Era uno strumento di conoscenza. Ai tempi dell’università, con alcuni amici più stretti, si parlava quasi solo di film. Tutte le sere si prendeva il tram e si andava al cinema in un quartiere diverso. Facevamo un gioco. Ci chiedevamo: “Quali sono per te le cose più importanti nella vita?”. Per me la più importante era il cinema, poi venivano le donne e la politica.
Ah, la politica solo terza in quegli anni?
[Ride] Sì.
Solo terza?
Eh ma le altre due…
Forse solo Walter Veltroni, ai tempi, avrebbe messo prima la politica, poi il cinema, poi le donne.
Il cinema era veramente l’ossessione principale. Si conoscevano persone interessanti grazie al cinema, anche i registi. Si organizzavano serate, rassegne, poi via via cose sempre più grandi. Si imparava un mestiere col cinema.
“Gli equilibri sono cambiati. Il cinema cinese soffre e anche nell’est Europa c’è poca roba. Forse il panorama maghrebino è il più vivace e interessante, oggi”.
E tu impari, tanto che poi di A.IA.C.E. diventerai segretario generale…
Io all’inizio ero il braccio destro del segretario generale della A.I.A.C.E. di Torino, che era la sede più forte in Italia ed è arrivata a contare 28mila iscritti. Dopo aver fatto il servizio militare, sono tornato a Torino e c’è stata una crisi all’interno dell’associazione perché l’A.I.A.C.E. aveva fatto un accordo con l’Unione Culturale. L’Unione Culturale era un centro di ispirazione comunista, che organizzava incontri e rassegne, e che stava nei sotterranei di Palazzo Carignano. Il segretario dell’Unione Culturale all’epoca aveva proposto all’A.I.A.C.E. di investire nella ristrutturazione di una parte dei sotterranei inutilizzati di Palazzo Carignano per creare una sala cinematografica. Lì è nato un conflitto di ordine economico: i lavori erano costati molto, molto di più del previsto e l’Unione Culturale voleva che fosse l’A.I.A.C.E. a pagarli. Per cui è successo un casino. Il segretario generale si è dovuto dimettere e mi hanno chiesto di prendere il suo posto. L’anno dopo ho fatto un anno di supplenza in una scuola media: un incubo, la peggiore esperienza che ho fatto nella vita.
Non salvi niente di quell’esperienza?
Salvo il rapporto con i ragazzi, ma tutto il resto è stato per me una fatica. Tornavo a casa stremato.
E poi l’insegnamento ti distoglieva da cinema, donne, politica e quindi avrai pensato: se è così faticoso perché devo investirci tutto questo tempo?
L’anno dopo ho detto basta. Ho mandato un telegramma al Provveditorato: “Cancellatemi da tutte le liste, io non esisto più per voi. Addio”.
In quegli anni inizi anche a collaborare con «La Gazzetta del Popolo».
Ho avuto una serie di colpi di fortuna. Il titolare della rubrica di critica cinematografica de «La Gazzetta del Popolo» era Marco Vallora, che era un amico dai tempi dell’università. Quando gli offrono di andare a «Panorama», lui suggerisce al giornale di mettermi alla prova. «La Gazzetta del Popolo» mi ha preso subito: in nero, sottopagato. Mi davano duecentomila lire al mese per scrivere un pezzo al giorno. Recensivo tutti i film che uscivano in una stagione – all’epoca erano 450 all’anno più o meno, adesso sono molti di più.
Avrai visto e scritto parecchio…
Tantissimo. Vedere tutti i film che escono, non solo quelli che ti interessano, ti dà la percezione di cosa sia il cinema in una stagione. Vedevo tutto, anche le nefandezze più atroci.
Che tipo di critico eri? Eri severo? Stroncavi molto?
Ero diventato amico di Achille Valdata, il “Vice” de «La Stampa», un decano della critica torinese. Mi disse: “Sei molto equilibrato, scrivi bene, non esageri con gli aggettivi”. Però ecco: scrivendo così tanto, tutti i giorni, di fretta, la qualità della scrittura non poteva certo essere elevatissima.
Ti sei divertito, insomma.
Molto. Andavo al cinema tutti i giorni, spesso due o tre volte al giorno, perché ai tempi non c’era l’abitudine di far uscire i film solo il giovedì. Ero diventato amico di Lorenzo Ventavoli, un esercente illuminato, storico del cinema e intellettuale – suo padre aveva aperto il primo cinema d’essai torinese, il Romano. Una volta scrissi una entusiastica e lunga recensione – all’epoca i giornali non avevano problemi di spazio – de Il grande uno rosso di Samuel Fuller, che lui proiettava. Ventavoli aveva comprato cinquemila copie del giornale e le aveva distribuite gratuitamente fuori dal cinema. Due anni dopo la Gazzetta è fallita.

Alberto Barbera con Gianni Rondolino e Stefano Della Casa.
Avevi dei riferimenti critici nella scrittura? Chi leggevi?
Da bambino abitavo in un paesino di seimila abitanti nei dintorni di Biella, non c’era nessuno che mi indirizzasse alla lettura. A Biella le riviste di cinema nemmeno arrivavano, quindi la prima mi è capitata sotto mano in parrocchia. Era «Letture», una rivista milanese pubblicata dai Padri Gesuiti del Centro S. Fedele di Milano, che pubblicava recensioni approfondite di cinema, letteratura, teatro. C’era un critico di cinema bravissimo, che si chiamava Padre Luigi Bini. Ho cominciato leggendo i suoi pezzi. Poi, al liceo, trovo per caso nell’unica grande libreria di Biella, rovistando tra i mucchi di libri, la rivista «Cinema & Film». E lì mi rendo conto dell’esistenza di un’altra critica, di un altro mondo. Inizio a leggere «Cineforum», anche questa una rivista cattolica, «Film Critica», «Ombre Rosse», ovviamente i «Cahiers du Cinéma». Questo per dirti che, quando sono arrivato all’università e seguivo i corsi di Guido Aristarco, io ero già prevenuto nei confronti della rivista di cui era direttore, «Cinema Nuovo», con tutto quello che aveva rappresentato per la critica italiana.
Com’era Aristarco da professore?
Come professore non era niente male, spiegava bene. Pacato, molto didascalico. Una volta vado a fare un colloquio con lui e gli dico: “Guardi Aristarco che io non sono d’accordo con lei, con le posizioni di «Cinema Nuovo»” e lui mi risponde “Non c’è nessun problema, dillo a lezione, così facciamo un dibattito…”, cosa che poi ovviamente non ho mai fatto. Lui e Rondolino erano rivali, in tutti i sensi. Si odiavano.
Tu eri rondoliniano?
Sì, con qualche riserva, anche se poi siamo diventati amici. Gli devo tutto. I miei riferimenti però erano altri, «Ombre Rosse» ad esempio – ero diventato molto amico di Goffredo Fofi e di Gianni Volpi, che era un grandissimo critico, l’anima della rivista, uno di cui ho sempre avuto una stima enorme ma con un vizio tremendo: era di una pigrizia pazzesca. Non si alzava mai dal letto prima delle dieci del mattino. Insegnava in un liceo, aveva detto al preside: “Quando fate l’orario se mi mettete alle otto io non vengo, posso solo dalle undici in poi. Quindi vedete voi”. Mi ha insegnato un sacco di cose. Non li conoscevo personalmente, ma leggevo e ammiravo tantissimo anche Enzo Ungari, Adriano Aprà, Marco Melani, insomma tutta quella generazione di critici. Poi Fernaldo Di Giammatteo, che ai tempi stava avviando la collana del Castoro dedicata al cinema. Andava in giro per le città d’Italia a cercare giovani critici a cui affidare le redazioni dei Castori, nel 1977 è passato anche all’A.IA.C.E. di Torino.
E tu hai scritto un Castoro su Truffaut.
Io in realtà avrei dovuto fare Alain Resnais e Paolo Bertetto quello su Truffaut. Di Giammatteo ci fa il contratto, ma poi Bertetto mi chiede di fare a cambio e io mi prendo Truffaut. La mia più grande passione era la Nouvelle Vague. Snobbavo – sbagliando – il cinema italiano, perché il mio riferimento erano i film francesi, la critica francese, la politique des auteurs, che adesso è in parte superata.
Beh erano testi critici straordinari quelli che nascevano attorno ai Cahiers, ancora oggi li leggi e ci trovi intuizioni straordinarie, provocazioni ragionate, una lingua, una postura nuove…
Assolutamente sì, anche se il cinema è cambiato molto rimangono un riferimento imprescindibile e irreplicabile.
È uno sguardo, prima che un metodo. Infatti, una delle cose che colpisce scorrendo i vecchi programmi del Festival Internazionale Cinema Giovani di Torino, di cui eri direttore, è l’attenzione a determinate cinematografie, come quella indipendente americana degli anni Novanta, quelle asiatiche. Si intravede già una direzione che poi caratterizzerà anche la tua esperienza alla Mostra di Venezia.
Il primo anno del festival è il 1982, Rondolino mi chiede di fare l’ufficio stampa, poi due anni dopo divento segretario generale. In quegli anni eravamo in quattro a fare tutto: io, Rondolino, Turigliatto e Steve Della Casa. Io mi occupavo dell’organizzazione, della gestione amministrativa e della selezione, Roberto Turigliatto era responsabile delle grandi retrospettive sulle nouvelle vague degli anni Sessanta e Stefano Della Casa gestiva quello che si chiamava Spazio Aperto. Nel 1989 sono diventato direttore. I film ai tempi bisognava andarseli davvero a cercare, letteralmente.
Dove vai a cercarli?
A New York, certo, ma soprattutto a Est. Viaggiavo con Marco Müller, eravamo diventati amici, giravamo sempre in coppia, ci chiamavano Gianni e Pinotto. Müller sarebbe poi stato direttore del Festival di Pesaro, di Rotterdam, di Locarno e ovviamente di Venezia. Facevamo questi lunghi viaggi in Centrasia ed Estremo Oriente: Mosca, Hong Kong, Pechino, Tokyo, Taipei, Seoul, India. Stavamo via tre-quattro settimane, conoscevamo tutti i registi. Siamo stati i primi direttori di festival occidentali ad andare in Kazakistan nel 1991, ricevuti come se fossimo ambasciatori di governi, messi a dormire in questo grande albergo dove stavano i politici che venivano in visita. Una cosa incredibile. Posso raccontare degli aneddoti pazzeschi.
Ti ricordi cosa eri andato a cercare in Kazakistan?
Sì, ho preso un film che poi ha vinto anche un premio a Torino, The Last Cold Days di Bolat Kalymbetov e Bulat Iskakov. Ho cominciato ad andare tutti gli anni a Teheran, al Fajr Film Festival, spesso a Hong Kong, che era già un mercato importante, forse ai tempi anche più di quanto non lo sia adesso. Erano gli anni della nouvelle vague hongkonghese e di quella taiwanese. E lì ci si incontrava con un gruppo di persone, tutti occidentali, tra cui David Streiff, Ulrich Gregor e sua moglie, Dimitri Eipides, Wouter Barendrecht, Tony Rains: sette o otto, non di più, tutti direttori di festival o curatori di importanti rassegne (Locarno, il Forum di Berlino, Rotterdam, Vancouver). Si vedevano gli stessi film, si diventava amici degli stessi registi, ci si scambiava le informazioni di cui entravamo in possesso.
Vi sentivate dei pionieri.
Eravamo accolti dappertutto con grandissima curiosità. Ricordo una cena in un albergo a cinque stelle di Hong Kong, una tavolata con una dozzina di registi e produttori, una parte della nouvelle vague del Paese riunita (John Woo, Stanley Kwan, Clara Law, Wong Kar-wai, Kirk Wong), che ci chiedevano: “Ma perché i nostri film non trovano mercato in Europa? Perché non vengono comprati? Perché nessuno li distribuisce?”. All’epoca i loro film li vedevi solo ai festival. A Teheran, in un bar, abbiamo fatto amicizia con Kiarostami e gli altri iraniani: Mohsen Makhmalbaf, Rakhshan Bani-Etemad, Majid Majidi… I più grandi registi di quegli anni li incontravi con facilità.

Il Palazzo del Casinò al Lido di Venezia.
La Mostra non è solo un punto di arrivo, ma un punto di partenza e una tappa che accompagna tutta la carriera di un regista. Penso ad autori come Lav Diaz, che ha esordito a Venezia nel 2008 con Melancholia e nel 2014 ha vinto il Leone d’Oro con The Woman Who Left. Quest’anno porterà a Venezia un nuovo film. In un certo senso, da Venezia Diaz è stato lanciato, coccolato, cresciuto. Con il mercato che cambia, questa ti sembra destinata ad essere sempre di più la funzione dei festival di cinema?
Certo, è l’inizio di un percorso che proseguirà negli anni successivi. Credo che in un certo senso sia sempre stato così, pensa al ruolo che ha avuto Venezia negli anni Cinquanta nella scoperta e valorizzazione del cinema giapponese, che non esisteva sulle mappe internazionali: nel 1951 vince Rashomon, e poi da lì tutti gli anni c’erano due giapponesi in concorso, Mizoguchi, Kurosawa, Ozu. Venezia ha fatto conoscere quel cinema in Europa, ma si potrebbero fare altri esempi. La funzione di scoperta e di valorizzazione degli autori è connaturata al ruolo della Mostra, alla sua storia e al suo prestigio. Questa cosa continua oggi: negli ultimi anni alcuni dei premi più importanti sono andati a registi o registe completamente sconosciute, come Audrey Diwan.
Anche Lorenzo Vigas, Alice Diop…
Alice Diop, con Saint Omer, certo. E tanti altri. Se si mantiene uno sguardo curioso, se si fa molto scouting, direttamente e circondandosi di collaboratori bravi ed esperti delle varie cinematografie – l’esperto di cinema cinese, di cinema sudamericano, di cinema sudorientale, etc. – si riescono a intercettare le cose più interessanti, quelli che poi diventano i nuovi punti di riferimento del cinema contemporaneo. Questa credo che sia la funzione principale di un festival.
I festival di cinema hanno ancora la stessa importanza di allora?
I festival oggi non solo non hanno perso importanza, ma l’hanno aumentata. I grandi produttori, comprese le piattaforme, e quelli indipendenti, hanno tutti bisogno dei festival. Mai come negli ultimi anni ho sentito la pressione da parte delle produzioni per accaparrarsi un posto in selezione. Se oggi rifiuti un film, il produttore – o il distributore, il sales agent – ti scrive quattro o cinque volte chiedendoti di riconsiderare la tua decisione. C’è molta ansia e la paura di non riuscire a trovare uno spazio per promuovere il film e, di conseguenza, aumentare le chance di garantirsi un’uscita in sala. E poi i festival sono rimasti anche uno dei pochi spazi dove poter discutere dei film.
Ricordo la proiezione al PalaBiennale di Under the Skin di Glazer nel 2013. C’era un clima da stadio: fischi, applausi, discussioni accese a fine proiezione con estranei, una cosa che ovviamente non può accadere altrove. A un festival non scegli le persone che hai di fianco in sala, becchi il critico che ha la luna storta dopo aver saltato il pranzo o la signora di Venezia che è venuta al Lido e ha pagato profumatamente per vedere un film che magari l’ha pure delusa profondamente. Si crea una situazione irripetibile, di vitalità, di passione, di scambio.
Quando ho portato a Venezia Jonathan Glazer, che mi piaceva tantissimo, non mi sarei mai immaginato una reazione del genere, la più scomposta che ci sia mai stata a una proiezione ufficiale in Sala Grande, dove c’è un pubblico particolare, più pacato, applaudono quasi tutti, alcuni magari più intensamente, altri meno, però sempre in un clima rispettoso. Quella volta erano tutti incazzati neri, addirittura c’era chi insultava il regista. Glazer e Scarlett Johansson erano spaesati, avviliti, non sapevano che fare, sono dovuto andare a consolarli: “State tranquilli, guardate che non è così. Poi vedrete che il film andrà bene”. Infatti poi Under the Skin è diventato di culto, uno dei film più votati del decennio nelle classifiche dei critici, soprattutto anglo-americani. Ma alla Mostra è stato accolto con la reazione più violenta in assoluto, me lo ricorderò sempre, imbarazzantissimo.
Il pubblico comincia a cambiare e a diventare centrale durante la direzione di Carlo Lizzani, a inizio anni Ottanta. Nel 1980 Umberto Eco è giurato e si accorge che arrivano al Lido molti giovani, con i loro sacchi a pelo, che sono davvero appassionati: si guardano 4-5 film al giorno, si infervorano, magari sghignazzano o fischiano, comunque partecipano. Kezich parla di massentizzazione della Mostra, riferendosi all’Estate Romana, che in quegli anni fu una rivoluzione. Il collaboratore più stretto di Lizzani d’altronde era Enzo Ungari, che è stato uno degli ideatori di Estate Romana. Nel 1980 arriva anche la Rai con i furgoni, le troupe, le telecamere, le attrici in veste di conduttrici. Il ruolo del critico si fa meno importante: le persone vogliono sapere cosa pensa il regista, cosa dicono gli attori, cambia la narrazione attorno al film. Con Lizzani cambia anche la struttura della Mostra, delle sezioni; cinema popolare e d’autore coesistono in modo più armonico, una lezione che poi tu hai seguito, mi pare.
Io facevo parte di quella generazione che contestava i vecchi critici, magari anche ingiustamente – averceli oggi! I quattro anni della gestione Lizzani li ho seguiti come corrispondente de «La Gazzetta del Popolo». Già all’epoca con Lizzani, e con Ungari che selezionava un cinema diverso da quello che finiva in competizione, c’era uno scontro di prospettive critiche che però trovavano all’interno del festival una armonia favolosa. Lizzani aveva fatto fare un salto in avanti al modello di festival che esisteva a Venezia, a Cannes, a Berlino. Quando sono arrivato per la prima volta a Venezia nel 1999, il mio modello era la Mostra di Lizzani e Ungari di quegli anni, una Mostra dove il cinema d’autore radicale, le anteprime e il cinema popolare non erano più separati in modo netto. Era quello che bisognava fare, anzi bisognava spingersi oltre, contaminare. Poi quando sono tornato a Venezia nel 2012, questa volontà è stata ancora più evidente. Ai tempi, abbiamo discusso molto sui criteri di selezione: ha senso mettere in concorso film più di ricerca, più estremi, con prodotti hollywoodiani? Parlare di cinema d’autore come si era fatto fino a quel momento non aveva più senso, bisognava rivedere tutto, tenere in considerazione la trasformazione radicale dell’industria dell’audiovisivo, abbracciare il melting pot di influenze e culture diverse che era ed è lo specchio del cinema di oggi. Nel 2014 il Leone d’oro lo vince Lav Diaz, due anni dopo Todd Phillips con Joker. Per molti, questa cosa è insensata, per me invece non lo è per nulla, anzi.
“Se si mantiene uno sguardo curioso si riescono a intercettare quelli che poi diventano i nuovi punti di riferimento del cinema contemporaneo. Questa credo che sia la funzione principale di un festival”.
Quando vieni nominato per la prima volta direttore della Mostra, nel 1999, Baratta dice che ti ha scelto per scrollarsi di dosso un po’ di residui del sessantottismo. Cosa intendeva?
Lui ce l’aveva soprattutto con il sottobosco romano che popolava il cinema italiano.
Infatti Kezich, alla tua nomina, titola: “Il vento del Nord soffia sulla Mostra”.
Erano tutti romani prima. Lavoravano da Roma, arrivavano qui una settimana prima della Mostra ed erano percepiti da Venezia come un corpo estraneo, un’imposizione dall’alto che portava dei modi che non appartenevano alla città. La rivoluzione che abbiamo fatto con Baratta consisteva anche in questo. Sin dal 1999, io venivo a Venezia ogni settimana e mi ci fermavo a lavorare per almeno tre giorni. Ora ci vengo meno nel corso dell’anno, ma da fine maggio sono qui con l’intero comitato di selezione. Il grosso del lavoro di selezione lo si fa al Lido, la Mostra la si prepara da qui. La regione, la città sono solidali con la Mostra del cinema, non siamo più visti come espressione di un mondo romano, per di più poco amato. Questo è uno degli aspetti dell’operato di Baratta che è destinato a rimanere.
Siete stati anche i primi a ringraziare il Lido, riconoscendogli un ruolo.
Gli abitanti del Lido detestavano la Mostra del cinema: quando cominciava, molti scappavano, andavano nella seconda casa per non essere disturbati dalle frotte di stranieri che arrivavano qui. Adesso non succede più, ma ci è voluto tempo. Oggi gli abitanti del Lido mi fermano per strada, mi salutano, chiedono della Mostra, mi ringraziano.
Nel 2001 tu lasci la Mostra perché Urbani, allora Ministro della Cultura, e Sgarbi, sottosegretario, chiedono la tua sostituzione. Che successe?
Ho conosciuto Sgarbi all’inaugurazione della Biennale di Arti Visive del 2001. Quel giorno, faccio un pezzo di visita con lui. Camminando, molto cordialmente mi dice: “Barbera, mi dicono che tu sei il più bravo di tutti. Però sai, noi dobbiamo cambiare, dare un’impressione di discontinuità, fare le nostre nomine. Non possiamo riconfermarti. Però se vuoi lavorare con noi ti troveremo un altro posto”. Io l’ho ringraziato e gentilmente declinato. Il mio mandato sarebbe scaduto l’anno dopo. Quello di Baratta però scadeva proprio quell’anno. Urbani all’inaugurazione della Mostra d’Arte Cinematografica era freddo, sicuramente non cordiale. Lì ho capito che l’avventura veneziana sarebbe finita prima del previsto.
Perché nel 2012 accetti di tornare a fare il direttore della Mostra?
Ho accettato di tornare a Venezia, benché fossi al Museo del Cinema di Torino, dove mi trovavo benissimo, a condizione che si investisse nel ristrutturare completamente le sale di proiezione, costruendone anche di nuove. E poi a patto che si mettessero in discussione la struttura organizzativa e l’accoglienza, le si perfezionasse, cose che siamo riusciti a fare. Oggi, non lo dico io, ma ce lo dicono i produttori e i registi invitati, in pochi festival del mondo trovano condizioni di accoglienza così efficienti, precise, affidabili.
Anche la natura della Mostra è cambiata. Orizzonti è diventata col tempo una sezione con una sua forte identità, e un’importanza quasi paragonabile a quella del concorso principale.
Fino ai primi anni Duemila, quando si chiamava ancora Cinema del Presente, Orizzonti era una sezione non competitiva, poco attraente per media, stampa, pubblico. C’era poco interesse, poca curiosità, era difficile convincere i registi a portare film in quella sezione. Allora ci siamo inventati un secondo concorso, con i suoi premi.
“Ai tempi dell’università, con gli amici facevamo un gioco. Ci chiedevamo: ‘Quali sono per te le cose più importanti nella vita?’ Per me la più importante era il cinema, poi venivano le donne e la politica.”
Sui giornali alcuni scrivevano: “Non si capisce la lungimiranza di fare due concorsi”.
Erano tutti contro. Mi davano del matto. Oggi in concorso ci sono film che fino a qualche anno fa sarebbero stati in Orizzonti. Per citarne uno: nel 2022 Cannes voleva mettere Saint Omer di Alice Diop in Un Certain Regard, io gli ho offerto il concorso principale. Alla fine, ha vinto il Leone d’argento. In Orizzonti quest’anno c’è il secondo film di Alexandros Avranas, che aveva vinto due premi a Venezia anni fa con Miss Violence. Mescoliamo molto le carte, in modo che non sia così netta la distinzione tra il concorso principale e quello Orizzonti.
Se oggi Orizzonti, a distanza di anni, è una sezione compresa da tutti, faccio più fatica a vedere la lungimiranza di Venice Immersive, dei film in Augmented Reality, su cui tu sembri puntare molto. Quale futuro hanno, a livello di mercato e di potenzialità espressive?
Guarda, non lo so. Non è il futuro del cinema, questo è sicuro. Siamo ancora in una fase sperimentale, in qualche modo non così dissimile da quella in cui si trovava tutto il cinema negli anni Dieci, quando era ancora alla ricerca di uno standard tecnologico, linguistico, formale, narrativo, e procedeva per tentativi. Il cinema immersivo, oggi, è esattamente in quella situazione. Ogni anno fa un passo avanti. Ho visto i film di quest’anno, e rispetto alla scorsa edizione c’è stato un salto sia tecnologico – è migliorata enormemente la definizione e la qualità della visione – sia in termini di ricerca estetica e linguistica. Lo standard ancora non c’è, ci si arriverà. Così come non c’è un mercato: questo è il problema principale, il blocco più grande allo sviluppo del cinema immersivo.
Una cosa, più di tutte, divide la Mostra di Venezia dalla sua più grande “rivale”, Cannes: il rapporto con le piattaforme di streaming online. Venezia si è aperta ai film Netflix, Apple + etc, Cannes no, oppone una ferma opposizione.
Thierry Frémaux, delegato generale di Cannes, sarebbe felicissimo di poter ospitare in concorso i film delle piattaforme, ma glielo impediscono la legislazione francese e il suo Consiglio di amministrazione, dove sono rappresentate tutte le categorie del sistema cinema, compresi gli esercenti e i distributori, che sono ovviamente i più ostili a questo mutamento. In Francia c’è una legge che impone delle finestre che devono intercorrere tra l’uscita in sala di un film e la sua diffusione sulle piattaforme. Oggi queste finestre sono di 15 mesi, ma qualche anno fa erano addirittura di 36 mesi. Sono condizioni che per le piattaforme sono inaccettabili, e che appartengono alla preistoria dei rapporti tra cinema e televisione. Oggi la durata media di permanenza di un film nelle sale è, quando il film è di successo, di un mese, un mese e mezzo. Poi i film vanno sulle piattaforme, hanno un’altra vita. Insomma, Thierry vorrebbe, ma non può. In Italia siamo favoriti dalla mancanza di regole altrettanto rigide.
E questo a livello distributivo. Ma per quanto riguarda l’aspetto artistico-formale? Tu a cinque anni vai a vedere il tuo primo film nel cinema parrocchiale, su un grande schermo, dove l’occhio che può muoversi orizzontalmente e verticalmente in libertà. Ad esempio, un film di Paradžanov oggi, immaginato per un supporto più piccolo, è impensabile per le piattaforme.
Se parliamo di prodotti top di gamma, chiamiamoli così, cioè il cinema d’autore, questo continua ad esistere a prescindere dal fatto che siano prodotti destinati alle piattaforme. Quelli di Cuarón, Scorsese, Fincher, sono film girati con criteri cinematografici, con un impianto produttivo cinematografico, con un linguaggio che è cinematografico. Anche le serie. La novità di quest’anno a Venezia è l’apertura alle serie, abbiamo Joe Wright, Sorogoyen, Vinterberg e Cuarón, lavori che vanno dalle cinque ore e mezza alle otto ore di durata. Sono film lunghi, girati da registi di cinema. Poi è chiaro che vedere il film di Cuarón in sala e sullo schermo casalingo sono due cose diverse, però se tu hai la fortuna di vedere il film in quelle due o tre settimane in cui esce al cinema hai la stessa esperienza che avevi prima quando vedevi un film hollywoodiano o un film d’autore.
Mi chiedo se sarà così anche per il cinema documentario. Venezia ha una grande tradizione in questo senso: solo da quando sei tu direttore della Mostra sono passati e sono stati spesso premiati Oppenheimer, Seidl, Wiseman, Morris, Maresco, Wang Bing. I cataloghi documentari delle piattaforme sono abbastanza sconsolanti, si trovano soprattutto prodotti di qualità bassa. Chi investirà in questi film? In prodotti così ambiziosi e difficili per lo spettatore?
È una terra di mezzo, che secondo me continuerà a esistere. Finché Errol Morris sarà in attività, troverà sempre una piattaforma disposta a finanziare un suo film. Wiseman è un caso a parte, se li produce lui i film. Ma c’è poco spazio anche al cinema per il documentario, sono film poco redditizi, quindi chissà in futuro. Di certo, in questo momento, le piattaforme mostrano una singolare apertura ai prodotti d’autore, concedendo anche parecchia libertà ai registi, addirittura il final cut. Intervengono poco, paradossalmente, perché se parliamo di piattaforme pensiamo subito a questi imperscrutabili algoritmi, che non si capisce poi che cosa cazzo siano davvero, no? Questa contraddizione esiste e chissà quanto durerà. Non sono pessimista, né particolarmente preoccupato da questi aggiustamenti continui. Sono al corrente, per esempio, che il prossimo anno Netflix ha in cantiere almeno quattro grandi film d’autore.
“La reazione del pubblico a ‘Under the skin’ di Glazer è stata la più scomposta che ci sia mai stata al Festival. Erano tutti incazzati neri, addirittura c’era chi insultava il regista. Poi il film è diventato di culto”.
Quindi se Von Stroheim fosse vivo oggi riuscirebbe a fare il suo Rapacità da sessantasei ore con il final cut e nessuno gli romperebbe i coglioni.
[Ride] Sì, probabilmente nessuno gli romperebbe i coglioni, certo.
Parliamo di Venezia 81, la prossima edizione della Mostra. A livello tematico, molti film nelle diverse sezioni sembrano caratterizzati da un tentativo di riflettere sul presente, sul cambiamento climatico, sulle guerre (da diverse prospettive), su vecchi e nuovi tiranni. Poi ci sono molti autori giovani, soprattutto nel concorso principale, come se nell’ultima fase del tuo mandato volessi lavorare sul futuro. C’è Brady Corbet, ad esempio, che qui aveva presentato il molto promettente The Childhood of a Leader.
Questo nuovo film di Corbet è pazzesco, vedrai. Tre ore e trentacinque, in 70mm, una storia incredibile.
Quali sono i criteri che hanno orientato la selezione di quest’anno?
Ci sono dodici film di autori che non sono mai stati in concorso a Venezia, tra cui un film di Singapore, quello di Siew Hua Yeo, un film di un regista argentino, Ortega, molto bravo però conosciuto solo all’interno del circuito dei festival, Love di Dag Johan Haugerud, e poi Dea Kulumbegashvili, che qualche anno fa ha diretto Beginning.
Beginning ottimo esordio.
Ottimo, sì. Questo suo nuovo film è bellissimo, molto duro, radicale da tutti i punti di vista e soprattutto da quello formale. Lei lavora molto sui fuori campo, sui piani di sequenza, sulle soggettive. Veramente un lavoro notevole. Poi c’è Maura Delpero. Il suo primo film era interessante ma non completamente riuscito, questo invece è sorprendente.
Non l’ho visto.
Nel 2018 noi non lo avevamo preso, poi ha vinto Locarno, però mi era sembrato un po’ sopravvalutato. Questo invece è un film folgorante, un film che recupera integralmente la lezione di Olmi, applicandola a una vicenda ambientata in un villaggio di montagna a cavallo tra la fine della Seconda guerra mondiale e il dopoguerra.
Difficile confrontarsi con il cinema di Olmi, lavorare seguendo quel solco.
Difficilissimo, davvero. Lei ci è riuscita, con una maestria e una maturità davvero impressionanti.
“Ricordo una cena in un albergo di Hong Kong, una tavolata con la nouvelle vague del Paese riunita: John Woo, Stanley Kwan, Clara Law, Wong Kar-wai, Kirk Wong. A Teheran, in un bar, abbiamo fatto amicizia con Kiarostami. I più grandi registi di quegli anni li incontravi con facilità”.
Quindi i film più attesi? Le sorprese per te quali saranno quest’anno?
Come dicevo, Corbet è una bomba. Todd Phillips, con il secondo capitolo di Joker, è stupefacente. L’ho visto a febbraio a Los Angeles: alla fine del film stavo così, a bocca aperta, giuro! E poi Luca Guadagnino con Queer, che è il suo film più bello. Daniel Craig mai così bravo, impressionante, la performance della vita. Io ho visto due versioni del film, quella che proietteremo è la terza, più breve, dura due ore e un quarto. La prima era di tre ore e venti, la seconda di due ore e mezza. E un po’ mi spiace, perché so cosa ha tagliato: tutto il peregrinare di Craig nei locali gay di Città del Messico all’inizio degli anni Cinquanta, con questa fauna incredibile di omosessuali in cerca di avventure. Spero che prima o poi Guadagnino faccia il director’s cut perché ci sono delle cose bellissime.
Guadagnino adora Friedkin, impossibile non pensare a Cruising, anche lì con tutte le parti, tagliate perché molto esplicite, delle peregrinazioni nei locali gay del protagonista.
In Guadagnino c’è molta più ironia, maggior distacco rispetto al coinvolgimento di Cruising. Mi spiace molto che quella parte di Queer sia stata sfoltita perché era tutt’altro che inessenziale alla vicenda e alla costruzione del personaggio.
Magari tra qualche anno noi siamo qua a Venezia a vedere la versione integrale.
Eh, magari sì, lo spero.

Una scena di “Queer” di Luca Guadagnino.
Altri?
Sorprendente questo regista singaporegno, Siew Hua Yeo. Il suo esordio aveva vinto a Locarno, nel 2018. Questo è un film modernissimo, ma che nello stesso tempo riprende Hitchcock, La finestra sul cortile: è un film sul controllo sociale, sullo sguardo, sulla visione. Bello Harvest di Athina Tsangari, che dura due ore e mezza ed è girato in sedici millimetri, con una grana sporchissima. È una ricostruzione meticolosa della vita in un villaggio rurale, sperduto nella campagna inglese, alla fine del Cinquecento. Film molto duro anche questo.
Walter Salles?
Salles ha fatto il suo film più bello. Un film politico, largamente autobiografico, perché lui era amico della famiglia di questo deputato socialista arrestato e fatto scomparire dalla giunta militare brasiliana. Lui abitava nella casa di fianco e frequentava i figli di questo deputato. Il film è veramente emozionante.
Seguendo la conferenza stampa di presentazione, ho esultato per il ritorno di Takeshi Kitano, ma non ho capito nulla del film, sei stato molto evasivo, ellittico.
Non ho detto niente apposta, è una sorpresa. Film metacinematografico, sessantacinque minuti di assoluto divertimento.
Quali sono stati i momenti più difficili da direttore della Mostra? Inizio io: 2019, in concorso c’è Roman Polanski e la regista argentina Lucrecia Martel, che è Presidente di Giuria, dice che non avrebbe presenziato in sala alla prima per protesta, auspicandosi anche l’introduzione di quote rosa che garantissero almeno il 50% di donne nelle sezioni della Mostra. Dichiarazioni che scatenarono molte polemiche.
Lucrecia Martel fece un errore di comunicazione. Durante la conferenza stampa di apertura una giornalista le chiese come pensava di poter gestire la giuria di un concorso che vedeva presente anche J’Accuse, il film di Roman Polanski. E lei, invece di limitarsi a dire qualcosa di sintetico del tipo “Io giudico i film, non l’artista” si mise a fare un lungo discorso, molto articolato, elaborando il suo punto di vista che però nessuno capì fino in fondo e che fu riassunto dalla stampa con una formula giornalistica molto semplificatoria: “Se c’è Polanski, io non vado in sala”. Cosa che lei però non aveva mai detto. Disse, invece, che avrebbe giudicato il film senza pregiudizi, ma che se l’avessero invitata a una cena o a un ricevimento con Polanski, ci avrebbe pensato due volte, dato che con l’uomo, vista la sua storia, non voleva avere nulla a che fare.
In effetti i giornali ci hanno consegnato una versione diversa della storia che tu mi racconti.
Ma certo, perché poi la maggior parte della stampa, le agenzie che hanno scritto? “Lucrecia Martel non vedrà il film di Polanski e non presenzierà in sala”. Io corsi subito da Lucrecia Martel nella sua stanza, dove si stava provando il vestito per la cerimonia di apertura, per chiederle di fare un comunicato che risolvesse il fraintendimento. Però nessuno ha poi ripreso il comunicato, capisci? Per cui è rimasta come valida questa versione distorta della storia. Che è successo alla fine? Che la giuria presieduta da Lucrecia Martel ha dato a Polanski il premio per la miglior regia, a dimostrazione del fatto che lei nei confronti del film non aveva nessuna preclusione e anzi ha votato con convinzione per assegnargli il premio.

Alberto Barbera con Woody Allen e Soon-yi Previn.
Altri momenti complicati?
L’anno scorso, quando c’erano in concorso Polanski, Woody Allen e Luc Besson, una giornalista di settore aveva scritto che ero un insopportabile esempio di maschio tossico e che andavo cacciato perché avevo detto, appunto, che non stava a me esprimere sentenze in merito ai comportamenti più o meno legittimi di una persona, essendo io il direttore di un festival chiamato a giudicare il valore estetico di un film e a distinguere tra uomo e opera. Fu un momento complicato, perché era la prima volta che si chiedevano esplicitamente le mie dimissioni. Sono stato criticato anche in passato per certe scelte – cinematografiche, di selezione – ma sempre in un clima di confronto costruttivo con la stampa. Però sai, è anche naturale che la maggior parte delle domande e delle interviste iniziali vertesse su quella questione, essendo addirittura tre i registi dai comportamenti controversi presenti in Mostra. Poi l’anno più difficile in assoluto è stato l’anno del COVID; fino all’ultimo non sapevamo se il festival si sarebbe tenuto o meno, tutti gli altri festival erano stati obbligati a rinunciare. Attorno al 20 giugno abbiamo deciso di farlo, io, Baratta e Del Mercato, senza avere certezze di alcun tipo, scommettendo sul fatto che i contagi sarebbero diminuiti in estate. Alla fine è andata bene.
“La prima versione di ‘Queer’ era di tre ore e venti, questa dura due ore e un quarto. E un po’ mi spiace. Spero che prima o poi Guadagnino faccia il director’s cut perché ci sono delle cose bellissime”.
Immagino sarai molto legato a quella edizione.
Sì, è stata un’edizione memorabile, un’emozione senza precedenti per tutti quelli che hanno partecipato, che all’inizio erano anche spaventati. Dicevano “Ma avremo fatto bene? E se poi ci ammaliamo?” Dopo un paio di giorni si erano tranquillizzati e alla fine erano felicissimi di aver preso parte a un’edizione storica.
L’anno scorso c’è stato anche lo sciopero degli attori di Hollywood.
Sì, il film di apertura avrebbe dovuto essere Challengers di Guadagnino, ma poi è partito lo sciopero. Amazon mi chiama per dirmi che aveva deciso di ritirare il film perché senza Zendaya, che era in sciopero, non se la sentivano di portarlo. Quella è stata una settimana infernale, con Guadagnino incazzato come una iena, a litigare con quelli di Amazon perché ci teneva molto a venire a Venezia. Io pure, furibondo, sempre al telefono con Los Angeles a dirgli che non potevano fare questa cosa, che erano gli unici a non venire, che anche se non c’era Zendaya vabbè, amen, il film se lo sarebbero visto tutti comunque, tutti ne avrebbero parlato, la promozione sarebbe stata garantita. Alla fine, dopo una settimana di interlocuzione violentissima, arriva la telefonata che conferma che no, il film non sarebbe stato presentato qui. Sono stato malissimo, perché era proprio il film perfetto per l’apertura, entusiasmante, trascinante.
Guadagnino ci sarà rimasto malissimo…
Sai, per lui era l’occasione di aprire la Mostra di Venezia, uno dei sogni della sua vita… Però quest’anno è in concorso con un film che è ancora più bello.
Il rapporto tra Mostra e cinema italiano è stato ed è, spesso, complicato. Ci sono state in passato grandi polemiche sulla presenza italiana, sui premi non assegnati, risate e stroncature (ad esempio: Nessuna qualità agli eroi di Franchi). Ricordo Marina Cicogna dire che “Non sappiamo fare lobby, i francesi invece sì”, e l’ex Ministro della Cultura Bondi lamentarsi dei mancati premi agli italiani. La Mostra fa riscoprire nazionalismi e orgogli patriottici latenti. Come è il rapporto oggi tra Mostra e cinema italiano?
Il rapporto tra cinema italiano e Mostra mi sembra molto migliorato negli ultimi anni. Le polemiche gratuite sono scese a zero o quasi, tutt’al più i giornali segnalano i mancati premi ai film italiani, più per dovere patriottico che per reale convincimento. Credo che sia merito della credibilità e dell’indipendenza delle scelte di selezione, il non essersi mai piegati a logiche di parte o spartitorie, fatte col manuale Cencelli per accontentare un po’ tutti, produttori e distributori. Ho sempre difeso il cinema italiano, ma solo quando ne valeva la pena, denunciando storture e problemi quando esistevano, senza reticenze. Mi sono attirato critiche, ma credo anche di essermi guadagnato rispetto.
Quali sono oggi per te le cinematografie più interessanti? Rispetto a qualche anno fa, mi pare più difficile indicare con chiarezza un’area geografica-culturale più interessante di altre.
Sì, è così, gli equilibri sono cambiati, orientarsi è più difficile. Il cinema cinese soffre, il clima politico è soffocante lì, anche nell’est Europa c’è poca roba. Forse il cinema maghrebino è il più vivace e interessante oggi.
“L’anno più difficile in assoluto è stato l’anno del COVID; fino all’ultimo non sapevamo se il festival si sarebbe tenuto. Alla fine è stata un’edizione storica, memorabile”.
Tu hai proprio il vizio delle recensioni. Oltre ai film, so che sei un appassionato critico su Tripadvisor: non c’è ristorante del Lido che tu non abbia recensito.
Adesso un po’ meno, però una volta mi piaceva recensire i ristoranti. Quando sono in un posto nuovo e non so dove mangiare, leggo le recensioni online e scopro che spesso sono farlocche o poco attendibili. Vai a mangiare in un posto con recensioni strepitose, poi ti rendi conto che le hanno scritte gli amici del titolare, oppure semplicemente gente che non ha gusto, che si accontenta di poco. Se vado in un ristorante buono voglio dirlo, stessa cosa se trovo un ristorante sopravvalutato o che non mi piace. Adesso non le scrivo più perché non ho più tempo, non ho più voglia, ma c’è stato un periodo in cui lo facevo spesso.
Prima volta alla Mostra di un critico o di un appassionato di cinema: dove lo mandi a mangiare?
Purtroppo ha chiuso La Favorita, dove si mangiava veramente bene. Adesso ci sono due o tre ristoranti decisamente buoni. Uno è Da Enzo, ha aperto quest’anno, ha rilevato l’ex trattoria Africa, l’ha ristrutturata e si mangia benissimo. Solo pesce freschissimo, cucinato molto bene. Anche Valentino è buono, ma ha un difetto: sono molto lenti. Chi va, deve mettere in conto che ci passerà almeno tre ore. E poi c’è Andri, un classico da sempre, frequentatissimo anche in passato dalla gente del cinema.
Un film che avresti voluto assolutamente alla Mostra ma che non sei riuscito ad avere?
Megalopolis. Con Coppola ci siamo scambiati e-mail continue per almeno un paio di settimane e alla fine sembrava convinto di venire a Venezia. Poi hanno pesato varie considerazioni a favore di Cannes: la malattia della moglie, la volontà di sottrarsi allo stillicidio di pareri negativi sul film che filtravano dalla proiezione tenuta a Los Angeles per 200 persone (un grave errore quello). Peccato!
newsletter
Le vite degli altri
Le vite degli altri è una newsletter che racconta di vite che non sono la nostra: vite straordinarie, bizzarre o comunque interessanti.
La scriviamo noi della redazione di Lucy e arriva nella tua mail la domenica, prima di pranzo o dopo il secondo caffè – dipende dalle tue abitudini.
Contenuti correlati