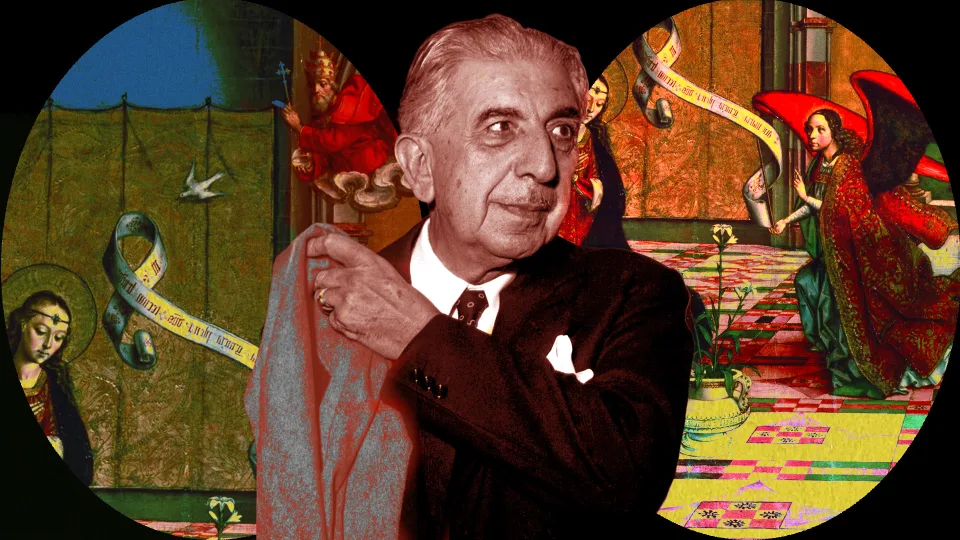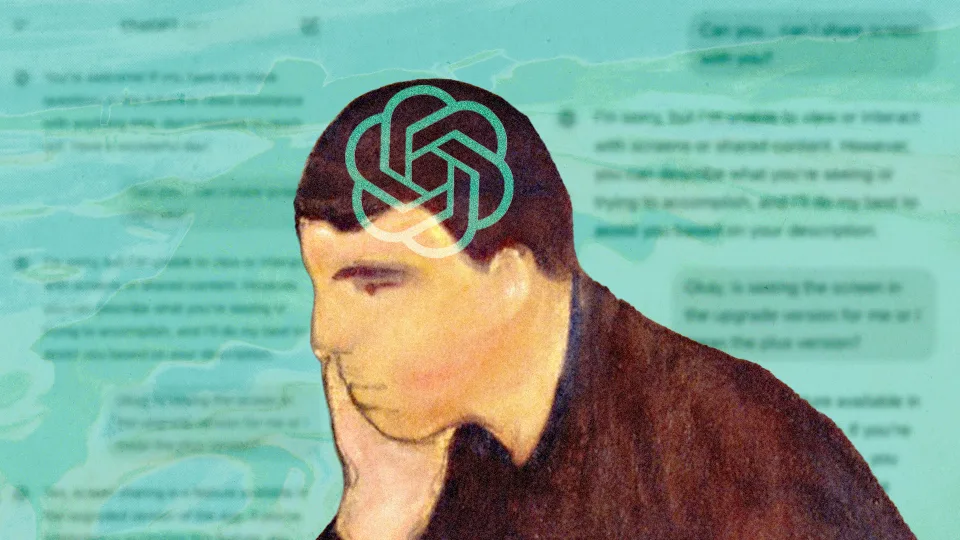Ha vissuto molto in Italia, ama Primo Levi e Natalia Ginzburg, ha rischiato di morire in Ucraina. Qui, lo scrittore colombiano racconta la sua vita e la sua opera, entrambe non banali.
Héctor Abad Faciolince è una delle voci più rilevanti della letteratura latino-americana contemporanea. Colombiano, ha vissuto la maggior parte della sua vita all’estero, senza mai recidere il legame con la propria terra. E terra, in Colombia, non è metafora di altro: quando un colombiano dice mi tierra ha in mente le vallate verdi e rigogliose dove piove spesso e altrettanto spesso batte il sole, dove banani, bambù e alberi da frutto di ogni forma e colore si confondono, lasciando alla città il permesso di esistere. La scrittura di Abad Faciolince è frutto di intrecci: la memoria intima e la storia pubblica si affrontano e si confrontano, e l’una sbiadisce nell’altra, o nell’altra si rivela.
Il suo libro più noto è El olvido que seremos (L’oblio che saremo, Einaudi), un doloroso memoir sulla figura del padre, Héctor Abad Gómez – medico, professore e attivista per i diritti umani – assassinato nel 1987 a Medellín dalle milizie paramilitari. Il romanzo è diventato un caso editoriale in tutta l’America Latina ed è stato adattato per il cinema nel 2020 dal regista Fernando Trueba.
Faciolince ha vissuto a lungo in Italia: prima a Torino, dove ha studiato Lettere, poi a Verona, dove ha insegnato all’università. In quegli anni si è avvicinato con passione alla lingua e alla letteratura italiana anche grazie a una pratica affettuosa e clandestina: traduceva piratescamente Calvino, Eco, Ginzburg e altri autori italiani per una rivista letteraria distribuita a Città del Messico. Nel giugno 2023 è sopravvissuto a un attacco missilistico russo in Ucraina, in cui ha perso la vita la scrittrice ucraina Victoria Amelina.
Ci diamo appuntamento in un caffè dall’aria parigina, storico punto di incontro della borghesia di Medellin, sua città natale. Durante la nostra conversazione italiano e spagnolo si sono dati il cambio, permettendo che prevalesse, di volta in volta, la lingua più adatta allo scopo. Abbiamo parlato di Italia, di ex-futuri, di scrittura e di morte.
Ha vissuto in molti luoghi. Vorrei sapere delle sue geografie biografiche, emotive, letterarie.
Ho vissuto in Germania, in Messico, ho passato un periodo negli Stati Uniti e un altro in Olanda, ora vivo metà del tempo in Spagna e l’altra metà in Colombia. Ma l’altrove in cui ho vissuto più a lungo è stato l’Italia.
E che influenza ha avuto l’Italia sullo scrittore che è diventato?
Posso dividere i miei nove anni in Italia in due fasi. Durante la prima fase ero uno studente, vivevo con la mia fidanzata. A Torino ho passato gli anni più felici della mia vita, quelli della mia educazione intellettuale e sentimentale. Vivevamo nella casa di una rivoluzionaria italiana che si era trasferita a Cuba per ragioni politiche. Dopo la laurea sono tornato in Colombia. Era l’inizio del 1987. Qualche mese dopo, mio padre è stato assassinato. Tornai in Italia e iniziò una fase di segno opposto: gli anni più cupi della mia esistenza. Mi portavo addosso un’infelicità profonda che avvolgeva tutto. Ma i ricordi si annacquano ed è difficile ricostruire i fatti della vita.
Nei suoi romanzi lo fa.
Scrivendo è molto più facile. Ho avuto un rapporto così intimo con l’Italia che, a un certo punto, lo spagnolo – la mia lingua madre, quella che insegnavo all’università di Verona – iniziò a risentirne. Parlavo male la mia stessa lingua, e questo mi mise profondamente in imbarazzo.
Che Italia era quella che le tolse la sua lingua?
Era l’Italia degli anni Ottanta: usciva dagli anni del terrorismo e recuperava i valori democratici e liberali. C’era una grande effervescenza e fiducia nel futuro. Il MSI, i cui eredi oggi sono al governo, era un partito considerato esecrabile. Gli anni dell’avvento di Berlusconi coincisero con quelli della mia infelicità, della mia vergognosa dimenticanza dello spagnolo e dello smembramento della mia famiglia e allora misi insieme tutto: i miei dolori personali e la volgarizzazione politica e culturale che era in atto. Si apriva il tempo di un’Italia rozza, un’Italia mascalzona [in italiano n.d.r.]. Allora provai, per l’Italia, rabbia e vergogna.
Nel suo libro Traiciones de la memoria parla di ex futuri: quello che avrebbe potuto essere e non è stato. Invecchiare in Italia è un suo ex futuro?
Sì, diventare italiano è un mio ex futuro. Come Stendhal che sulla sua tomba fece scrivere: “Arrigo Beyle – Milanese – Scrisse – Amò – Visse”. Eppure scrisse sempre in francese. È molto difficile per uno scrittore rompere con la lingua dell’infanzia. Quando mi sono accorto che l’italiano non riusciva a restituire l’energia del mio lessico famigliare, ho capito che in Italia non avrei potuto essere uno scrittore. Dovevo tornare in Colombia. Riuscivo a essere italiano per dieci minuti, perfettamente. Dopo dieci minuti, qualcosa si inceppava, o nella lingua o nel passato: i riferimenti culturali, i programmi televisivi dell’infanzia mi smascheravano. Non è nemmeno una questione di italiano o spagnolo. La propria lingua è qualcosa di storicamente e geograficamente circoscritto: è quella della propria città, del proprio liceo. Io, con un argentino, con un cileno non mi capirò mai fino in fondo. Quando uno aspira a scrivere con una certa carica e intensità deve attingere alla lingua della gioventù. E questo malgrado io rifiutassi il Paese della mia giovinezza, la Colombia. Non ho nemmeno un amico scrittore a Medellin. Ho amici ingegneri, architetti… ma non scrittori.
Soffre di questo spatriamento?
Beh, un Paese ci vuole. Nell’Italia di Berlusconi mi sono sentito spaesato e ripudiato [in italiano n.d.r.]. Per fare un esempio: in Italia non sono mai riuscito a trovare un editore – per così dire – fisso, per ogni nuovo libro un nuovo editore.
Parliamo di Einaudi e del microcosmo intellettuale che ha nutrito. È l’editore con cui ha pubblicato il suo libro più celebre, L’oblio che saremo, dove racconta del rapporto con suo padre.
È la casa editrice degli autori che amo. Amo profondamente Primo Levi, Natalia Ginzburg, Italo Calvino, ma non riesco a dimenticare che fu Ginzburg [dopo il parere negativo di Cesare Pavese, e riconoscendo poi l’errore anni dopo n.d.r.] a rifiutare Se questo è un uomo. E allora mi dico: questa scrittrice che amo fece un gesto difficile da spiegare. Forse anche le persone migliori non riescono a non provare invidia quando si trovano davanti un’opera grande. Ginzburg aveva perso il marito Leone a causa dei nazifascisti, e a partire da quella esperienza aveva scritto una poesia bellissima. Una poesia, non un grande libro. Invece questo signore, Primo Levi, che non era neanche uno scrittore, ma un chimico, aveva scritto un libro antiletterario, al grado zero della letterarietà, e lei forse non riuscì ad ammettere la forza di quell’opera.
Le piace la lingua italiana?
Adesso l’italiano l’ho quasi dimenticato, non lo parlo da trent’anni.
Lo parla perfettamente.
Amo l’italiano. Ho letto di più in italiano che in spagnolo, soprattutto le traduzioni. Perché in spagnolo i traduttori erano spagnoli o argentini, dunque quella tradotta non era propriamente la mia lingua. Ho letto in italiano i tedeschi, i russi, gli americani.
Quali opere della letteratura italiana l’hanno influenzato?
Io ho capito come potevo scrivere L’oblio che saremo grazie ad alcuni libri per me fondamentali. Con Se questo è un uomo ho capito che si può scrivere un libro che sia potente come un romanzo a partire da un’esperienza tragica, reale. Grazie a Lessico famigliare ho invece capito che puoi scrivere nella lingua di casa tua, puoi scrivere come parlano le tue sorelle, i tuoi genitori seduti a tavola. E poi come Ginzburg, anche io parlavo poco da bambino, mentre le mie sorelle parlavano moltissimo, non mi lasciavano finire una frase…
Torniamo alla sua giovinezza torinese. Fece incontri importanti.
Gliene racconto uno. In quel periodo infelice, dopo la morte di mio padre, ho avuto una professoressa molto amata: Lore Terracini. Un giorno mi portò a casa di Norberto Bobbio, suo amico. A un certo punto lui disse: “Andiamo, devo passare in centro” – credo in via Biancamano, all’Einaudi. Prendemmo l’autobus, e mi pagò il biglietto. Io cercai di oppormi, ma lui ridendo mi disse: “Un senatore può permettersi di offrire il biglietto a un ragazzo.” Lo ringraziai e dissi: “Il giorno in cui i senatori colombiani prenderanno l’autobus, vorrà dire che la Colombia è diventata un paese civile.” Quel giorno non è ancora arrivato. E forse nemmeno in Italia i senatori prendono più l’autobus. [ride, n.d.r.]
Lei ha scritto: “Quelli che i guelfi accusano di essere ghibellini e i ghibellini accusano di essere guelfi, sono proprio quelli che hanno ragione”. Mi ha fatto pensare all’atteggiamento eretico di Pasolini, e anche a quello di suo padre, Héctor Abad Gómez.
Esattamente. Mio padre era attaccato da tutti i fronti. Per l’estrema sinistra, il suo impegno a difesa dei valori liberali e democratici era visto come “borghese”. Agli occhi della destra, il fatto che si battesse a fianco delle vittime della violenza politica – spesso militanti di sinistra – lo faceva apparire come un alleato dei guerriglieri. Ma la Colombia è un paese violento. La quantità di storie legate a sequestri e omicidi che ogni colombiano ha in famiglia è impressionante. A un certo punto si contarono 40 mila sequestri. Mia moglie mi raccontava che il fratello, da bambino, durante il novantesimo compleanno del nonno disse: “Che fortunato il nonno, non l’hanno ancora ucciso!”
Che rapporto ha con la morte?
Per molto tempo ho pensato che mi sarebbe piaciuto morire con la consapevolezza che stavo morendo.. Ma in Ucraina, nel 2023, ho rischiato davvero di morire a causa di un missile russo. Davanti a me è morta Victoria Amelina, una scrittrice che stava documentando i crimini di guerra russi. Da allora sono impegnato nella scrittura di un libro sulla morte, un libro ossessivo. E sono arrivato a una conclusione molto semplice: non voglio morire da martire o da eroe, come mio padre. Voglio avere la morte che lui stesso considerava l’unica accettabile: quella per vecchiaia.
È andato in Ucraina con la consapevolezza che poteva morire?
No, non sono andato per fare l’eroe, è successo per caso. successo per caso. Anzi, per mancanza di carattere.
Cioè?
Dovevo andare a Kiev per presentare la traduzione ucraina de L’oblio che saremo. Ma mi dissero che dovevamo avvicinarci al fronte per vedere davvero com’era la guerra. Io dissi: “No, non posso. Ho già il volo prenotato, costerebbe troppo cambiarlo, non posso venire. Mi dispiace, andate voi.” Ma insistendo, mi convinsero. E poi: un tetto che crolla distrutto da un missile russo e una persona ti muore davanti.
Crede invece che suo padre sapesse che rischiava la vita?
Quando lo hanno ucciso aveva in tasca due cose: una poesia sulla morte e sull’oblio, e la lista dei nomi che i paramilitari volevano eliminare. C’era anche il suo. Avrebbe potuto allontanarsi, rifugiarsi dai suoi cugini a Cartagena. Non lo fece.
In questo siete diversi?
Sì. Lui era un attivista, si candidò a sindaco di Medellin. Io non vorrei mai essere candidato per nessuna carica. Nutro un’ideologia del dubbio. Non so chi abbia ragione e chi abbia torto, è troppo difficile stabilirlo.
È un cinico o un entusiasta?
L’entusiasmo, quando fallisce, quando si scontra con la realtà, porta al cinismo. Ma l’entusiasmo rinasce e si scontra di nuovo con la realtà. Dopo molti scontri, il rifugio del cinismo diventa una tentazione. Ma cerco di evitarla, questa tentazione.
È felice quando scrive?
Mi piace la disciplina settimanale che ti dà la scrittura giornalistica. Io, che tendo a isolarmi dalla realtà, vengo costretto a poggiare i piedi per terra. E poi scrivere per un giornale ti obbliga all’umiltà. Se hai una scadenza, devi consegnare l’articolo, che tu sia soddisfatto o meno.
“Forse anche le persone migliori non riescono a non provare invidia quando si trovano davanti un’opera grande. Ginzburg aveva perso il marito Leone a causa dei nazifascisti, e a partire da quella esperienza aveva scritto una poesia bellissima”.
Un amico giornalista un giorno mi ha detto: “scrivere è umiliante”.
[Ride n.d.r.] Il suo amico ha ragione. È umiliante soprattutto quando ti confronti con gli scrittori a cui vorresti assomigliare o con l’idea di scrittura che hai in mente. Quando scrivi una pagina di cui non ti vergogni, dalla quale non ti senti umiliato, allora provi una specie di soddisfazione. Ma non è una grande felicità perché ti rendi conto che è eccezionale riuscire a scrivere una buona pagina. È letteralmente un’eccezione, qualcosa che dipende molto anche dal caso. A volte a partire dalla prima frase hai trovato il tono giusto e questo ti ha permesso di arrivare alla fine della pagina. Ma trovare questo tono equivale a mescolare le parole come fossero le carte in un mazzo e infine sceglierne una. Che sia quella giusta è un fatto eccezionale. Scrivere porta sempre con sé un rischio: è come suonare una piccola sonata per pianoforte piena di note false, o cantare una canzone e stonare terribilmente alla seconda frase. Ogni volta che scrivi un libro ricominci da capo. Ogni volta ti senti un apprendista: devi imparare a scrivere quello specifico romanzo, a meno che tu non sia il tipo di scrittore che per tutta la vita scrive varianti dello stesso libro.
Quando scrive, attinge alla sua storia o alla fantasia?
In questo momento sto scrivendo un libro a partire da quello che mi è accaduto in Ucraina. Ho sentito che non potevo farne una cronaca e tantomeno un romanzo. Allora ho iniziato a scrivere entrambe le cose, la cronaca e il romanzo, per vedere quale delle due si imponeva. Chiamiamo F la finzione e R la realtà. Pare che nessuna delle due si sia imposta, si stanno invece dando il cambio, un capitolo per una.
Ha paura di esporre chi ama, nei suoi romanzi?
Se hai paura sei fottuto. Certo, qualcuno ogni tanto si offende. Ma la verità ha sempre qualcosa di crudele, qualcosa di molto crudele.
Anche la letteratura?
La verità della letteratura è che , se vuole essere autentica, deve fare i conti con la realtà. Altrimenti è una cosa di poco conto.