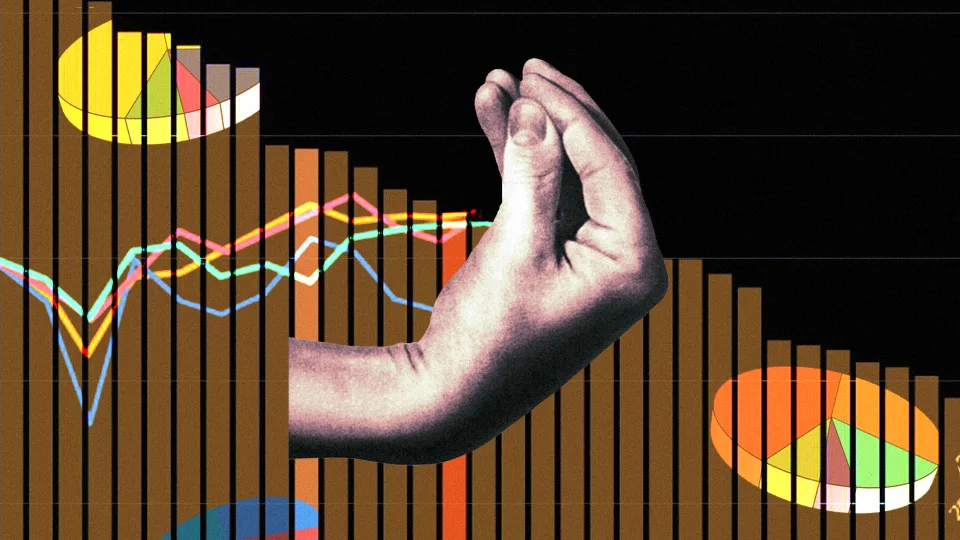Ogni anno Sanremo monopolizza la nostra attenzione. Tra polemiche, contestazioni, dichiarazioni improvvide, discorsi sul mercato musicale, PR, per giorni e giorni non si parla d’altro. Manca però una cosa a questa lista, la musica, che forse al Festival della canzone italiana è la cosa meno importante.
Quest’anno, per la prima volta da quando raccontare la musica è diventato il mio mestiere, non seguirò per lavoro il Festival di Sanremo.
Quello che voglio dire è che non solo non sarò in Liguria ma non dedicherò neppure a distanza articoli o speciali radiofonici alla settantaquattresima edizione della competizione musicale più importante del Paese. Negli anni, come molti colleghi, ho fatto di tutto intorno a Sanremo in quei cinque giorni di febbraio.
Ho raggiunto il massimo del delirio sanremese l’anno in cui ho partecipato al Dopofestival, che, come suggerisce il nome, va in onda subito dopo la diretta. Dopo aver attraversato una Sanremo deserta – in quei giorni, sono tutti chiusi nelle case coi televisori accesi o seduti a teatro con ori e paillettes in bella vista – ho atteso l’inizio della trasmissione di cui sarei stata ospite fuori dal Casinò, seduta su una panchina accanto a una scultura che effigia Lucio Dalla, stremata dai miei stessi sbadigli e dallo show appena concluso.
Alla fine della trasmissione, dopo aver visto coi miei occhi e ascoltato con le mie orecchie Francesco Renga sostenere assurde teorie circa le innate scarse doti vocali delle donne rispetto ai colleghi uomini, ancora in abito da sera nero, ho abbandonato il bombardamento di toponomastica musicale dei bar del centro (il mio preferito è il Bar Melody) e ho raggiunto un amico sanremese in un locale della città vecchia a una serata drum’n’bass per poi, dopo aver ballato in stato comatoso ed essermi addormentata su una panca del locale, andare con lui e i suoi amici a dormire, sempre nel mio fido abito da Dopofestival, in una casa in ristrutturazione senza riscaldamento.
Drum’n’bass a parte, a me andare a Sanremo e trascorrere lì quella settimana non è mai piaciuto granché. La prima volta che ci ho messo piede mi è stato immediatamente chiaro: appena scesa dal treno, sono stata braccata da un karaokista di strada fuori da una catena di supermercati per cantare una vecchia canzone di Francesca Alotta, dopo due ore di permanenza la città ha iniziato a ricordarmi una Las Vegas da luna park della Bassa o un paese della Lomellina nei giorni di Carnevale – che però, rispetto a Sanremo durante il festival, ha comunque più grazia e più understatement.
La musica italiana, anche quella passata dai palchi sanremesi, è il mio pane, il mio più antico spazio di ricerca e di lavoro eppure, anche quando ero più giovane, a differenza di altri colleghi, non ho mai avuto la sensazione che essere presente a Sanremo potesse rappresentare una qualche forma di vera consacrazione, un punto di arrivo dorato in grado di sancire che dunque sì, la musica era diventata il mio lavoro; ho ben presto, anzi, realizzato di sposare in toto il sentire di Dino Buzzati che in un suo noto elzeviro per il «Corriere della Sera» del 1963, pur affascinato dal Festival al punto da decidere di scriverne, sostiene che tutto il baraccone sanremese gli evochi una certa decadenza.

Nel pezzo paragona la kermesse alle fiere campionarie degli anni trenta, con gli stand di chi vendeva dentifrici, sul luogo del Festival avverte insomma un’aria che definisce risaputa e stanca, coi fiori (i famosi fiori di Sanremo!) che addirittura gli paiono finti mentre le dive, i divi, i cantanti e le cantanti gli sembrano coperti di polvere. Continua:
[…] non riconosco più, sul posto, quel fenomeno di ingenua, stupida forse, ma strapotente vita, l’illusione, l’esaltazione lirica. Manca il senso di gioco, di sospensione, di scoperta, di rivelazione, che in anni passati usciva, innegabilmente, dai convessi vetri dei televisori domestici.
A mancargli sono, dice, la bellezza, l’incantamento e quel senso di poesia e pathos che fa parte del Festival ma non va cercato in loco, lì dove il Festival vive e origina, in una città che lo scrittore e artista non esita a definire ridente, quieta, ospitale, verde, ricca e riposante come un “fatato cimitero in anteprima” ma nelle case degli italiani, nella dislocazione della provincia apparentemente priva di incanto dove invece la sensazione dell’incanto si coltiva:
“[…] dovevo andarla a cercare nella cantoniera della Val Padana assediata dalle nebbie, nei due locali più servizi alla periferia di Ancona dove si è appena sistemata la coppia di sposini, nel salone del diruto castello siciliano dove il settuagenario duca paralitico chiede al video un supplemento di vita continentale, nella casa parrocchiale della Gallura, il cui prevosto indulge, tre sere all’anno, alle peccaminose propensioni delle sue pecorelle. Laggiù sì, il festival può diventare una cosa grande”.
La deduzione buzzatiana, insomma, è semplice: la poesia del Festival di Sanremo può sopravvivere solo nel mondo lontano dalla città dei fiori, laddove c’è spazio per vagheggiare e dunque pure per esaltare il mito che, una volta visto da vicino, perisce insieme alla sua epica invero tutta proverbiale. Conclude dunque l’autore con un elogio leopardiano dell’immaginazione come luogo di prossimità tra l’uomo e il proprio desiderio di piacere:
“[…] ai milioni di anime semplici che sparse per l’Italia hanno seguito con trasporto il tredicesimo festival della canzone, vorrei poter dire: la vera festa è stata la vostra, la vera illusione è stata la vostra, quel po’ di poesia è stata tutta per voi. Non rimpiangete di non essere stati presenti a Sanremo. Da galantuomo ve lo garantisco, non ne valeva la pena”.
L’articolo di Buzzati è esemplare, utilizzato come materiale narrativo intorno al Festival da più punti di vista e pure, e questo è chiaro, considerato squisitamente in ottica letteraria. Ma è soprattutto significativo, io credo, questo specifico dato centrale esplicitato in chiusura: non ne vale la pena; anche io credo che la migliore forma nella quale usufruire di Sanremo sia quella aggregativa e immaginaria, costruita a debita distanza nei salotti, nella contemplazione lontana, negli appartamenti, negli inviti agli amici pieni di promesse di condivisione di un inspiegabile trasognamento collettivo che somiglia sempre più alla realizzazione di un desiderio di aggregazione e sempre meno a qualcosa che riguarda la musica.
“La città ha iniziato a ricordarmi una Las Vegas da luna park della Bassa o un paese della Lomellina nei giorni di Carnevale – che però, rispetto a Sanremo durante il festival, ha comunque più grazia e più understatement”.
In questi ultimi anni a Sanremo si è consumato qualcosa che somiglia a un paradosso: da un lato un crescente interesse per le dinamiche condivise intorno alla gara, ai look dei cantanti, a tutto quello che a Sanremo è scenico, spettacolare, notiziabile; dall’altra la percezione di un ritorno massiccio all’egemonia musicale dei brani in gara, una ritrovata centralità quasi dispotica nel discorso musicale italiano di ciò che si suona sul palco dell’Ariston.
Prima della direzione artistica di Claudio Baglioni (2018 – 2019), abbiamo assistito ad anni di scollamento tra il Festival e il reale musicale: Baglioni ha, per inclinazione naturale di musicista, riportato cioè la musica (pop, s’intende) reale al centro del discorso sanremese e Amadeus ha poi raccolto questa eredità proseguendo nel medesimo solco e cercando, edizione dopo edizione in misura sempre maggiore, di televisivizzare e socializzare il tutto ulteriormente, confezionando lo spettacolo, intorno alle canzoni.
Negli anni dello sfaldamento della scena indipendente – vale a dire dell’annientamento supremo delle alternative – , anni in cui il pensiero di un mercato musicale indipendente, di un campo da gioco altro rispetto al mainstream, sembra diventato fantasia visionaria da rivoluzionari mancati, sognatori perduti in qualche circolo ARCI di cui non si è rinnovata la tessera, Sanremo è tornato a sembrare il tutto musicale, la forza centripeta della musica italiana, arrivando a definire i sì e i no dell’unico mercato musicale italiano possibile.
Se, da musicista, cantante, autore, pensi di poter ottenere un certo riscontro in quel mercato senza partecipare al Festival vieni percepito come un illuso, una pecora nera o uno degli Inti Illimani. Improvvisamente, dopo molti anni, soprattutto nelle ultime sei edizioni, essere a Sanremo sembra però essere diventato non solo necessario ma, più che utile, pericolosamente cool. E come si fa a essere cool se non si è cantanti e non si può essere presenti al Festival? Si rende cool la visione di quel festival, ci si aggrega al carrozzone e tra un salottino per influencer e l’altro per commentare tutto il commentabile se ne scrive ovunque, si tenta di rendere nobile anche sulla (rara) stampa di qualità qualcosa che nobile non è assottigliando sempre di più il confine fondamentale tra la figura del cronista musicale e del critico, in altre parole, il confine tra chi si limita a riportare cosa succede e ha successo e chi fa approfondimento e scopre, solleva coperchi, gioca a predire il futuro sonoro.
In un tempo storico in cui il massimo desiderio collettivo sembra essere quello di esprimere la propria opinione sempre e comunque, il Festival di Sanremo diventa il campo da gioco perfetto per farlo selvaggiamente tutti quanti per una settimana intera, con in più l’aggravante di una percezione di inoffensività: in fondo il Festival non è guerra, non è salute, non è nemmeno, apparentemente, politica, insomma, a straparlarne per qualche giorno, pare, non si fa male a nessuno.

Sanremo ha sempre subito colpi e contraccolpi nel suo procedere a volte come protagonista, altre come corpo morto che si trascina edizione dopo edizione con la forza dell’inerzia. Dopo i fasti dei primi anni ‘60, per esempio, dopo il ‘68 e nei primi Settanta il Festival smette di fare opinione, tanto che nel 1973 la Rai decide addirittura di mandare in onda esclusivamente la serata finale, qualcosa di impensabile tanto nel decennio precedente quanto oggi. Il rito collettivo sembra sfaldarsi, le persone non cantano più le canzoni a memoria dopo poche ore e cercano altri modi di infatuarsi collettivamente.
Qualche anno dopo, però, arriva il riflusso e dunque Sanremo decide di svecchiarsi: ecco Anna Oxa che balla vestita da cabaret punk, Enzo Carella con le ragazze sandwich in calzamaglia dorata, e poi l’eros, il non sense, la febbre del sabato sera all’italiana per cercare di riconquistare i giovani rendendosi però un campo che ospita porzioni di innovazione più che un luogo in qualche forma in sé generativo di novità.
Come ogni fenomeno di lunga storia, dunque, esistono corsi e ricorsi, andate e ritorni, niente di nuovo sembra apparire mai davvero e niente che durerà per sempre può suggerirci deduzioni definitive. Tuttavia la sensazione è che a perderci davvero, un po’ più del solito, in queste ultime edizioni sia la musica e il modo in cui chi se ne occupa dovrebbe trattarla.
“E come si fa a essere cool se non si è cantanti e non si può essere presenti al Festival? Si rende cool la visione di quel festival”.
Sanremo ha sempre contemplato vaste alternative organizzate: nel 1969 Dario Fo e Franca Rame organizzarono, in parallelo alla kermesse ufficiale, il loro Controfestival a Villa Hormond (come riportato dai volantini ufficiali dell’epoca). Gli interlocutori erano da un lato gli operatori economici sanremesi, in nome di un turismo diverso da quello di élite portato avanti da anni di amministrazione della DC, con al centro uno spettacolo costoso come quello del Festival; dall’altro operai e lavoratori in genere, cui si intendeva mostrare come il Festival fosse un’imposizione generalista di falsi miti, un’arma che il padrone metteva in campo per asservire le coscienze lavoratrici cercando di far dimenticare i temi centrali della lotta per i diritti dei lavoratori, quegli stessi lavoratori sfruttati anche all’interno della macchina del Festival. Il Controfestival consistette in una serata di ‘spettacolo-pantomima’ a ingresso gratuito (contro le 20.000 lire del Casinò) dove andava in scena una parodia di cantanti, canzoni e dell’intero mondo del Festival ufficiale.
Ovviamente stiamo parlando qui di un’alternativa culturale simbolica più che artistica in ottica strettamente musicale, ma senza voler passare per queste forme di incarnazione ideologica della contestazione ormai superate – benché al loro fondo semplicemente lasciate andare, basterebbe riferirsi a tutta la musica che continua esistere al di fuori dalla macchina dell’Ariston e a come Sanremo e tutto ciò che intorno a Sanremo ruota, stampa compresa, sembri invece abbracciare questa macchina annientando di fatto l’attenzione sulle alternative artistiche.

La macchina del capitale abbraccia tutto ciò che è il Festival: la discografia (da sempre) ma ora anche le persone sui loro divani tanto amati da Buzzati quanto dalla sottoscritta, invitate e inevitabilmente soggiogate dai meccanismi di partecipazione falsata in chiave social: fantasanremo, visualizzazioni, click, coinvolgimento casalingo, non più solo con televoti o giurie demoscopiche, mostrando perfettamente ciò di cui parlava Pier Paolo Pasolini quando si riferiva agli spettacoli di canzoni in tv che trasformavano le famiglie da “un nucleo di innocenti conservatori” a “un nucleo di ansiosi consumatori”.
Ecco che allora, tutti quanti, discografia, stampa in ginocchio al servizio di artisti senza arte, comuni cittadini telespettatori con canone Rai attivo convinti di essere anima realmente partecipe al risultato della gara e alla sua narrazione, aderiamo al modello, un modello unico, che non può che dire sì al carrozzone.
La musica scritta e prodotta in Italia fuori dalla macchina Sanremo negli altri trecentosessanta giorni dell’anno però, continua a esistere, in grande parte è di qualità nettamente superiore a quella prodotta in modo artificiale finalizzata al solo solo consumo che parte dal palco dell’Ariston per propagarsi nei mesi a venire come editto radiofonico.
“Il rito collettivo sembra sfaldarsi, le persone non cantano più le canzoni a memoria dopo poche ore e cercano altri modi di infatuarsi collettivamente”.
Credo che sia arrivato il momento di ragionare dunque sulle alternative, che sia preciso dovere di chi racconta la musica – e lo fa oltre la dinamiche redazionali con la pretesa di posizionare il proprio discorso al di là della mera cronaca di ciò che il grande mercato offre – di dare voce e spazio a quello che negli ultimi anni è stato letteralmente schiacciato dal brand Sanremo, ovvero quella musica reale che per un attimo Claudio Baglioni aveva infilato, pur in dose assai limitata, dentro al macchinone. Abbiamo cominciato con il minimo distacco del gioco ironico e ci siamo finiti dentro, quasi tutti, con tutti e due i piedi ma quando il nostro lavoro è raccontare cosa la musica oggi è, forse è bene fare un passo indietro o, addirittura, in avanti.
Quest’anno non racconterò Sanremo, dunque, per questa necessità che sento di sottrarmi alla macchina, evitare di professionalizzare e dunque portare lo storytelling sanremese generatore di click intorno a una materia artistica povera che distrugge il discorso musicale più che rafforzarlo. Quella di dedicarmi alle alternative possibili e vive mi pare sempre più una buona forma di necessaria resistenza culturale, dunque politica ed estetica.