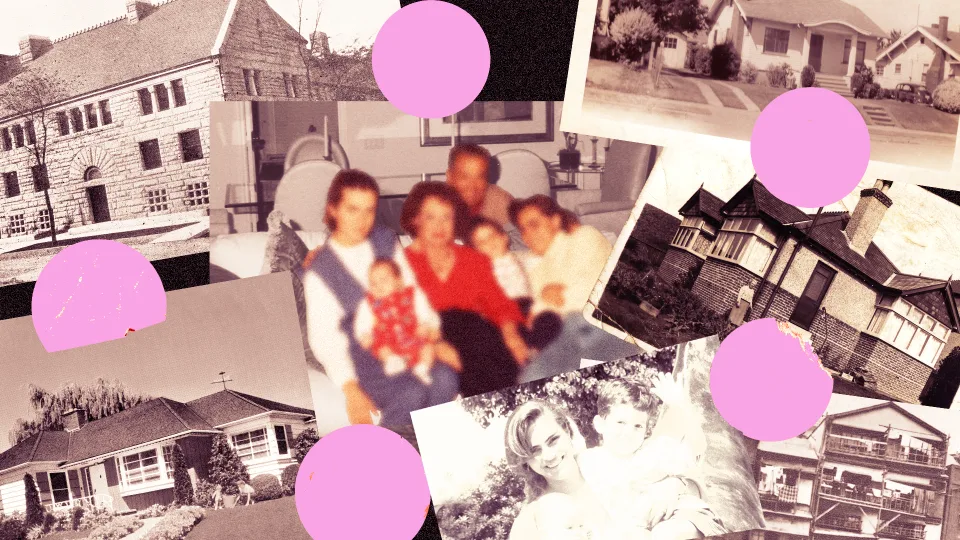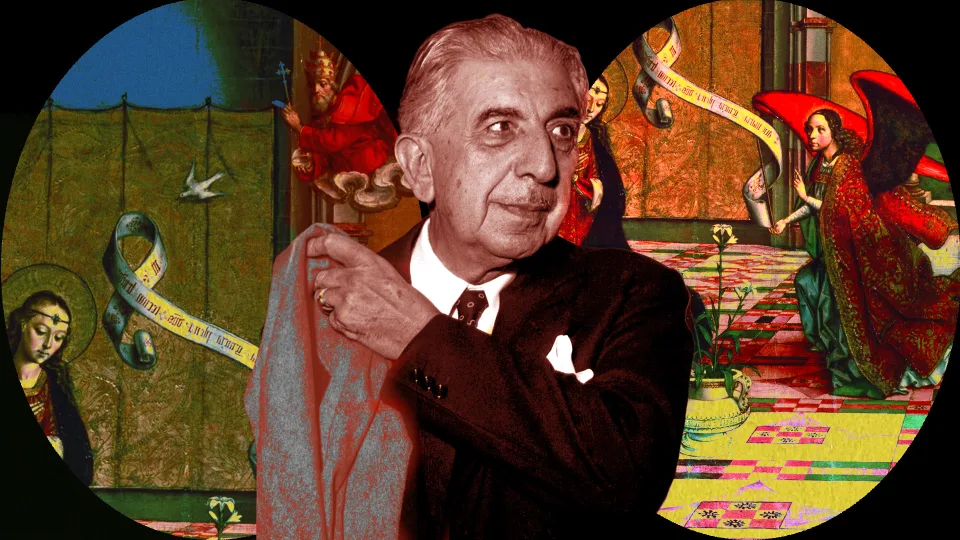Autore di una produzione letteraria tra le più alte dell’Occidente, Baudelaire è ancora oggi in grado di attrarre i lettori.
Qualcuno ha voluto fissare la figura e l’opera di Charles Baudelaire ricorrendo a un’espressione molto efficace, “il morbo e il marmo”: il morbo, perché nei suoi versi ritroviamo l’inquietudine, il tormento, la perversione, il rovello dell’epoca contemporanea; il marmo, perché tutto ciò si esprime soprattutto attraverso la forma classica del sonetto, che Baudelaire considerava dotata di una bellezza pitagorica. Bellezza pitagorica significa bellezza formale, ossia nata da vincoli, dalla necessità di sottostare a certe regole, metriche o rimiche (e si ricordi che in francese esistono due tipi di rime, femminili e maschili, che nulla hanno a che fare con il genere grammaticale). Da qui l’idea baudelairiana del verso come una sorta di “catena d’oro”.
Ebbene, per avvicinarci al capolavoro di questo sommo autore, I fiori del male (1857) – da poco ripubblicato in Italia da Mondadori in nuova traduzione a cura di Milo De Angelis –, basti pensare che Thomas S. Eliot ne parlò come del “più grande esempio di poesia moderna in ogni lingua”. A sigillare tale accostamento, sta il fatto che la produzione dell’autore francese presenta numerosi, acutissimi testi in prosa, saggistici e diaristici. Con lui la figura del poeta diventa tutt’uno con quella del critico. In questo senso, l’immagine dell’iceberg rende perfettamente l’idea di ciò che avviene con Baudelaire. Come comprenderne i versi senza l’immensa “massa di spinta” della sua riflessione? Come afferrare la portata della sua lirica, ignorando il pensiero che la sostiene? Il tutto, attingendo alle fonti classiche e a quelle cristiane, all’energia del Mito come alle forze della Croce.
Con Baudelaire, ha precisato uno studioso quale John Jackson, “la modernità entra nella poesia”. È vero però anche il contrario, ossia che i suoi furono gli ultimi versi perfettamente aperti alla comprensione del pubblico. Lo sostenne il linguista Emile Benveniste, affermando: “Situazione fondamentale e decisiva di Baudelaire: è l’ultimo a tenere un autentico discorso. Dopo di lui questa nozione si abolisce nella tendenza Mallarmé – verso lo svanimento profondo di ogni messaggio e dell’organizzazione sintattica del discorso”. In tal senso, I fiori del male si troverebbero sì sulla soglia del Moderno, ma appena prima dei suoi sconvolgimenti epocali.
Conviene ad ogni modo cominciare sottolineando uno fra i punti centrali della poetica di Baudelaire: la natura scompare a favore della città. Non a caso, il progetto di Walter Benjamin, massimo interprete di Baudelaire, è intitolato a Parigi capitale del XIX secolo. Dunque nelle sue liriche non troviamo più valli, boschetti o il lago di Lamartine, insieme a quella natura tanto cara ai romantici (si pensi appunto ai laghisti inglesi). Tutto questo è cancellato a favore delle nuove strade, delle nuove piazze, dei nuovi boulevard, della nuova popolazione dello spazio urbano. Industrializzazione e massificazione: uno tra i maestri di Baudelaire sarà d’altronde lo scrittore americano Edgar Allan Poe, a cui si deve L’Uomo della folla, e del quale il poeta francese tradurrà ben tre volumi di racconti.
Per una sorta di paradosso, dice però Jackson, l’entrata nella modernità coincide con un sentimento di caducità, di morte, sorretto da una parola chiave: spleen (in greco e poi in inglese ‘milza’). Lo spleen non è altro che l’erede del malessere letterario ottocentesco. Il termine appartiene alla famiglia della Sehnsucht, dello struggimento, della nostalgia dei romantici tedeschi, ma è anche qualche altra cosa. Secondo la millenaria teoria degli umori, esso sta indicare la bile, l’umore atrabiliare, cioè l’umore nero. Melanconia viene infatti dal greco antico mèlās, “nero”, quell’umore che fa dell’uomo un estraneo al mondo. Molto spesso in Baudelaire troveremo appunto il senso di un doloroso esilio sulla Terra.
Ora, un altro nodo centrale delle sue poesie è il cristianesimo, un cristianesimo particolare, mediato dalla figura di quel grande reazionario che fu Joseph de Maistre, un cristianesimo venato di agostinismo. La riflessione del poeta sul male e sul peccato, è stato detto, può venire soltanto da una distorsione del senso di colpa, dunque da una radice radicalmente cristiana. Baudelaire è un poeta cristiano che morirà bestemmiando nell’ospedale in cui era stato ricoverato, fino ad essere cacciato dalle suore.
Ancora: troviamo in lui un occhio lucidissimo, spalancato sulla sensibilità del suo tempo, un intuito sociale che ci fa pensare a Balzac. Inoltre, vediamo agire un vivo senso di pietà e di commozione per gli abitanti di Parigi, gettati ai margini dalla nuova economia. Ricordiamo ancora che nel 1848, l’anno che segna l’uscita del manifesto comunista di Marx, l’anno di una rivoluzione che attraversa l’intera Europa, lo troveremo sulle barricate. Ma dicevamo di una lancinante pietas. In effetti, il suo amore va alle vecchierelle, ai mendicanti, ai clochards, ai saltimbanchi, agli zingari o alle prostitute. E questo, bisogna sottolineare, in uno strano contrasto con il suo elitarismo, con quella aristocraticità che gli veniva da una precisa scelta di campo estetica e insieme etica: il dandysmo.
Oggi la figura del dandy si confonde con quella del gigolò, dell’elegantone, del raffinato a oltranza. Nell’Ottocento, invece, da Lord Brummel a Gautier (cui sono appunto dedicati I fiori del male), tale appellativo designava un autentico asceta, un monaco del bello, il quale, in nome della Bellezza, lottava contro la società borghese tutta votata all’Utile e alla Merce.
In una lettera del 1852, Baudelaire scriveva: “Come volete che si diano delle notizie biografiche? Volete forse mettere che sono nato a Parigi nel 1821, che ho fatto giovanissimo molti viaggi per i mari dell’India [non era vero, ne fece uno soltanto]. Io non credo che si debbano mettere cose del genere”. Questo annotava l’autore. Noi gli disubbidiremo e cominceremo proprio dicendo che la sua nascita avviene a Parigi nel 1821, la stessa data in cui, mentre si spegne Napoleone, vengono al mondo Flaubert e Dostoevskij. Ha appena sette anni, quando muore suo padre: da questo momento si apre una breve parentesi di serenità. Sarà probabilmente la più serena nella vita di un infelice che, va anticipato, Paul Verlaine inserirà nel novero dei “poeti maledetti”.
Pochi mesi di gioia perché vissuti in un contatto totale, fusionale con la madre. Quest’ultima, infatti, aveva già avviato una relazione con il militare e uomo politico Jacques Aupick, sfociata, dopo un aborto, nel matrimonio. Il figlio reagirà alle nozze come di fronte a un tradimento. Si tratterà di una fase destinata a segnare la sua vita, anche se all’inizio i rapporti con il patrigno non furono cattivi. In ogni caso, poco tempo dopo, Baudelaire si trasferisce con la madre a Lione dove deve subire l’allontanamento dalla famiglia e gli anni desolazione al College Royal.
Qui dimostra la sua anima insofferente, recalcitrante. È dodicenne quando commenta così una rivolta tra scolari: “Io sono fra i ribelli, non voglio essere uno di quei leccaculo che hanno paura di dispiacere ai professori”. Al college di Lione, continua sempre Baudelaire, “botte, battaglie con i professori e i compagni, pesanti malinconie”.
Il 1836 vede la famiglia Aupick trasferirsi a Parigi. Il ragazzo è ammesso al collegio Louis Le Grand, uno dei migliori istituti della capitale, ma appena tre anni dopo, disgustato dall’idea di passare per spia, eccolo espulso per essersi rifiutato di consegnare un biglietto datogli da un compagno. Il 1839 è anche l’anno della fuga dall’autorità familiare. Ormai diciottenne, Baudelaire inizia un periodo di vita libera e dissipata; negli stessi mesi contrae una malattia venerea, stigma del suo frequente, intenso rapporto con il mondo della prostituzione.
Lungo è l’elenco degli scrittori e artisti che conoscerà nel corso di questi anni. Balzac e Gautier, per esempio, incontrati durante una seduta di fumatori di hashish, e poi pittori come Courbet, poeti come Nerval. Nel 1841 troviamo un altro elemento biografico fondamentale: quella ossessione per i debiti che aveva marchiato a fuoco Lamartine, Chateaubriand, Balzac. Lo stesso anno lo vediamo partire per le Indie Orientali, dove un consiglio di famiglia aveva pensato di mandarlo perché si allontanasse da tentazioni pericolose come l’amore per i bordelli o lo sperpero di danaro. Destinazione Calcutta, ma Baudelaire si fermerà prima, alle Mauritius, e tornerà indietro. C’è da dire, però, che proprio in questo viaggio maturano alcuni tra i suoi testi più celebri, a cominciare dall’Albatros.
Nel 1842, a ventun anni, diventa finalmente maggiorenne e chiede di entrare in possesso di una notevole eredità: centomila franchi in oro. In questo periodo di dissipazioni, conoscerà una fra le donne centrali della sua esistenza, l’attrice creola Jeanne Duval, che diventa sua amante. Comincia la redazione dei Fiori del male, ma nel 1844 la madre decide di dare inizio alla procedura per mettere il figlio sotto tutela, affidandolo a un notaio. In effetti, nel giro di appena due anni, Baudelaire aveva dissipato quasi la metà del patrimonio paterno, oltre 44.000 franchi oro. Si tratta di un vero e proprio trauma: Baudelaire vedrà questa scelta con un attentato alla sua identità. Verrà respinto in un mondo adolescenziale e minoritario, nel quale perderà ogni diritto di usufruire del denaro. Siamo insomma di fronte a una svolta nel suo sviluppo emotivo e mentale: non per niente, poco dopo ha luogo un primo tentativo di suicidio.
Il 1847, però, coincide anche con la scoperta di Edgar Allan Poe, l’intercessore, il modello. Abbiamo citato De Maistre, lo scrittore cattolico e reazionario autore delle Serate di Pietroburgo; ebbene, Baudelaire dirà: “De Maistre e Poe mi hanno insegnato a pensare”.
Il 1848 significa barricate e rivoluzione. Resta famosa l’immagine del poeta che, imbracciando un fucile e con le mani sporche di polvere da sparo, incita la folla urlando: “Bisogna andare a fucilare il generale Aupick!” (ossia il suo patrigno). La seconda Repubblica durerà più o meno tre anni (la Prima Repubblica era nata dalla presa della Bastiglia del 1789), e sarà stroncata nel 1851 dal colpo di stato del suo presidente, poi Napoleone III, nipote di Napoleone I il Grande. Ebbene, ha sottolineato Giuseppe Montesano, il colpo di stato fu un autentico choc e spoliticizzò definitivamente Baudelaire. Al tutorato familiare, sotto il controllo del notaio Ancelle, si aggiunge, quasi a completarlo, il tutorato politico: due forme di assoggettamento e sottomissione che finiscono per soffocare la vita del poeta – anche se, è stato affermato, sotto il Secondo Impero egli riceverà aiuti e i sostegni di vario genere. Il senso dell’avvenimento, comunque, è chiaro: l’orrore per la morale della borghesia, più tardi affidata all’immagine del Belgio.
1857: escono Madame Bovary di Flaubert e la prima edizione dei Fiori del male: i due libri verranno portati di fronte allo stesso magistrato, che li accuserà di oltraggio al pubblico pudore. Baudelaire dovrà sopprimere alcune poesie consacrate agli amori saffici: facile immaginare quale fosse lo scandalo per l’epoca. Muore intanto il suo patrigno, Aupick. Da questo momento lo scrittore va incontro a una particolare trasformazione: ancora poco tempo, e cesserà del tutto di produrre versi. A soli 39 anni, Baudelaire smette di frequentare la poesia. Abbraccerà la cosiddetta “poesia in prosa”: sarà il passaggio dai “fiori del male” ai “fiori del banale” (Claude Pichois). Scopriremo così una musica nuova, che non ha più nulla a che fare con la metrica tradizionale; una musica moderna, adatta ai nuovi tempi, adatta alla nuova città. Come si è osservato, questi poemi in prosa, scritti nell’arco di circa dieci anni, iniziano infatti dopo quei lavori di sventramento della vecchia Parigi ideati dal barone Haussmann.
Con l’avvento al potere di Napoleone III, la capitale conobbe una radicale trasformazione sul piano urbanistico. Viene creata la vasta rete di boulevards, sia per modernizzare la metropoli, sia per permettere un controllo militare più agevole. La città delle rivoluzioni (1789, 1830, 1832, 1848, per citare soltanto le maggiori) manteneva un’impronta medievale, con strette strade dove bastava buttare un letto di traverso per creare una barricata. I nuovi boulevards, invece, ampi, diritti e spaziosi, sono fatti apposta per consentire le cariche di cavalleria e il tiro dell’artiglieria.
Baudelaire assiste inorridito a questa mutazione, con la nascita di tanti cantieri polverosi (descritti ad esempio nella poesia Il cigno). Si ascolti per esempio il famoso appello-grido-invocazione: “Ruines, ma famille” (“Rovine, famiglia mia”). Alla mutazione della città, corrispose appunto quella della sua opera. Oltre alle “poesie in prosa”, progetterà diari intimi, che si chiameranno via via Fusées, ossia “razzi”, o Il mio cuore messo a nudo. Scopre Wagner, a cui indirizza una lettera entusiastica rimasta senza risposta. Nel 1861 nuovi propositi di suicidio, poi improvvisamente, nel 1863, la decisione di trasferirsi a Bruxelles, a caccia di contatti editoriali e conferenze retribuite, sempre nella speranza di guadagnare un po’ di denaro. Purtroppo il fallimento sarà completo, portando Baudelaire a sviluppare un odio profondissimo, addirittura metafisico per Bruxelles e il Belgio in generale, odio culminato in un libro di frammenti contro questa nazione vista come l’incarnazione stessa della borghesia: La capitale delle scimmie.
Siamo arrivati al 1866: verso metà marzo, visita la chiesa di Saint-Loup, a Namur, la stessa dove, nel secolo successivo, verrà battezzato uno fra i massimi poeti di lingua francese del Novecento, ovvero Henri Michaux. Baudelaire inciampa sul pavimento, cade, ha un ictus che gli paralizza il lato destro del cervello. Viene ricoverato in un ospedale in cui le suore inorridiscono al suo continuo bestemmiare. La madre e qualche amico lo vanno a riprendere per trasferirlo a Parigi. È qui che si spegnerà il 31 agosto 1867, dopo aver perso il completamento la memoria e il linguaggio, i due cardini di un’opera tra le più alte dell’Occidente.
Tutto quanto si è detto, in conclusione, spiega il perché della intramontabile fortuna di Baudelaire, specialmente presso il pubblico giovanile. Come potrebbe essere diversamente, per un poeta maledetto che scrive di vampiri e di malinconia, di miseria e di hashish, di emarginati e di eros, trattando questi temi con una scrittura cristallina, acuminata, definitiva? Io mi trovo alla soglia dei settant’anni, e non posso certo cadere nel ridicolo, ma se potessi farlo, so per certo che mi farei tatuare un suo verso.