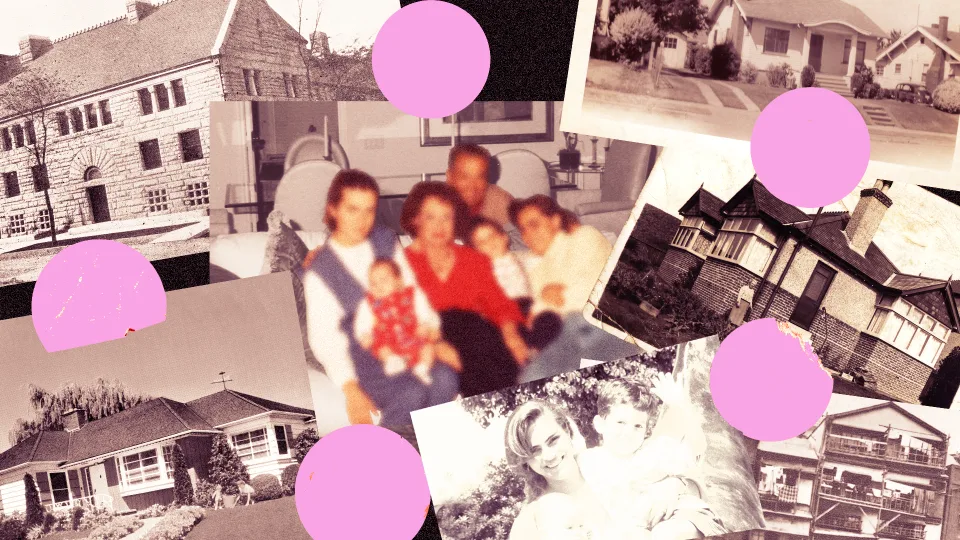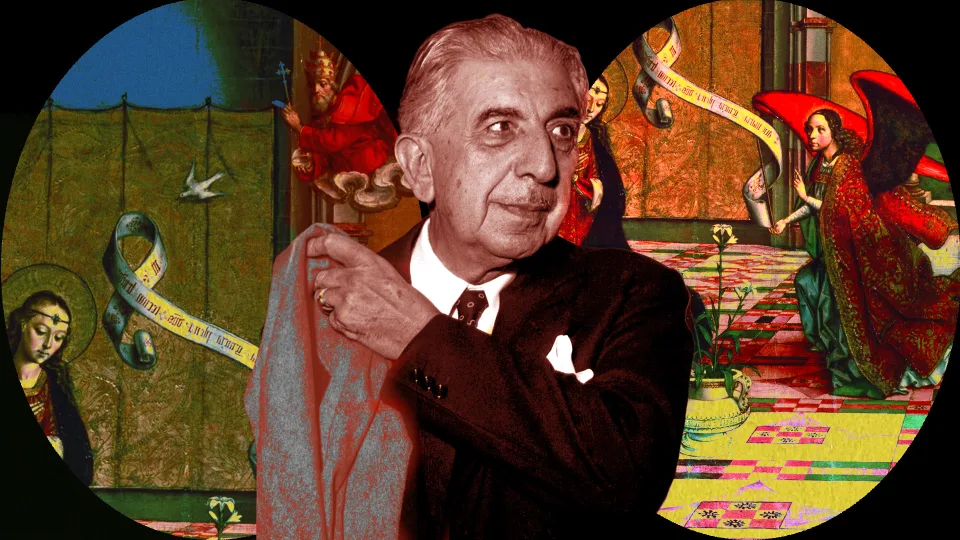Dalle scuole ai giornali, il racconto del bullismo sembra ancora dominato dal panico morale più che dall’ascolto: si punta sull’emozione e sul dolore, si ignorano i contesti e si finisce per non conoscere davvero né chi agisce né chi subisce.
Con l’ingresso nella scuola media, nei discorsi di mio figlio è comparso l’aggettivo popolare. A lui e ai suoi amici serve per descrivere i ragazzi o le ragazze ritenuti “di successo” nell’ambito scolastico. All’inizio questa accezione, per me secondaria, quasi mi infastidiva, poi ha finito per prendere il sopravvento: ha sostituito nel mio immaginario i corridoi delle scuole medie a cui ero abituata – angusti passaggi colorati di verdolino – con quelli delle middle o high school americane. È vero che lo scrutinio del gruppo, il timore del giudizio e dello scherno ci sono sempre stati e sempre ci saranno (e io, specie alle medie, ne avrei fatto volentieri a meno); ma per chi come la sottoscritta è stata un’adolescente in epoca analogica è quasi un riflesso condizionato chiedersi cosa comporta questa popolarità (o la sua assenza) per gli adolescenti di oggi; immaginarsi subito la derisione e l’esclusione che passa per i profili online; arrivare velocemente da questa parola a un’altra, assai più ricorrente e molto meno neutra: bullismo.
A ben guardare, anche bullismo è un termine nuovo utile a declinare in modo diverso qualcosa di antico. È stato lo psicologo svedese Dan Olweus il primo a usare bullying nei suoi studi sulla violenza scolastica sul finire degli anni Settanta. Secondo lo stesso Olweus, i fenomeni di prevaricazione all’interno degli istituti scolastici non sono una novità: è lo sguardo su di essi a cambiare nel tempo e a portare la ricerca a interessarsene. Inizialmente il bullismo era un oggetto di studio prevalentemente nei paesi Scandinavi ma l’attenzione si è andata pian piano ampliando.
Il concetto si è imposto su scala globale a partire dalla fine degli anni Novanta-inizio Duemila, anche in relazione ad alcune sparatorie avvenute nelle scuole statunitensi la cui matrice è stata ricollegata proprio al bullismo (la più famosa è quella di Columbine, nel 1999). Da lì le denunce e i report si sono moltiplicati.
L’idea di bullismo è il frutto di un progressivo cambiamento prospettico: gli stessi atteggiamenti violenti che in precedenza venivano derubricati alla voce “ragazzate”, o interpretati come ineludibili riti di passaggio tra l’infanzia e l’età adulta, iniziano a essere considerati come qualcosa di non più ammissibile, e, per contagio, altre parole che designano fenomeni contigui vengono rimesse in discussione: è il caso di nonnismo o di goliardia. Allo stesso modo, anche le strategie punitive praticate nel contesto familiare o all’interno delle istituzioni scolastiche devono essere censurate: le pene corporali, deprecate dagli organismi internazionali, sono ormai proibite in molti ordinamenti nazionali, anche se non in tutto il mondo, come ricorda Save the Children.
Il cammino della nozione di bullismo si interseca con vari movimenti: in primis la sempre crescente considerazione attribuita ai giovani e ai bambini in quanto categorie sociali autonome, ma anche la condanna verso tutte le forme di discriminazioni per ragioni fisiche, di genere, di etnia, di religione, di orientamento sessuale ecc. Insomma, l’identificazione del bullismo come fatto sociale procede insieme all’affermazione dei valori di inclusività che sono germogliati anche in ambito accademico attraverso approcci critici come quelli dei gender studies o dei postcolonial studies – del resto, vittorie sempre precarie: basta pensare alla velocità con cui Trump ha cancellato i programmi di diversità, equità e inclusione subito dopo la sua rielezione.
In anni più recenti si è abbassata l’età dei soggetti coinvolti e si è sconfinato dal mondo reale in quello digitale – anche se l’interpretazione del cyberbullismo come semplice estensione del bullismo in rete non è unanime. Nel 2025 l’Istat ha pubblicato un report (basato su dati del 2023), secondo il quale il 21% dei ragazzi tra gli 11 e i 19 anni è stato vittima di comportamenti offensivi o violenti in modo continuativo. I più colpiti sono i maschi e i cittadini di origine straniera mentre la fascia di età più interessata si attesta tra gli 11 e i 13 anni. Inoltre, il bullismo è abbastanza trasversale alle classi sociali. Secondo un report dell’Iss del 2022, le percentuali usate per misurare l’incidenza del bullismo sia agito che subito non variano poi molto in relazione al benessere materiale delle famiglie di provenienza.
La natura del fenomeno, eterno e proteiforme, lo rende, per certi aspetti, di difficile maneggiabilità. Intanto perché raccoglie in sé diversi immaginari.
Prima di tutto quello del bambino malvagio – e anche qui non siamo in presenza di una novità. L’opposizione bambino buono, educato e rispettoso vs. bambino cattivo, indisciplinato, “discolo” nella migliore delle ipotesi, la troviamo già nell’Italia post-unitaria in due libri fondamentali e fondanti: Le avventure di Pinocchio di Collodi e Cuore di De Amicis. Entrambi sono intrisi di una pedagogia di buoni sentimenti e ubbidienza ma con sfumature diverse. Le avventure di Pinocchio ci raccontano di un personaggio fatto di legno ma più umano degli umani, che suscita simpatia e immedesimazione. È un libro permeato di ottimismo, il percorso di formazione che inscena mira a correggere le storture del burattino impertinente e sfacciato, trasformandolo infine in un bambino vero (e virtuoso). Nel libro Cuore, invece, la distinzione tra bene e male appare più impermeabile, più manichea. Lo aveva del resto rilevato Umberto Eco, quando nel Diario minimo del 1963, esercitò la sua ironia e la sua sagacia critica nell’Elogio di Franti, il villain del romanzo. Eco prendeva in giro i santarellini come Derossi o Garrone e parteggiava per il cattivo di turno, il bullo ante-litteram, individuando nel suo carattere distintivo – il riso, lo scherno, lo sberleffo – un tratto rabelaisiano, il principio dialettico che vuole mettere in crisi l’ordine costituito, il conformismo borghese. L’anti-eroe così descritto da Eco, d’altra parte, rispondeva alla retorica del momento storico, al desiderio di ribaltare la visione convenzionale del mondo e le regole già date. Incarnava lo spirito del tempo e portava in sé il tema dello scontro tra individuo e società. Inoltre, Eco, per mostrare l’ideologia zuccherosa di cui è impastato il libro Cuore, rimarca che il personaggio di Franti è sostanzialmente un guscio vuoto, buono solo a illustrare cosa è il male: “Di tutti gli altri è detto qualcosa di più, cosa facesse il padre, in che eccellessero a scuola, come portassero la giacca o si levassero i peluzzi dai panni: ma di Franti niente altro, egli non ha estrazione sociale, caratteristiche fisionomiche o passioni palesi. Tosto e tristo, tale il suo carattere, determinato al principio dell’azione, così che non si debba supporre che gli eventi e le catastrofi lo mutino o lo pongano in relazione dialettica con alcunché. Franti da Franti non esce; e Franti morirà”.
“A ben guardare, anche bullismo è un termine nuovo utile a declinare in modo diverso qualcosa di antico. È stato lo psicologo svedese Dan Olweus il primo a usare bullying nei suoi studi sulla violenza scolastica sul finire degli anni Settanta”.
Il termine bullo sembra provenire dal germanico bule, o dall’olandese boel, e in entrambi i casi l’accezione originaria era positiva (amico e fratello i significati). Se prendiamo il Devoto-Oli del 1971 troviamo che il bullo era il “teppista, bravaccio”. Ma la connotazione nascondeva dei tratti benevoli, anche in virtù di una diversa zeitgeist che vedeva di buon occhio gli atteggiamenti smargiassi e prepotenti: non a caso la macchietta di Petrolini di Gigi er bullo è passata indenne attraverso diversi decenni – o magari non è neppure scomparsa se esistono ancora personaggi come Fabrizio Corona?
Un altro libro che nutre il nostro immaginario rispetto al bullismo, e che in effetti, per quanto calato anch’esso nel suo tempo, è stato in più occasioni citato come paradigmatico del fenomeno, è Il signore delle mosche di William Golding. Qui si racconta di alcuni ragazzini che, sprovvisti della supervisione degli adulti deceduti in un incidente aereo, si trovano a fronteggiare la sopravvivenza nell’isola in cui sono naufragati. Sebbene inizialmente il gruppo cerchi di ispirarsi alle regole della convivenza civile, il romanzo registra il graduale fallimento di questi tentativi fino alla regressione verso la dimensione del conflitto continuo e la soddisfazione delle pulsioni più abiette. Il personaggio emblematico del bullo è Jack, che rappresenta gli istinti primordiali, la caccia, l’aggressione, la sopraffazione; c’è anche la vittima perfetta: Piggy, il bambino grassoccio e occhialuto che incarna invece la ragionevolezza, la civiltà.
Nel Signore delle mosche le tribù di ragazzi e i conflitti ricordano nelle loro linee essenziali e astratte molti degli elementi che ricorrono quando si parla di bullismo: la costruzione di un nemico interno al gruppo dei pari usato come vittima sacrificale, il ruolo di chi osserva senza prendere una posizione, l’assenza degli adulti.
Se il bambino cattivo della prima metà del Novecento si stagliava su uno sfondo di valori morali condivisi e radicati nella società e nelle istituzioni, nella contemporaneità – il sociologo Maffesoli ha parlato di un neotribalismo postmoderno – il sostrato che sta dietro al bambino cattivo, dietro al bullo, è avvolto dalla nebbia: difficile capire le ragioni, inquadrare il fenomeno, il miglior ragionamento che si riesce ad articolare rimanda alla logica ancestrale della tribù.
Oggi comunque il nostro immaginario è nutrito più dalle notizie che dai libri. E, come rileva un saggio di pochi anni fa la sociologa Rosalba Perrotta, il modo in cui viene raccontato il bullismo fa leva soprattutto sulle emozioni – su quello che la studiosa chiama “panico morale”. Partendo dall’analisi degli articoli pubblicati su due quotidiani nazionali di diversa impostazione politica, Perrotta sostiene che gli episodi di aggressione vengono presentati ai lettori come qualcosa di completamente nuovo e di terribile che può essere contrastato solo con la repressione. Tutto ciò produce un allarme sociale a intermittenza, che terrorizza le famiglie nel momento in cui la notizia è ovunque ma che tende a essere rimosso velocemente quando il tema esce dal flusso delle news.
Lo abbiamo visto recentemente, nel caso di Paolo Mendico, un ragazzo di 14 anni che si è tolto la vita in seguito ad anni di derisioni e prese in giro a scuola, e di cui si è ampiamente parlato, almeno per qualche giorno. È positivo l’emergere di queste denunce, a riprova del cambio di sensibilità generale – forse, fino a qualche decennio fa, la famiglia di un ragazzo che si è ucciso avrebbe provato vergogna e optato per il silenzio e il ripiegamento nel privato – tuttavia, c’è da notare che il tipo di informazione fornita serve poco alla causa del contrasto al bullismo, piuttosto alimenta la sfiducia nelle istituzioni – cieche e imbelli – e il senso di una barbarie senza volti e connotati.
Così come nei processi mediatici per i casi di cronaca l’attenzione converge sui presunti assassini, nella narrazione mediatica del bullismo il baricentro è tutto spostato sulla vittima. “Le voci dei bulli vengono ignorate. Non conosciamo il loro punto di vista, la loro definizione della situazione, li assimiliamo alle immagini stereotipate di cattivi che li rendono simili al Franti di De Amicis”, scrive Perrotta. Ed è probabilmente qui che ci si imbatte in un “angolo cieco” dell’informazione, dovuto a una serie di limiti oggettivi quando gli attori coinvolti sono minori – in primis il fatto che il diritto di cronaca viene meno rispetto al diritto di riservatezza dei minorenni. È un angolo cieco che si presenta in moltissime delle vicende che riguardano i bambini, in cui, come nelle fiabe, deve esserci l’orco cattivo, o la sua versione più giovane, il bambino cattivo. Talvolta la magistratura nel tempo smonta tesi che erano comparse sui giornali – prendiamo il caso di Bibbiano – mentre in altri casi la violenza patita dalle vittime è indiscutibile. Ma non è questo il punto: il nodo centrale è l’immaginario che i media creano calcando solo sul tono patetico o censorio. È il “panico morale” di cui parla Perrotta, che poco aiuta a comprendere: al limite ci fa sentire “assolti” quando il bullismo si mostra nel volto vero della vittima che non c’è più.