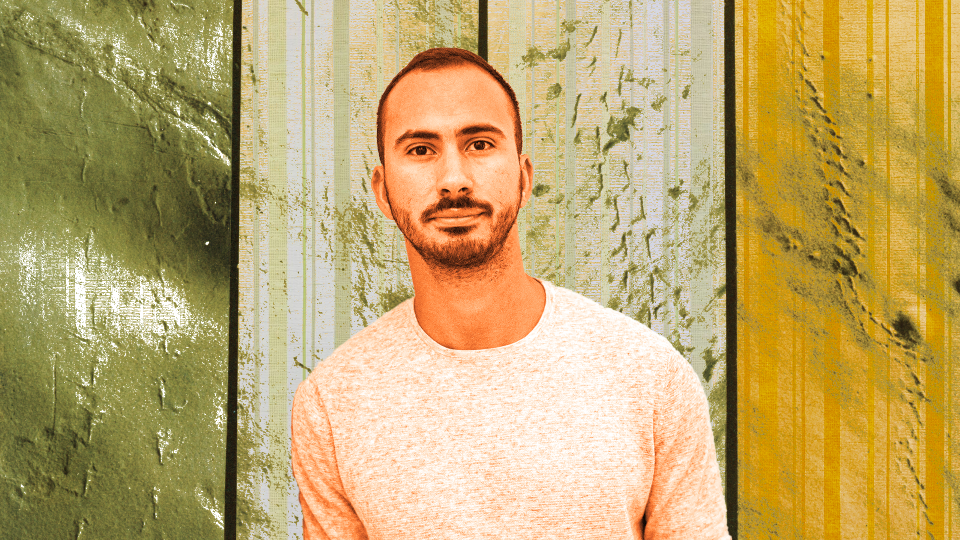Con "Austral" (Sellerio) Carlos Fonseca si conferma uno degli scrittori più interessanti della letteratura latinoamericana, area dove gli autori e le autrici di talento continuano ad abbondare. Una conversazione sui limiti del romanzo, la distanza e le contiguità culturale tra Europa e America Latina e sull’importanza di Roberto Bolaño.
L’universo narrativo di Carlos Fonseca popola le soglie: deserti remoti, lingue estinte, utopie fallite. Nato in Costa Rica nel 1987 e cresciuto tra Porto Rico e Stati Uniti, oggi Fonseca insegna Letteratura postcoloniale latinoamericana all’Università di Cambridge ed è considerato uno degli scrittori in lingua spagnola più interessanti della sua generazione.
I romanzi di Fonseca sono dei laboratori di biografie inventate, archivi apocrifi e memorie collettive che si intrecciano a vicende intime. La sua narrativa costruisce un immaginario dove la precisione documentaria convive con l’invenzione, e dove ogni pagina sembra nascere da un dettaglio marginale destinato ad aprire nuovi spiragli nella storia. Camuffamenti biografici e linguistici, pseudonimi, genealogie reinventate, archivi falsificati, fino alle soglie geografiche che segnano il passaggio tra continenti e memorie – l’America Centrale e l’Europa, il New Jersey e il Chaco, il museo e la giungla – Fonseca racconta la fragilità delle identità di confini sempre pronti a trasformarsi o a dissolversi.
In Museo animale (Sellerio, 2022, traduzione dallo spagnolo di Gina Maneri), intreccia il destino del curatore di un museo di storia naturale del New Jersey con quello della stilista visionaria Giovanna Luxembourg. L’innesco narrativo è un breve articolo che il giovane curatore dedica al motivo a quinconce – la disposizione a cinque punti, come il “cinque” del dado – che riconosce sulle ali di alcune farfalle tropicali: una micro-geometria che in natura regola il gioco tra mimetismo e ostentazione. Pubblicato su un bollettino museale, intercetta l’attenzione di Luxembourg e diventa il simbolo del loro sodalizio intermittente. La trama segue questo dialogo, mentre il motivo migra dalle teche ai tessuti, trasformando un reperto naturale in una domanda sul visibile e sul suo rovescio. I loro incontri segreti restano sospesi, senza esito, come se l’intero romanzo fosse una meditazione sul fallimento dei progetti umani quando entrano in collisione con le forze oscure della Storia.
In Austral, pubblicato nel 2025 ancora da Sellerio e tradotto da Maneri, il protagonista Julio Gamboa riceve i manoscritti di Aliza Abravanel – scrittrice colpita da afasia negli ultimi anni della sua vita – e si confronta con testi sospesi tra romanzo e memoir, saggio antropologico e frammenti diaristici. In quelle pagine affiorano la follia dell’antropologo Karl von Mühlfeld, i fantasmi della colonia antisemita fondata in Paraguay dalla sorella di Nietzsche, le cicatrici lasciate dal genocidio guatemalteco, e le domande sulla sopravvivenza di una lingua in via d’estinzione.
Austral è un romanzo matrioska, nel quale Fonseca mette in scena figure che scrivono fino alla follia, si perdono nella propria voce, inseguono la memoria di un popolo e del suo idioma. Le pagine sono piene di citazioni e rimandi, un tessuto intertestuale che intreccia Wittgenstein e Borges, Sebald e Piglia, Bolaño e Saer. Al centro della sua scrittura c’è una tensione costante tra purezza e contaminazione, archivio e oblio. La cifra più originale della sua scrittura è da ricercarsi proprio in questa tensione irrisolta, in cui l’archivio si trasforma in rovina e l’oblio diventa una forma paradossale di memoria. Leggere Fonseca significa dubitare di risposte troppo nette e definitive, percorrendo un territorio dove le rovine del passato non smettono di interrogare il presente.
Per la sua struttura vertiginosa e per la precisione del lessico, considero Museo animale una delle letture più significative degli ultimi anni. In occasione della pubblicazione di Austral – che ha ribadito le mie impressioni sull’autore – ho raggiunto Carlos Fonseca al telefono, per porgergli alcune domande a partire dalle sue opere tradotte in Italia.
Vorrei iniziare questa conversazione parlando di memoria e perdita, due temi che innervano i tuoi romanzi tradotti in Italia. In Austral il perno di questa relazione è il linguaggio.
È vero: sono due temi ricorrenti. Generalmente consideriamo il linguaggio come qualcosa di immateriale. Penso che attraverso Austral io abbia voluto esplorare cosa succede quando dei costrutti sociali che diamo per scontati e per garantiti – come il linguaggio, appunto – cominciano a sfaldarsi o a vacillare. Nel momento in cui questo avviene, siamo costretti a osservarlo come qualcosa di materiale, cioè in termini politici e culturali.
Quello che mi preoccupa di più, però, è la standardizzazione della lingua. Tanto per fare un esempio, ultimamente ho letto alcune lettere della corrispondenza tra Nabokov e Edmund Wilson. La lingua con cui comunicavano era ricca, piena di idiosincrasie, unicità. Se le paragoniamo alle email o ai messaggi che ci spediamo oggi, sembra che parliamo tutti nello stesso modo. Abbiamo reso il linguaggio qualcosa di puramente efficiente e utilitaristico, ma forse questo ci rende anche incapaci di osservare il mondo in maniera complessa. Mi inquieta molto quando l’impostazione automatica degli smartphone suggerisce la parola successiva da scrivere in un’email. Mi chiedo spesso cosa stiamo sacrificando con questa modalità e cosa stiamo invece guadagnando.
Museo animale e Austral sono due romanzi dalla struttura organica ed eterogenea. Le vicende a tratti prendono deviazioni inaspettate o si fanno opache, la trama è interrotta da pezzi di archivio, immagini, digressioni, piccoli sabotaggi narrativi che generano straniamento nel lettore. Quanto è importante per te esplorare i limiti della forma romanzo?
Penso che sia più che altro la mia mente a funzionare così, non un obiettivo che cerco di raggiungere con la scrittura. È il modo più realistico e coerente che conosco di raccontare una storia. Ai miei studenti dico sempre: non esiste menzogna più grande che pensare che una storia abbia un inizio, uno svolgimento chiaro e una fine. In realtà le storie sono fatte di digressioni, di dimenticanze, di cose che tornano e altre che non vanno a parare da nessuna parte. Quando scrivo cerco di aderire alla vera forma delle storie e alle loro traiettorie, che sono disordinate e scomposte. Secondo me è una caratteristica propria della narrativa contemporanea, oggi non può più esistere una narrazione onnisciente.
“‘Non esiste menzogna più grande che pensare che una storia abbia un inizio, uno svolgimento chiaro e una fine.'”
Intendi dire che la narrativa contemporanea deve muoversi inevitabilmente su una trama non lineare? Anche se non si può dire che Austral non abbia una trama, non ho potuto fare a meno di pensare che per te sia stato una specie di compromesso.
Mi piacciono le storie e quindi le trame, ma sono un po’ annoiato dalla continuità e dalla causalità. Quello che mi piace fare è mettere insieme più storie – più traiettorie, appunto – e farle risuonare tra loro, in senso figurativo, metaforico. Austral è composto da tre storie di perdita in cui gli elementi che le compongono risuonano tra loro. Ovviamente non lascio che questo avvenga in maniera casuale. C’è una sorta di posizionamento strategico dei frammenti di storie, le immagino come una composizione che permette a questi richiami armonici di possedere anche un ritmo.
L’identità dei tuoi protagonisti è caratterizzata da una forma di nomadismo culturale. La perdita delle proprie radici è un topos letterario che nella narrativa contemporanea ha assunto varie forme e a questo punto mi chiedo, è un discorso globale anziché locale?
Le nostre vite e i nostri networking sono globalizzati e di conseguenza la narrativa che produciamo è errante. Mi piace molto la “poetica dell’erranza” del poeta e scrittore Édouard Glissant e da scrittore mi piace l’idea di essere un errante, sia nel senso di uno che commette errori che di uno che si perde nella cartografia delle possibilità concesse dalla letteratura. Tutti gli scrittori ai quali guardo con ammirazione sono scrittori dell’erranza e della digressione. W. G. Sebald era letteralmente uno che iniziava a camminare e si perdeva. Oppure i personaggi di Roberto Bolaño, che sono spinti a perdersi dall’entropia della storia che li vede protagonisti.
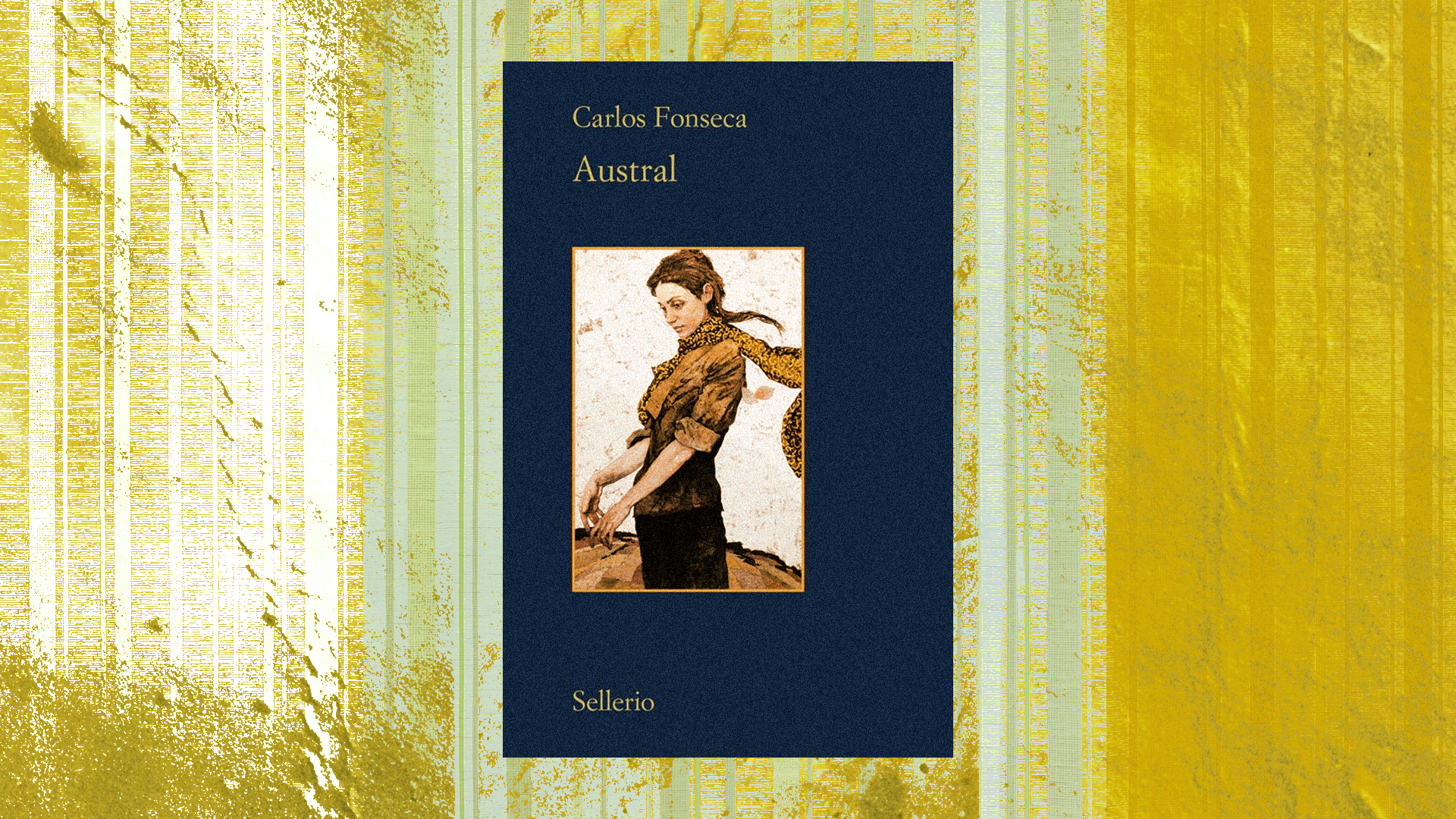
Hai nominato sia Sebald sia Bolaño, a cui vieni paragonato spesso e in maniera piuttosto esplicita. Come ti fa sentire?
Mi mi viene da sorridere. Sono felice di essere considerato una specie di discepolo di alcuni autori che hanno rappresentato tantissimo per me e per la mia generazione. Penso che in particolare, Sebald e Bolaño siano stati significativi soprattutto mentre scrivevo Museo Animale e Austral; ne ero ossessionato ed è stata una fortuna non averli letti da adolescente. A quell’età leggevo Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Clarice Lispector, Gabriel García Márquez.
Sembra un periodo molto fertile per la letteratura latinoamericana, a giudicare da quello che viene tradotto in Italia. Negli ultimi anni abbiamo conosciuto o scoperto voci capaci di intrecciare autobiografia e invenzione, memoria politica e sperimentazione formale, cronaca e immaginari visionari e radicali. Penso a Mariana Enriquez, Camila Sosa Villada, Pola Oloixarac, Marcelo Rubens Paiva, Cristina Rivera Garza, Benjamín Labatut, Pilar Quintana, Leila Guerriero.
Sì, è un momento molto eccitante per la letteratura latinoamericana: molti scrittori e scrittrici latinoamericani sono tradotti e letti in tutto il mondo. Forse il fenomeno più importante degli ultimi dieci anni è stato il riemergere della letteratura di genere, come il neogotico, o quello che Cortázar avrebbe chiamato “fantastico”; penso ad autrici come Mariana Enriquez o Monica Ojeda. Rilevante è anche il filone della climate fiction che ovviamente sta proliferando in tutto il mondo e che in America Latina ha contribuito alla creazione di discussioni sul senso della scrittura durante la crisi climatica e sul rapporto tra natura e cultura – penso ai romanzi di Juan Cárdenas, Cristina Rivera Garza, Marta Aponte.
C’è un avvenimento recente che penso mi riguardi più da vicino, è una teoria personale sulla generazione di scrittori alla quale appartengo. Nell’ultimo decennio è cambiato il modo di leggere Bolaño. Quando ho iniziato a scrivere, la maggior parte dei miei colleghi sembravano voler emulare I detective selvaggi; i protagonisti dei loro libri erano scrittori, poeti o lavoravano in una libreria e volevano diventare l’uno o l’altro. Invece adesso il romanzo più influente di Bolaño è 2666, cioè un Bolaño paranoico, che ha cercato di scrivere questo romanzo tentacolare che abbraccia tutto l’universo contemplando anche le questioni socio-politiche latinoamericane.
Austral è un romanzo arricchito da una quantità eccezionale di riferimenti culturali. Filosofia, arte, antropologia, letteratura. Riesci a tenere assieme tante discipline.
Ricardo Piglia diceva di Borges che era un “erudito giocoso”. Io ho una formazione accademica, ho trascorso molto tempo tra i tomi filosofici, ma anche a me piace “giocare”. Quando scrivo mi chiedo sempre – su un piano tecnico – come rendere questo gioco combinatorio utile ai fini della storia. Calvino in questo era un maestro: riusciva a integrare nelle sue opere nozioni di letteratura, scienza, semiotica o di storia dell’arte, mettendole al servizio di un fine più grande, che poi è quello che forse interessa di più il lettore: capire meglio la vita.
Il protagonista di Austral, Julio Gamboa, è chiamato a decidere se il manoscritto di una sua vecchia amica scrittrice sia un romanzo o un libro di memorie. Ci ho visto una provocazione legata al dibattito che c’è oggi a proposito di autofiction e romanzo d’invenzione
Probabilmente mentre scrivevo quel passaggio deve essermi scappato un sorriso al pensiero che fosse una provocazione indiretta. A parte gli scherzi, penso che l’autofiction sia una questione di complessità: se è una storia in cui l’autore si limita a riportare i fatti della propria vita, non mi interessa granché. Tanto per essere ripetitivi, e tornando a parlare di Borges: nei suoi racconti si può rintracciare l’allegoria del suo amore per Estela Canto, il fatto che fosse un uomo timido e che soffrisse per quella relazione. Si può considerare Finzioni un libro di autofiction? Penso di sì, se parliamo di un genere nel quale l’autore utilizza e distorce la propria esperienza personale per scrivere qualcosa di più complesso. Mi interessa molto questo aspetto, capire in che modo, nelle cose che scriviamo, si celano e prendono nuove forme le esperienze personali che non possiamo davvero ignorare.
La voce narrante dei tuoi protagonisti spesso si sdoppia, si contraddice. Prima hai parlato di “composizione strategica”, quindi di un intervento successivo alla stesura, mi interessa capire se c’è un intervento simile anche sulla voce narrante. C’è una fase di riscrittura in cui insabbi e sottrai deliberatamente i piani narrativi o rendi incoerenti i tuoi protagonisti?
È una cosa che ho imparato da Faulkner. Le sue voci narranti non capiscono mai fino in fondo quello che gli accade e non interpretano mai davvero correttamente quello che vedono. Questo pone il narratore in una posizione di ambivalenza e di equivoco. Si instaura un rapporto profondo tra il lettore e il narratore, perché i fatti avvengono “in diretta” per entrambi.
Questa ambivalenza mi pare si rifletta anche nei tuoi personaggi, spesso spettri, figure scomparse o assenti, che lasciano tracce del loro passaggio da decifrare.
Sì è vero, c’è sempre un’assenza che richiede di essere colmata. C’è un certo senso di spettralità da cui sono affascinato, così come sono affascinato dall’idea di ricostruire qualcosa che è andato perduto, che sia il linguaggio o una presenza, appunto. È un’interpretazione della Storia benjaminiana: la Storia è stata una catastrofe e noi dobbiamo ricominciare a ricostruire, a partire da quello che ci rimane, con quello che abbiamo a disposizione.
“La narrativa che produciamo è errante. Mi piace molto l’idea di essere un errante, sia nel senso di uno che commette errori che di uno che si perde nella cartografia delle possibilità concesse dalla letteratura.”
“Australe”, che significa “meridionale”, deriva forse dal greco “austērós” (austero, aspro). Che cos’è il Sud per te?
In letteratura il Sud è un posto contraddittorio. Da una parte è un paradiso terrestre e dall’altra un inferno. Nella letteratura occidentale questo lo ritroviamo tanto in capolavori del Novecento come Cuore di tenebra di Conrad quanto nei diari di bordo di Cristoforo Colombo o in qualunque cronaca di viaggio colonialista dal 1492 in poi.
Nei tuoi romanzi si incontrano continuamente riferimenti che attraversano emisferi diversi, e dentro questo intreccio affiorano anche le asimmetrie di un passato coloniale. In che modo lavori su questa contaminazione tra Europa e Sudamerica, e quale significato assume per te scrivere su questa linea di tensione?
Trovo molto infantile e superficiale pensare che il risultato della decolonizzazione debba consistere in un rifiuto o una negazione della cultura occidentale. Invece amo trovare tra loro punti di contatto anche impossibili come, appunto, Nietzsche che appare improvvisamente in Paraguay o Wittgenstein in Guatemala. Mi serve a ricollocare il pensiero dell’umanità, a dotarlo di nuove interpretazioni e nuovi significati.
In Austral e in Museo animale, emerge l’idea del collasso di un’epoca di grandezza e di utopie. Come a dire: adesso non ci resta che scrivere romanzi sulla crisi del presente…
Penso che ci siano delle contingenze storiche che uniscono la generazione di scrittrici e scrittori nati intorno alla metà degli anni Ottanta sia in Europa sia in America Latina. In quel periodo sono cadute molte dittature in America Latina, mentre in Europa è caduto il Muro di Berlino. Siamo cresciuti percependo un senso di fine , la scomparsa dei nostri punti di riferimento. Quando sono nato io, in Costa Rica erano appena successe un sacco di cose e quello che è venuto dopo erano McDonald’s ovunque e la sensazione che fosse tutto abbastanza okay, ma anche orribile e vuoto al tempo stesso. Penso che questo sentimento di collasso della storia sia diventato predominante nella scrittura e nei romanzi. Gli individui non hanno più un orizzonte storico con cui confrontarsi e, per dare senso alle loro vite, l’unica cosa che rimane è il consumo, l’individualismo. La scomparsa della Storia è stato un trauma e io cerco di andare contro questo trauma. Negli ultimi dieci anni in Sud America c’è stato un risveglio, un ritorno dei movimenti politici e delle proteste di massa: sono molto interessato a questo passaggio dal torpore all’azione. I miei protagonisti, allo stesso modo, combattono per ritrovare un senso nella Storia e aggrapparsi a quello.