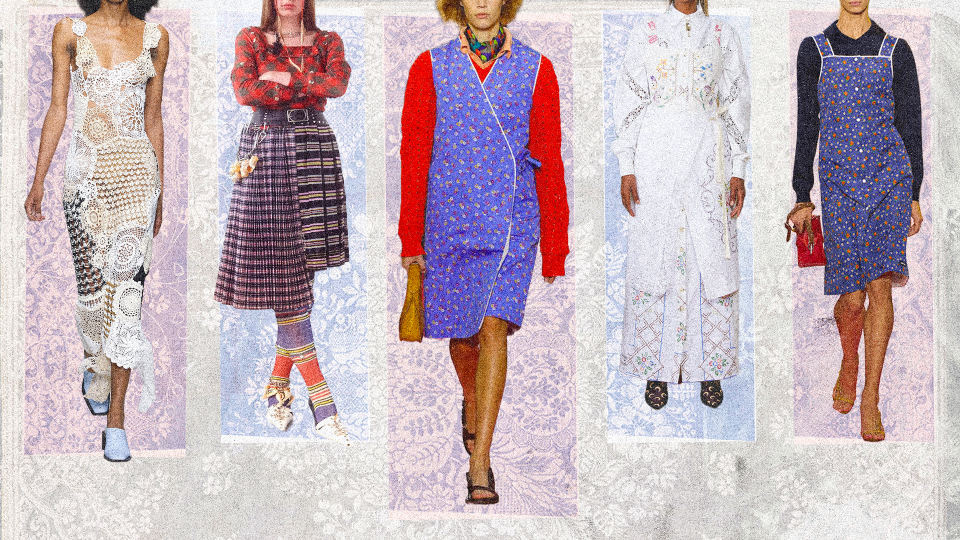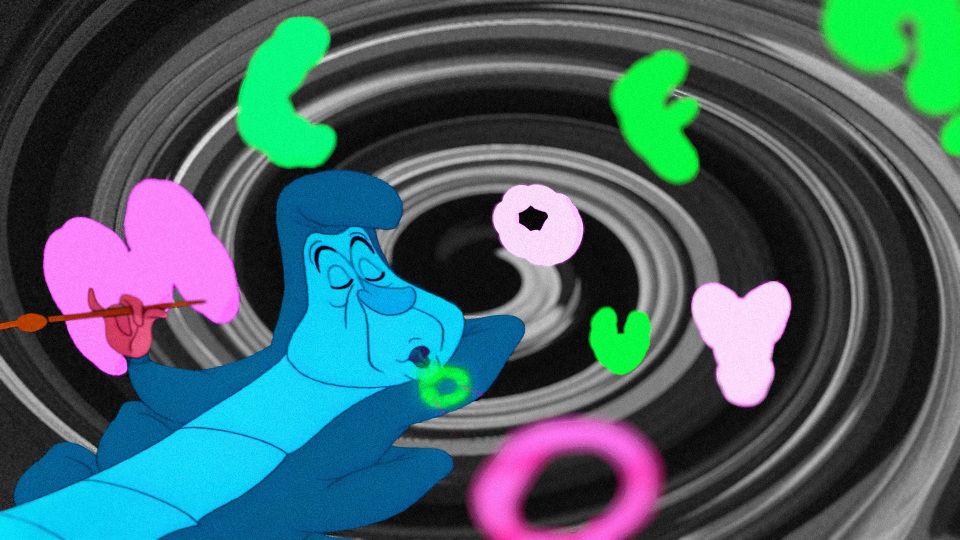È una domanda che si pone chi è costretto a parlare una lingua diversa dalla propria. Ma diventa partiolarmente complessa per gli immigrati che si trovano ai margini, lontani dal luogo natio, in una condizione di subalternità rispetto agli altri: è qui che il disagio psichico e la sofferenza faticano a trovare una via d'espressione sintonica con il proprio Io.
Ho un paio di care amiche italofone che hanno trascorso la quasi totalità della loro vita adulta tra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna: entrambe mi hanno detto di aver sempre fatto terapia soltanto in inglese. È una scelta (obbligata, mi rendo conto – anche se forse ormai sempre meno grazie alla psicoterapia online) che mi ha stranito: era possibile svelare le proprie ossessioni, manie, ansie, in una parola il proprio Io a qualcuno che non parlava la lingua intorno a cui si era sviluppato il loro inconscio? Oppure era un mio preconcetto ritenere che la lingua materna, che ci accompagna nelle prime esperienze del mondo, plasmasse la nostra identità e il modo in cui osserviamo la realtà in maniera tanto assoluta?
Per Frantz Fanon, lo psichiatra e filosofo postcoloniale francese nativo della Martinica, l’atto di parola è l’atto di soggettività per eccellenza, di asserzione di sé, di ancoraggio a un mondo, a una storia: “Parlare,” diceva, “è essere capace di utilizzare una certa sintassi, possedere la morfologia di questa o quella lingua.” Ma aggiungeva che significa soprattutto “adottare una cultura, sopportare il peso di una civiltà”.
Questo articolo si esprime per lo più attraverso le categorie di colonizzato/colonizzatore, ma mi pare che sia possibile fare riferimento ad altre, forse più attinenti ai nostri tempi. Per esempio, in Pelle nera, maschere bianche Fanon scriveva che parlare vuol dire “esistere per l’Altro”; eppure, per il colonizzato – e forse in maniera non del tutto dissimile anche per il migrante oggi – la dimensione dialogica è preclusa: non soltanto il subalterno parla una lingua diversa dall’Altro, ma cambia il registro, l’intonazione, la postura nel comunicare. Qualche mese fa ero in Questura, per le pratiche del permesso di soggiorno, e non ho potuto fare a meno di notare come le persone straniere che riempivano quella stanza asettica occupavano lo spazio in una maniera peculiare: anche chi ti saresti aspettato che avesse un certo modo di fare – ragazzetti, famiglie con bambini piccoli, uomini ansiosi di tornare al lavoro – non protestavano, non erano agitati. Più erano arrabbiati, invece, meglio conoscevano la lingua.
E talvolta, quando quelle caratteristiche non si presentano (quando cioè l’atteggiamento non è dimesso, la parola corretta e la voce assertiva), mi pare che la reazione dell’Altro sia ancora stupita o indispettita: “Come parli bene l’italiano” oppure “Non mi puoi parlare così”.
Noreen Masud, l’autrice del memoir Terre piatte, scrive però che “apparentemente il trauma trascende la lingua e il tempo, e per questo è inesprimibile”. Ritiene che le persone sappiano raccontare la loro storia, ma la parte difficile è trovare qualcuno che sappia come ascoltarle.
L’altra dimensione non trascurabile è che chi attraversa un confine linguistico fa quasi sempre un lavoro di traduzione del sé, che è un processo tanto difficile quanto consapevole. Quindi alle volte mi domando se fare psicoterapia in una lingua diversa da quella materna non possa celare il pericolo di una dissimulazione, di cattiva traduzione dell’Io. Per questo non sono d’accordo con quanti affermano che si può raccontare un evento traumatico in qualsiasi lingua: non solo possiamo essere persone diverse in idiomi differenti, ma mutano radicalmente anche le strutture linguistiche, le metafore, i modi di leggere la realtà. Per esempio, in Europa la fobia è percepita come qualcosa di cui noi abbiamo paura, ma se in altre lingue e in altre culture fosse l’oggetto della fobia ad avere paura di noi, non sarebbe tutta un’altra questione?
Acqua sporca, il mio esordio alla narrativa, doveva essere principalmente un libro sulla lingua: su come un singolo processo migratorio possa cambiare il lessico e le modalità di comunicazione di un’intera famiglia. Questo intento iniziale è stato in parte disatteso quando, nel corso delle ricerche in fase di stesura, mi sono imbattuta nel pensiero di Jacques Lacan. Secondo lo psicanalista francese la struttura linguistica sarebbe molto simile alla struttura dell’inconscio, o meglio, l’inconscio è strutturato come un linguaggio – cifrato, chiaramente, altrimenti sarebbe troppo facile – e sarebbe proprio il fallimento di quella struttura linguistica a generare una frattura psicologica in cui si deposita il seme delle follia.
A detta di alcuni, Lacan sarebbe stato il primo analista a collegare direttamente linguaggio e psicoanalisi: innanzitutto ha compreso la capacità curativa della parola, ma bisogna anche dire che questa chiave di interpretazione l’ha intuita la religione prima ancora della medicina.
Il bilinguismo, che è tanto apprezzato nella pedagogia contemporanea, storicamente non è stata un’opportunità per le persone provenienti da territori colonizzati, ma un obbligo. Albert Memmi, intellettuale tunisino di lingua francese, lo definisce il dramma linguistico di chi, non potendo più parlare nella propria lingua madre, è progressivamente destinato a perdere la memoria, il passato e, quindi, anche il futuro – in poche parole: a esistere fuori dalla Storia, non più come un essere umano, ma come uno spettro. La scomparsa della lingua materna, e l’imposizione di quella coloniale, diventano fatti che alimentano un sentimento di inferiorità e veicolano la “malattia” psichica, forse anche attraverso una compartimentazione della propria identità. Da una parte c’è il sé pubblico, che deve esprimersi nella lingua del colonizzatore, e dall’altra il sé privato che conversa con i propri simili nella lingua natia.
In Ritratto del colonizzato, Memmi precisa che il bilinguismo coloniale non è un duplice strumento di lettura di una realtà, piuttosto la partecipazione a due mondi culturali e fisici che, esattamente come le due lingue, sono in conflitto. Du Bois la definisce two-ness, una sorta di partizione, di doppia coscienza: “Two souls, two thoughts, two unreconciled strivings; two worring ideals in one dark body, whose dogged strength alone keeps it from being torn asunder”. Da questa idea deriva, in parte, la caratterizzazione di Ayesha, una delle protagoniste del mio romanzo, che vive appunto tra due confini, due lingue, due geografie, due famiglie, in una frammentazione che da significante si fa significato.
L’idea di lingua bucata di Lacan evoca altre immagini: quella del broken english, ad esempio. Uno scrittore americano mi diceva che per lui non c’è nulla di rotto nell’inglese non-standard. Pur essendo complessivamente d’accordo col suo pensiero, io penso che ci sia nell’utilizzo di quella lingua una crepa identitaria mai del tutto rimarginata. Si può forse a questo punto dire che una trasformazione della lingua parlata equivale anche a una trasformazione dell’identità. Gloria Anzaldua in Terre di confine scrive che “per un popolo che non può identificarsi interamente né con lo spagnolo ufficiale (formale, castigliano), né con l’inglese ufficiale, cosa resta da fare se non creare una propria lingua? Una lingua a cui possa connettere la propria identità, in grado di comunicare le realtà e i valori considerati importanti – una lingua i cui termini non siano né español ni inglés, ma tutt’e due insieme. Parliamo un patois, una lingua biforcuta, una variazione di due lingue”.
“Chi attraversa un confine linguistico fa quasi sempre un lavoro di traduzione del sé, che è un processo tanto difficile quanto consapevole. Quindi alle volte mi domando se fare psicoterapia in una lingua diversa da quella materna non possa celare il pericolo di una dissimulazione, di cattiva traduzione dell’Io”.
Nella prefazione a I dannati della terra, il filosofo francese Jean-Paul Sartre racconta di come la furia e l’ira pervadano la mente del colonizzato, che però le rifugge: è una “furia rattenuta” che gira a vuoto e sconvolge gli oppressi. Contro sé stessi, ricorrono al soprannaturale, ai riti di possessione, difendendosi dall’alienazione coloniale attraverso l’alienazione religiosa: l’allucinazione (o, come preferisco chiamarla io nella finzione narrativa, immaginazione) aiuta a costruire loro un altrove, una realtà parallela, in cui possano sopravvivere e sfuggire alla violenza della colonia, della migrazione, dell’esilio.
L’altro giorno a una presentazione ho discusso amichevolmente con un fisico sulla contrapposizione, nelle pratiche di guarigione, tra magia e psicofarmaco – come viene delineato in Acqua sporca. Sosteneva che mi avrebbe dato ragione se i riti magici e la psicanalisi fossero stati posti sullo stesso piano: ma non lo psicofarmaco la cui efficacia viene determinata dal metodo scientifico. Protestavo che il metodo scientifico, per come lo conosciamo, è un prodotto del sapere occidentale, e in quanto tale contestabile. Siamo giunti a una tregua quando mi ha molto argutamente chiesto se ritenessi la matematica una scoperta o un’invenzione. Ecco, sì, io considero la matematica – e ogni altra forma di sapere linguistico – un’invenzione che, come per tutte le produzioni umane, funziona in un dato sistema quando e se tutti la eleggiamo a legge naturale o universale.
Per questo ritengo che un cambio di paradigma nei discorsi intorno alla salute mentale passi necessariamente attraverso la lingua. Non si tratta solo di fornire interpreti – benché questo sia essenziale – ma anche diverse interpretazioni, di ripensare radicalmente le epistemologie, i concetti, le parole stesse con cui nominiamo il disagio.
Termini come “mindfulness”, “boundaries”, “self-compassion” dominano il discorso contemporaneo sul benessere, tutti formulati in inglese, tutti radicati in contesti occidentali. È un linguaggio clinico che sembra suggerire che il disagio mentale sia privo di patria, come se si presentasse uguale a sé stesso ovunque, in Norvegia come in Cina, e potesse essere curato ricorrendo alle medesime tecniche. E perché certe pratiche di benessere fossero considerate valide (lo yoga, la meditazione, l’agopuntura, l’ayahuasca) hanno dovuto compiere un giro completo prima di atterrare nella lista di cure somministrabili in spazi neocoloniali.
Nel frattempo molte pratiche di guarigione collettiva, cerchi comunitari, terapie in dialogo con la natura, rimedi erboristici, pulizie spirituali, riti magici vengono demonizzati o delegittimati come “non scientifici” perché non rilevabili attraverso metodologie messe a punto in un altrove definito da assetti politici, culturali e sociali molto diversi. Questa cancellazione epistemica non solo ruba un’eredità culturale, di più, un’identità, ma impone soluzioni che potrebbero non funzionare per tutti.
Credits immagine di copertina: jälvporträtt, Åkersberga by Everlyn Nicodemus, 1982. Photograph: National Portrait Gallery London/Courtesy Richard Saltoun Gallery