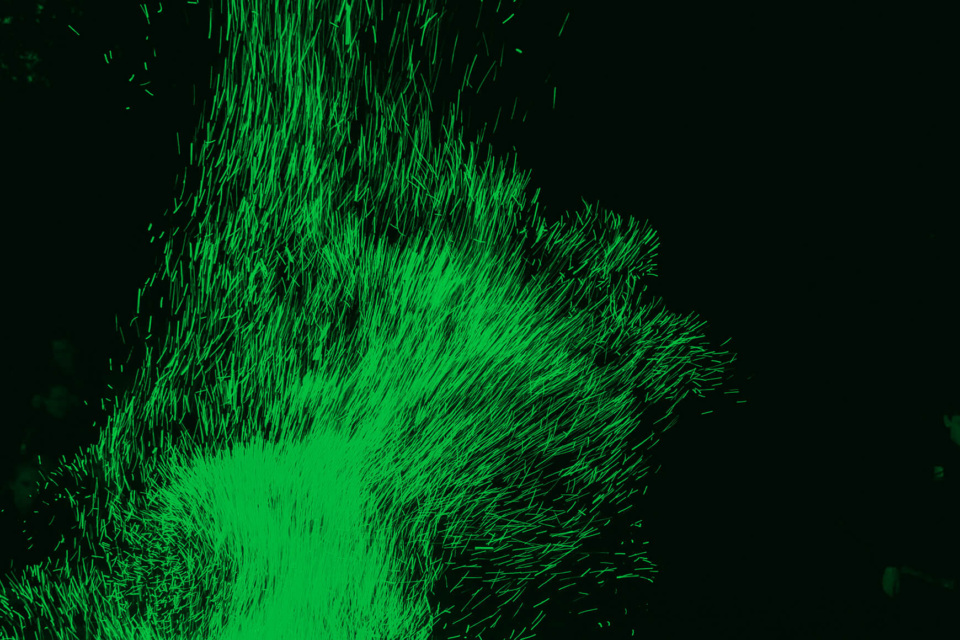Garland racconta gli USA lacerati dalla guerra civile attraverso il coraggio dei fotoreporter. Ma i personaggi sono macchiette e mancano riflessioni sulla natura della guerra, sul significato delle immagini e sul presente.
Civil War, l’ultimo film di Alex Garland, fa della realtà a cui si riferisce il suo principale motivo di interesse, esasperando il timore, più che legittimo, di una nuova guerra civile negli Stati Uniti d’America.
Non a caso il film è stato astutamente fatto uscire nelle sale il 12 aprile, data della battaglia di Fort Sumter.
Il film vuole dunque essere profondamente attuale, ma questa attualità distrae lo spettatore.
La prima volta che nel film vediamo la protagonista Lee Smith (professione: fotoreporter e anche tra le più brave, interpretata da Kirsten Dunst) è seduta sul letto di una camera d’albergo. Sullo schermo di un televisore, il presidente degli Stati Uniti d’America annuncia con fare tronfio i successi dell’esercito governativo sui ribelli.
Gli sforzi di convincere i telespettatori sembrano perlopiù vani: i sorrisi sono tirati, il tono vorrebbe essere fermo ma risulta affettato. Lo sappiamo perché, poco prima, abbiamo visto il presidente provare il discorso, cercare le parole giuste, il timbro più adatto alla persuasione. Ripreso di profilo, come da una macchina da presa di scena sul set, l’inquadratura va fuori fuoco per qualche secondo, alla ricerca di una resa più nitida. Pur non mettendolo a fuoco, sentiamo di averlo già inquadrato: forse è pazzo. Crediamo di riconoscere in lui Donald Trump? Epperò la pettinatura è diversa, i tratti più aggraziati… Il suo sguardo arrogante contrasta con quello impassibile di Lee davanti al televisore.
Lee Smith scatta una foto allo schermo; è già chiaro che la macchina fotografica è lo strumento che le permette di avere coscienza delle cose che accadono, che lei coincide con la macchina fotografica, che il suo lavoro le dà una postura e un fine. Simmetricamente sappiamo, senza saperlo davvero, che il presidente è bugiardo, violento e scorretto.
Lo spauracchio, nel prossimo futuro, di una guerra civile negli Stati Uniti è talmente forte che, anche chi si è informato distrattamente sul film, cercherà di verificare quanto realtà e finzione siano destinate a coincidere già dalla prima scena.
L’ultimo film di Garland, regista di Ex Machina e Men, è ambientato in un’America non troppo distante da quella odierna, dove è in atto una guerra tra le Forze Occidentali di Texas e California – con la loro bandiera americana rivisitata con due sole grosse stelle – e le forze del governo federale, sostenute da stati lealisti, New York, Arizona, California del Sud, Kansas.
A New York l’acqua è razionata, gli attentati sono all’ordine del giorno e lo è anche la violenza della polizia. A Washington il presidente, trincerato dentro la Casa Bianca, si difende come un animale ferito.
Il film racconta del viaggio da New York a Washington della coppia di giornalisti Reuters Lee Smith e Joel (Wagner Moura). Il loro obiettivo è intervistare il presidente prima che venga deposto, pare a breve.
Assieme a loro, l’anziano Sammy (Stephen McKinley Henderson), onorevole maestro del Nyt – nel film, una testata ormai svalutata, in crisi se non proprio sull’orlo del collasso, cosa che oggi pare implausibile, visto il successo di Wordle e Wirecutter – interpretato da Stephen McKinley Henderson, e una giovane aspirante fotoreporter, Jessie (Cailee Spaeny, già Priscilla nell’ultimo film di Sofia Coppola).
Jessie ha il mito della collega già affermata, alla quale, dopo un incontro fortuito, si appiccica come farebbe chiunque crede che il caso esista soprattutto per confermare la legittimità dei propri sogni e la fondatezza delle proprie ambizioni.
Lee non la vuole tra i piedi, il viaggio è pericoloso: ma non era forse anche lei così sfacciata e tenace da ragazza?
Si convince, si parte in quattro ma le preoccupazioni erano fondate: la macchina avanza lungo strade deserte, o popolate di cadaveri. Le auto sono rottami abbandonati, il cielo la notte è percorso da bombe, che se non fischiassero sembrerebbero lucciole.
L’avvicinamento a Washington è una graduale discesa negli orrori della guerra: torture, regolamenti di conti, nazionalismi, pulizia etnica. Cosa c’è alla fine di questo viaggio? Altro orrore o un nuovo inizio?
Civil War cerca nell’azione, nel movimento incessante, una chiave per raccontare il dramma dell’America divisa in fazioni distanti e sempre più inconciliabili. La scelta avrebbe anche senso: la conquista dello spazio, lo spostamento da un punto a un altro, la ricerca dell’ignoto oltre l’orizzonte, sono tratti fondamentali dell’americanità e del suo corrispettivo cinematografico, il western.
Nella convivenza dei personaggi in uno spazio ristretto e nella natura assieme pericolosa e rivelatoria del viaggio, Civil War riprende lo schema di molti film western del tipo film da camera in movimento, come li ha definiti il critico Alberto Crespi, del quale Ombre Rosse di John Ford è di certo l’esempio più riuscito.
“Civil War cerca nell’azione, nel movimento incessante, una chiave per raccontare il dramma dell’’America divisa in fazioni distanti e sempre più inconciliabili”.
Nonostante Garland sia britannico, Civil War è un film americano che più americano non si può: lo è per l’impianto narrativo e per il tema, la guerra civile in una nazione fondata sul fratricidio.
(D’altronde, il primo grande film americano della storia, The Birth of a Nation di David Wark Griffith, è anch’esso, a suo modo, un western e anch’esso si fonda sull’idea di un paese irrimediabilmente lacerato, che può trovare la pace solo nella sopraffazione di una parte sull’altra, nella sua sottomissione letterale e rituale).
Ma nel caso di Civil War, questo muoversi incessante non aiuta a mettere a fuoco i personaggi: chi sono, oltre ai ruoli che interpretano?
Una volta che li abbiamo conosciuti, siamo pronti a dimenticarceli o a confonderli con altri, visti o letti altrove.
Jessie è la giovane allieva, in gamba, talentuosa, ha il coraggio che serve a fare bene il mestiere. Lee è la venerata maestra, che la vita e il lavoro – per lei indistinguibili – hanno reso dura e tormentata. In questa famiglia che gli eventi hanno creato per il tempo limitato del viaggio, Sammy è il nonno, saggio e apprensivo; Joel il padre bamboccione ma cool, sempre con la sigaretta in bocca, la bottiglia di alcool in mano, lo sguardo sornione ma gentile. Oltre, non si va.
Di più: i personaggi sono subordinati alle loro funzioni, che in guerra sono tutto.
Come un tetto non serve più solo a riparare ma a uccidere dall’alto e una colonna di cemento non regge solo una casa ma si fa riparo dai cecchini, così le persone possono essere solo le loro azioni. Il soldato spara, il fotografo scatta.
A una stazione di servizio, Jessie e Lee si ritrovano davanti due prigionieri che, appesi per le mani e mezzi morti, penzolano da una struttura di metallo che in tempi di pace fungeva da autolavaggio. I loro aguzzini sono redneck in cerca soprattutto di una rivincita dalla loro condizione di inferiorità sociale e culturale (indicando uno dei due, il carceriere dice: “Eravamo a scuola assieme, ai tempi non mi parlava. Ora non sta mai zitto” alludendo alle suppliche che gli rivolge).
Davanti ai due prigionieri di guerra e all’aguzzino, Jessie è sigillata in un silenzio inquieto, paralizzante, pieno di angoscia. Lee invece fa posare il bifolco accanto ai prigionieri, orientando i corpi al fine di ottenere una composizione, e scatta una foto.
La lezione all’apprendista, turbata da questioni esistenziali, è deontologica, da ordine dei giornalisti: “Noi non facciamo domande. Noi registriamo quello che accade affinché siano gli altri a farsele”.
Lee scatta o cerca lo scatto giusto. Se non scattasse, smetterebbe di avere uno scopo. Senza scopo, si affloscerebbe come quei gonfiabili ad aria compressa che ondeggiano fuori da certi concessionari di auto.
Ma decenni di lavoro da fotoreporter la inseguono quando è più esposta e fragile, nel riposo, nel dormiveglia, nelle pause tra una foto e l’altra. Il silenzio e l’inattività favoriscono l’insorgere di ricordi traumatici: esplosioni, ammazzamenti, uomini cosparsi di benzina che prendono fuoco – sono inserti sbrigativi, di chi non ha tempo per articolare oltre il visibile un discorso più profondo sul trauma. Garland ha fretta, il SUV dei giornalisti deve ripartire. Anche Lee non può soffermarsi troppo sul suo dolore.
Quando, più avanti nel film, Lee comincia a porsele davvero, alcune domande, vediamo che qualcosa in lei si sta rompendo, che sta sconfessando se stessa. Col passare del tempo il suo volto corrucciato si distende; comincia a farsi apprensiva e materna nei confronti di Jessie, pronta a trasmetterle le sue conoscenze (ma quando Jessie le mostra le foto che ha scattato, Lee, incapace di articolare un giudizio più esteso, le dice solo “Bella questa!”).

Intuiamo, da alcune esitazioni improvvise nel lavoro e da questa graduale benevolenza, che è pronta ad abdicare, forse.
Come la sua protagonista, il film soffre le pause, i momenti di gruppo e quelli a due. I personaggi faticano a fare emergere la loro personalità attraverso i dialoghi, gli sguardi, i piccoli gesti. Quando ci riescono, lo fanno senza sottigliezza. La sera, attorno al fuoco, si dicono cose dimenticabili, già sentite, di maniera.
Meglio quando ripartono e stanno zitti: combattimenti, azione, tensione narrativa sono spesso ben congegnati.
Se la scrittura dei personaggi è sbrigativa, anche il contesto in cui sono immersi non sembra necessitare, per Garland, di approfondimenti. Cosa ha scatenato la guerra civile? Cosa la rabbia nelle strade? Cosa pensano i giornalisti di quello che accade? Nulla. Il dollaro americano vale meno di quello canadese, ma non sappiamo cosa ha portato alla svalutazione – la guerra civile ne è causa o conseguenza? Il film è destinato a giocare a nascondino con la realtà, ad alludere a essa nel tentativo di farsi convincente, utilizzandola come strumento di seduzione.
Garland ne è consapevole, per questo spariglia le carte, confonde. Ad esempio: come è possibile che Texas e California si siano unite in una nuova federazione? Pare strano, così come New York che sta dall’altra parte, quella dei lealisti – soprattutto oggi che le grandi città cosmopolite, somigliandosi un po’ tutte, sembrano essere l’argine più convincente ai populismi e ai fascismi, vantaggio non trascurabile della tanto vituperata globalizzazione.
Garland sostiene di aver voluto evitare, attraverso questa scelta, una lettura pigra e frettolosa da parte dello spettatore. La lettura pigra e frettolosa sarebbe però ampiamente giustificata dal film, che non fornisce altri appigli utili alla comprensione. Lo spettatore si ritrova così a doversi vanamente interrogare su questo elemento di distrazione, a speculare sulle ragioni di un’alleanza quantomeno bizzarra.
In una intervista al NYT, Garland afferma che la guerra civile è la naturale deriva della situazione di polarizzazione che gli Stati Uniti vivono ormai da anni. Questo è abbastanza ovvio. Ma mostrarla come conseguenza inevitabile non aiuta a comprenderne le cause.
Il Booker Prize 2023 è stato vinto, non senza discussioni, dallo scrittore irlandese Paul Lynch con Il canto del profeta (66thand2), romanzo che racconta di un’Irlanda sprofondata nel totalitarismo attraverso le drammatiche vicende della famiglia Stack, borghese, progressista e impegnata.
Il libro ha in comune con il film di Garland una certa attenzione per le conseguenze del totalitarismo, per gli aspetti concreti della sospensione dei diritti e della giustizia: sindacalisti che scompaiono, ragazzini ammazzati, orfane, vedove, mancanza di cibo e acqua, conformismo che a volte è strisciante e altre violento. Sia Lynch sia Garland si concentrano sulle rovine della democrazia, non sulle ragioni che hanno provocato il crollo. Entrambe le opere mancano di un impianto analitico forte ed evitano di soffermarsi sui retroscena e sulla politica, se non nelle sue manifestazioni burocratiche o di consenso popolare.
Lynch prende per la collottola il lettore, lo fa accucciare a terra, obbligandolo a guardare la materia oscena del dolore dei suoi personaggi. Non va per il sottile, ma l’obiettivo è chiaro: coinvolgere il lettore in un esercizio di empatia radicale, totalizzante…
“Il film è destinato a giocare a nascondino con la realtà, ad alludere a essa nel tentativo di farsi convincente, utilizzandola come strumento di seduzione”.
Garland non sembra voler andare oltre una constatazione abbastanza semplice: la guerra civile è una forma quasi assoluta di male, un virus endemico della democrazia nella sua fase terminale. Essendo un virus, le due fazioni in lotta finiscono, a tratti, per contagiarsi e quindi per assomigliarsi.
Ogni società si forma per sostituzione, per uno scarto sulla precedente, che difficilmente può essere indolore. Quella americana, forse, si è cristallizzata anche nell’accettazione della convivenza con un nemico un po’ reale e un po’ immaginario. Lo sconfitto rimane come fantasma, sintomo, sfogo represso, potenziale minaccia (e anche questo aspetto, forse, ha una sua attinenza con la vastità del territorio statunitense: il nemico c’è anche quando non si vede, in un altrove che lo sguardo, nella sua limitatezza, non può afferrare).
Qualche anno fa Adelphi ha meritoriamente pubblicato, nella traduzione di Francesco Pacifico, Lo stile paranoide nella politica americana di Richard Hofstadter, una conferenza tenuta nel 1963 e pubblicata per la prima volta l’anno successivo che, nella sua brevità, riesce a fissare con esattezza la violenta tendenza complottista che attraversa la politica americana (ma che è simile dappertutto).
Dietro la tendenza complottista, c’è uno stile di pensiero che Hofstadter chiama paranoide per sintetizzarne alcuni attributi fondamentali: l’esagerazione, la sospettosità, la sfrenata fantasia cospiratoria.
Secondo Hofstadter, uno dei tratti che accomunano i racconti complottisti di vario genere, è la natura bifida del nemico. Questo nemico è sempre tratteggiato con nettezza, è un perfetto modello di cattiveria, “amorale, sinistro, ubiquo, crudele”.
Talmente forte da orientare la Storia, vista dal complottista come frutto di una pura, incrollabile e decisiva volontà da parte dell’avversario.
Questo nemico, fa notare Hofstadter, possiede spesso un tipo di potere particolarmente insidioso: controlla i mezzi di informazione, può influenzare la mente o esercitare una particolare forma di seduzione (un esempio: il confessionale cattolico).
Questo nemico imbattibile si prefigura come una proiezione del sé, sia negli aspetti ideali sia in quelli inaccettabili. Soprattutto: è preso a modello. Per dirla con le sue parole, il paradosso fondamentale dello stile paranoide è “l’imitazione del nemico”. Se esso è un intellettuale, il complottista lo supererà per erudizione e pedanteria (il senatore McCarthy, ad esempio, con la puntigliosa ponderosità dei suoi dossier, gli antimassoni con i loro “logoranti ragionamenti sul rituale massonico”, i cristiani anticomunisti che lodavano l’impegno e la disciplina della controparte, fanno tutti un elogio, più o meno esplicito, delle qualità degli avversari).

“The Great Train Robbery” di Edwin S. Porter (1903)
Anche in determinazione, crudeltà, spregiudicatezza e volontà di attuare la Storia, i complottisti devono dimostrarsi all’altezza dei loro avversari.
Quando un ribelle giustizia dei prigionieri dell’esercito, la camera lo inquadra frontalmente; mentre spara, guarda in direzione dello spettatore – come accade nella prima scena di uno dei primi film mai realizzati in America, The Great Train Robbery –; la bocca è spalancata dall’eccitazione, l’occhio acceso da un bagliore luciferino.
In un’altra scena, due cecchini, appostati in un giardino, tra l’erba alta e i fiori – ancora, per un attimo, la camera va fuori fuoco, mentre Kirsten Dunst li guarda, trapassandoli, persa altrove, forse nell’infanzia, forse in un futuro impossibile lontano dal lavoro – sparano a una casa dove un altro uomo armato, barricato dietro le finestre, gli rende la stessa cortesia. Non sanno chi ci sia in quella casa. Non sanno in cosa crede o chi sostiene: non gli interessa. Dicono solo: “Ci sta sparando, noi spariamo a lui”.
In guerra conta rimanere vivi. Chi ha un fucile ed è intenzionato a usarlo ha più cose in comune con il suo nemico che con un pacifista (chi non ha ancora visto il film, rimanga fino alla fine).
La tendenza a leggere la politica americana attraverso la lente del disturbo psichiatrico è oggi particolarmente incoraggiata dagli eventi – Trump è solo, all’apparenza, il più disturbato tra i disturbati o il disturbo più visibile e spettacolare. Nel territorio brumoso e opaco della psiche, Garland sembra trovarsi a suo agio. Lo spettatore dei suoi film meno.
Esponente di punta del cosiddetto elevated horror – chissà perché questa esigenza critica di elevare generi che già funzionano in quanto tali, come se una patente di ricercatezza bastasse ad accrescerne il valore – , Garland sembra sempre voler mostrare che, oltre alle immagini che crea, c’è di più, che ci sono sempre dei sottotesti, che lui ha pensato a una cosa che forse suggerisce ma non ci mostra, che dietro, oltre il visibile, c’è un’architettura complessa, una serie di simboli da decifrare. Noi vediamo lo sforzo, ma non il risultato compiuto.
Men (2022) è un folk horror psicanalitico che ha come protagonista la cultura patriarcale, pieno di simboli, allusioni, allegorie e trovate francamente ridicole – la scelta di far interpretare tutti i personaggi maschili allo stesso attore, camuffato ora con denti finti, ora con parrucche; un mostro nudista coperto di foglie e muschio che dovrebbe forse rappresentare il maschilismo incarnato ma pare un Arcimboldo in uno spot dei sottaceti Saclà; un finale confuso e pieno di insulse lungaggini. Finito il film, chi non è un maschio tossico medita di diventarlo.
Le sue velleità da Freud con la macchina da presa avrebbero potuto trovare in Civil War lo sfogo perfetto: raccontare la psicologia di una nazione in crisi. Garland però neanche ci prova e, in parte, lo si ringrazia per questo – perché la pedanteria è sempre peggio della superficialità.
È chiaro che gli unici a cui vanno davvero le simpatie di Garland sono i reporter. Il desiderio di onorarli è infatti una delle motivazioni che hanno ispirato il film. Per Garland, sta accadendo qualcosa di terribile alla stampa: “Volevo rendere i giornalisti, i reporter, gli eroi che sono”.
Ma se la democrazia è in crisi, la stampa può solo documentarne la resa? Mai nel film, nemmeno per un attimo, i personaggi discutono di idee, opinioni, prospettive.
“Nel territorio brumoso e opaco della psiche, Garland sembra trovarsi a suo agio. Lo spettatore dei suoi film meno”.
C’è in questo elogio di un giornalismo vecchio stile, coraggioso, fatto bene, un elemento di profonda inattualità, che contrasta con il presente a cui il film allude di continuo. Garland, detestando buona parte dei giornalisti di oggi, che considera “pieni di pregiudizi”, ne cerca una versione idealizzata nel passato.
Lee ha lo stesso nome di Lee Miller, forse la più celebre e significativa reporter del Novecento – ma reporter, per Miller, è una definizione riduttiva.
Gli smartphone non hanno nel film un ruolo significativo – non c’è campo, ecco la scusa perfetta – e anche Jessie scatta con una Nikon 35mm appartenuta a suo padre. La scelta è talmente passatista da risultare surreale e controproducente per il suo obiettivo: può essere solo il tipo di dispositivo utilizzato o una pettorina smanicata da giornalista a determinare la postura, il valore, l’integrità di un reporter?
Se fosse così, basterebbe una pipa per fare un buon detective.
Tra il 1942 e il 1945 Frank Capra dirige una serie di film commissionati dal War Department del governo americano. Al film di Capra, André Bazin dedica negli anni Cinquanta un saggio nel quale sviluppa delle intuizioni che il tempo non ha significativamente intaccato.
Nel corso della Seconda guerra mondiale, le nazioni in guerra, scrive Bazin, cominciano a prevedere l’equipaggiamento cinematografico del loro esercito allo stesso titolo dell’equipaggiamento militare. L’operatore accompagna il bombardiere nella sua missione, il reporter e il soldato condividono un destino comune, un’intima consapevolezza del pericolo, lo stesso rapporto di vicinanza con la morte.
Ed è questa non solo una rivoluzione tecnologica, ma un mutamento dell’identità stessa della guerra: sul campo di battaglia non si fronteggiano più solo due schieramenti rivali, ma se ne aggiunge un terzo, quello dei produttori di immagini che, con eguale immediatezza, può decidere, in parte, le sorti del conflitto in corso.
Con l’arrivo delle macchine fotografiche e dei cameramen in zone di guerra, si prepara l’inesorabile assalto delle immagini alla nostra percezione del reale. Questo assalto, che agli inizi era sporadico e annunciato, ha compiuto un salto di specie, trasformandosi in un’occupazione eterna: le immagini che un tempo documentavano gli orrori della guerra su «Life» o nei cinegiornali, oggi ci rincorrono dappertutto, in ogni momento, su ogni schermo. Abitiamo il dramma, più drammi, tutti i giorni, da una distanza che solo apparentemente – solo ingannandoci – ci fa sentire al sicuro.
Se le bombe non ci piovono in testa, ci entrano dentro: percorrono la strada ormai senza difese che dalla cornea passa dalla pupilla, raggiungono il cristallino, la retina e arrivano al cervello, dove la luce è diventata un grumo di impulsi nervosi.
Oggi – già da un po’ – siamo in una nuova fase, nella quale la tecnologia è capace di generare – o contribuisce a generare – derive antidemocratiche, ma può aiutare anche ad avere un accesso non mediato alle zone di conflitto. Delle immagini che ricorderemo del conflitto a Gaza, molte sono amatoriali, foto scattate col telefono, video sgranati trovati su Telegram o Instagram.
In questo contesto, Garland sembra temere una fatale strumentalizzazione delle immagini: proprio perché non sono mediate, dobbiamo dubitarne. Solo il reporter professionista può consegnarci un resoconto veritiero e imparziale di ciò che accade. Alla fotografia di guerra non chiediamo di essere allusiva, evocativa o suggestiva ma perentoriamente rappresentativa, di farsi resoconto fedele della realtà.
Ma il paradosso di questa argomentazione idealmente molto condivisibile è che, per raggiungere questo obiettivo razionale, la fotografia di guerra deve titillare degli umori profondi, suscitare in noi emozioni accese.
Non a caso, lo slogan di «Paris Match», il periodico francese che ha fatto la storia del fotogiornalismo, era: “Il peso delle parole, lo shock delle foto”.
Alle foto di guerra non possiamo resistere non perché mostrano la verità ma perché quella verità è talmente dolorosa e intollerabile che ci mette in crisi, ci obbliga a prendere una posizione – contro una delle parti in causa o contro la guerra in sé.
Nel suo saggio contro la guerra, Le tre ghinee (1938), Virginia Woolf osserva, a proposito di una delle fotografie che il governo spagnolo assediato mandava all’estero un paio di volte a settimana, che il soggetto raffigurato è talmente martoriato da essere irriconoscibile: potrebbe essere il corpo di un maiale.
Le immagini non sempre aiutano a comprendere l’orrore, ma usano l’orrore per ottenere la nostra adesione a una tesi. Se prendiamo la celebre foto di Robert Capa, Morte di un miliziano repubblicano, non possiamo non accordarle un enorme valore estetico.

“Il miliziano colpito a morte” di Robert Capa (1936)
La foto ritrae un combattente nell’atto di morire, colpito da un proiettile franchista. Le sue ginocchia si piegano, la presa della mano sul fucile si allenta, il corpo, sbilanciato, è pronto a cadere sulla sua ombra per non rialzarsi più. La foto è bellissima – per quanto possa essere bellissima una foto così straziante – ma soprattutto ci colpisce per lo statuto di realtà che incarna.
Come fa notare giustamente Sontag, la foto perderebbe ogni valore se dovessimo scoprire che il soldato sul punto di cadere ha recitato per l’obiettivo di Capa.
La nostra sofferenza si alimenta della realtà; senza di essa, non si verificherebbe con la stessa intensità. Per credere a una verità, quella verità deve colpirci visceralmente.
Tutto questo a prescindere dal fatto che una foto di guerra sia stata scattata da un reporter con la sua Leica o da un droghiere col suo telefono.
La scelta di Garland di ignorare il ruolo della tecnologia e gli smartphone è la naturale conseguenza di un approccio miope e doppio, che pur riferendosi di continuo all’attualità non fa il minimo sforzo per interpretarla, reimmaginarla o solo problematizzarla, limitandosi a riprodurne male una versione idealizzata, già vecchia.
“Alle foto di guerra non possiamo resistere non perché mostrano la verità ma perché quella verità è talmente oscena, dolorosa, intollerabile che ci mette in crisi, ci obbliga a prendere una posizione”.
Se i giornalisti oggi contano meno, quelli bravi dovrebbero essere destinati a contare di più. Questa la speranza, condivisibile, del regista.
Ma chi cerca nel passato, che per definizione non può tornare, una soluzione ai problemi del presente, non è poi così diverso dal più ottuso dei reazionari.
Garland non è certo un reazionario, è animato da buone intenzioni, ma dimostra, ancora una volta, di non essere un regista dei più sottili.