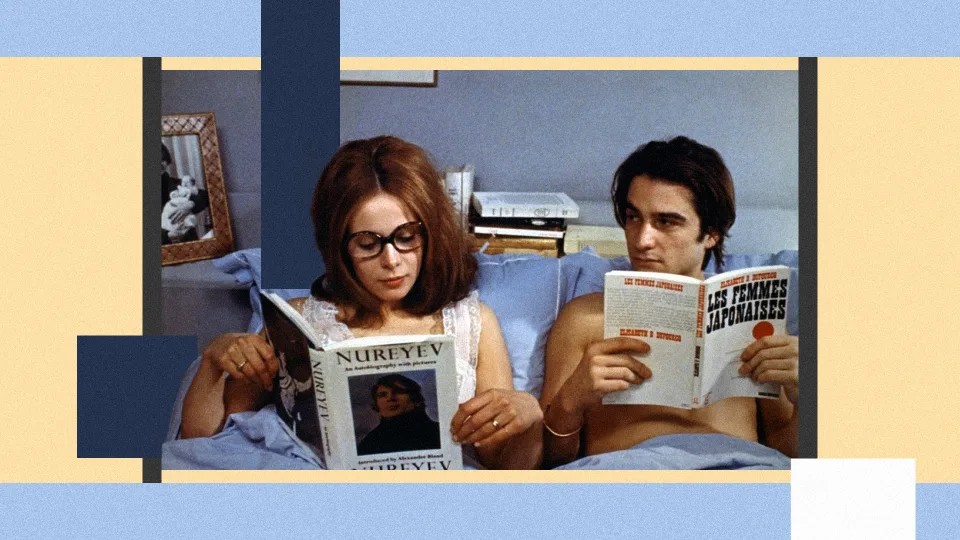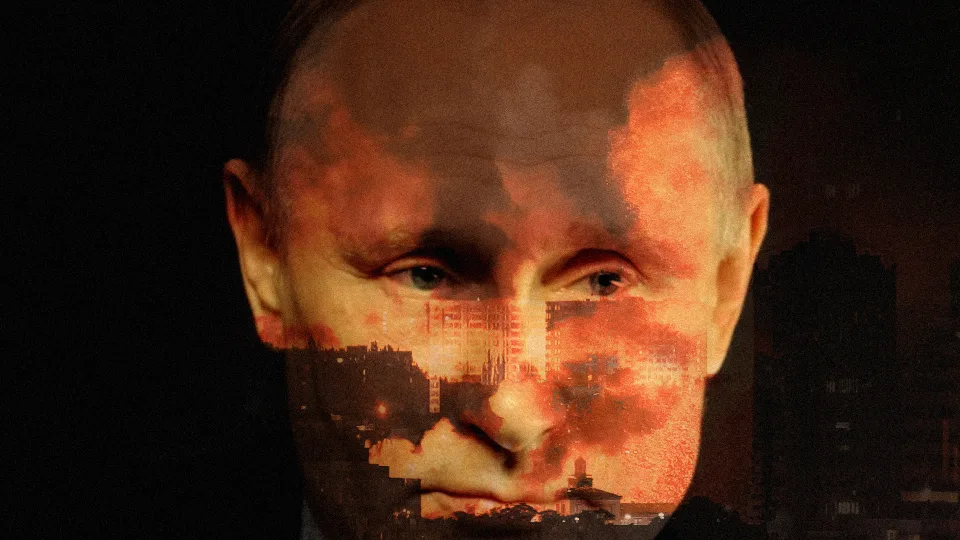Che ci piaccia o no, Gabriele Muccino, con i suoi film di successo e anche molto detestati, ha rappresentato una generazione.
C’è stato un momento, nei primi anni Duemila, in cui Gabriele Muccino era considerato l’emblema del “cattivo cinema italiano”. Nel 1999 era uscito Come te nessuno mai – il primo e forse più importante teen-movie fino all’arrivo di Tre metri sopra il cielo. Quando uscì L’ultimo bacio e, poco dopo, Ricordati di me, andavo al liceo. Frequentavo un corso pomeridiano di cinema organizzato dalla scuola; il docente, ogni volta che qualcuno scriveva un dialogo un po’ più carico, recitava in modo troppo enfatico o muoveva la camera a mano in modo troppo brusco, se ne usciva sempre con la stessa implacabile raccomandazione: “non stiamo mica qua a fare Muccino”.
Ai tempi, “Fare Muccino” era diventata quasi un’espressione idiomatica. “Fare Muccino” significava: scrivere personaggi impulsivi, nevrotici, forsennati, perennemente sopra le righe, esuberanti e sognatori fino al sospetto della stupidità. “Fare Muccino” significava mettere in bocca agli attori frasi pompose e declamatorie, spesso retoriche, e declamarle con tono esagerato e definitivo. “Fare Muccino” significava mettere i personaggi di fronte al bivio di una scelta decisiva. “Fare Muccino” significava mettere l’amore al di sopra di ogni altra cosa, e in nome dell’amore essere disposti a mandare all’aria tutto quanto. “Fare Muccino” significava trasformare Gabriele in un’unica entità bicefala col fratello Silvio e, ignorando che il film non fosse diretto dal primo ma solo interpretato dal secondo, andare in vacanza a Santorini a chiederci “che ne sarà di noi”. “Fare Muccino” significava pensare la propria vita come un precipitoso piano sequenza che si può girare una sola volta, e allora o la va o la spacca. “Fare Muccino” significava correre a perdifiato – sono pieni di corse, i film di Muccino – verso qualcosa che si scopre improvvisamente irrinunciabile per una felicità che non accetta compromessi e non va mai sottoposta a negoziati. “Fare Muccino” significava buttarsi, sempre, a qualunque costo, fino al rischio del ridicolo. “Fare Muccino” era, insomma, una colpa culturale, addirittura un modo di essere.
L’odio per Muccino l’ho poi ritrovato più e più volte, all’università e anche negli anni successivi, in ambienti culturali più adulti, ancora più avvelenato e astioso: Muccino come emblema di un cinema melenso e insulso, pariolino e piacione, enfatico e un po’ cafone, indifferente – se non ostile – a tutti quelli che vengono considerati i segni inequivocabili dell’Arte Seria e dell’Impegno. L’impressione è che su Muccino ci fosse una tacita licenza di sparare ad alzo zero: disprezzare Muccino era per tanti il riflesso automatico per assicurarsi un distintivo di alta cultura, una verità ovvia per chiunque volesse partecipare, anche solo da spettatore, al cinema d’autore; per lui si usavano aggettivi che affibbiati a chiunque altro sarebbero sembrati troppo livorosi, troppo netti; ma per lui no, quasi non erano abbastanza. A Muccino non si perdonava niente; e bastava un suo post facebook sul cinema di Pasolini, ad esempio, a scatenargli l’inferno contro: ma chiudi la bocca, come ti permetti a discutere i santi, coi film che fai. A me Muccino è sempre piaciuto, anche se ai tempi non avrei saputo argomentare le ragioni. Sospetto però che fossimo in tanti a guardare i suoi film quasi clandestinamente, come un vizio segreto e vigliacco, con lo stesso piacere con cui anni prima guardavamo Dawson’s Creek, godendo in privato, senza dirlo a nessuno.
Come in quegli stessi anni accadeva anche ad Alessandro Baricco, a Muccino non si perdonava forse il troppo successo: al botteghino sbigliettava come pochi, era arrivato a Hollywood, aveva diretto delle star, facile che stesse antipatico. Ma non era solo quello. Forse il carattere spavaldo, arrogante, forse quell’aspetto da golden boy romano a cui vanno tutte giuste, forse la storia d’amore con Elisabetta Canalis. Forse non gli si perdonava quella passione spudorata e adolescenziale per il presente che, a mio avviso, costituisce il maggiore dei suoi pregi: Muccino – caso raro fra i registi italiani più importanti – non ha mai fatto film in costume, e con l’eccezione de Gli anni più belli (che comunque culmina e finisce ai giorni nostri) i suoi film sono sempre ambientati nel tempo in cui sono stati girati. Anche a volergli male, a Muccino bisogna riconoscere quel merito che Tommaso Labranca attribuiva ad Ai Weiwei: “Almeno non fa parte del novero crescente di quei feroci nemici del presente, una categoria che ci perseguita da almeno trent’anni”.
Gabriele Muccino è stato volutamente e orgogliosamente pop. Non solo perché i suoi film li abbiamo guardati (e chi lo nega mente); è stato pop perché ha creato una di quelle divisioni manichee intorno a cui in Italia si costruisce la cultura di massa: scandalo per i colti, modello esistenziale per tutti gli altri, che in quei personaggi di “selvaggi sentimentali” (la definizione è di Javier Marìas) si riconoscevano o aspiravano a farlo. Tanto che oggi non saprei nemmeno dire se siamo stati noi che abbiamo cominciato a comportarci e a immaginare noi stessi come i personaggi di Muccino, o se è stato Muccino a cogliere per primo quello che stavamo per diventare: eterni adolescenti sclerotici e smancerosi, che in età adulta ancora si struggono per quell’amore del liceo, che detestano il proprio lavoro e accarezzano velleitariamente l’idea di aprire un chiringuito in Brasile, che si compiacciono nel regalarsi a vicenda il volumetto Adelphi di Siddharta e si dicono frasi come “ho bisogno di sentirmi vivo”, in quella lingua che sembrava così finta e invece era così vera proprio in quanto finta, perché proprio in quel periodo la gente aveva iniziato a parlare davvero così, un eloquio farlocco da soap opera erudita che Muccino sapeva padroneggiare meglio di chiunque altro, e che nei suoi film mostra tutta la sua quasi tragica fatuità. Che ci piaccia o no, Muccino è stato il regista che meglio di chiunque altro ha saputo raccontare l’Italia a cavallo fra i due millenni, l’Italia del berlusconismo più tartufesco e sciocco e tetro, l’Italia come parodistico scimmiottamento di un’America già in declino; l’Italia che inizia a scoprirsi piccola e misera e marginale: l’Italia del complesso d’inferiorità, l’Italia degli scintillii miserabili e dello show-business di provincia, l’Italia che inizia ad impoverirsi, a deprimersi, a mangiare male, a vestirsi male, a scrivere male, a sognare male.
Sì, L’ultimo bacio è uno di quei film che hanno visto tutti, anche se la sua importanza come opera formativa è ammessa con più imbarazzo di quanto accada con I cento passi o Le fate ignoranti. A rivederla oggi, questa storia di trentenni scriteriati e immaturi a cui molti, nella mia generazione, abbiamo finito per qualche momento per assomigliare, fa l’effetto di un fantasma anticipatorio: un’angosciante parabola di adulti infantilizzati e regressivi, insicuri e depoliticizzati, imprigionati dalla clausura di lavori asfissianti e detestabili, ossessionati da un’idea d’amore travolgente come unico rimedio a un’irrimediabile ordinarietà dell’esistenza. Nell’Ultimo bacio c’è già la classe disagiata di Raffaele Alberto Ventura e l’aporafobia di Adela Cortina; c’è già la tendenza – tutta contemporanea – a non politicizzare la propria infelicità, rovesciandola tutta sul piano privato, e in particolare su quello sentimentale. Le storie d’amore diventano il punto di fuga di vite altrimenti impossibili.
“Ai tempi, ‘Fare Muccino’ era diventata quasi un’espressione idiomatica. ‘Fare Muccino’ significava: scrivere personaggi impulsivi, nevrotici, forsennati, perennemente sopra le righe, esuberanti e sognatori fino al sospetto della stupidità”.
Non più la Politica né Dio né l’Arte, dunque, ma la Relazione Clandestina. Nessuno come Muccino ha fotografato il momento in cui abbiamo deciso definitivamente che delle sorti collettive non ce ne fregava più niente, che quella storia che non si può essere felici da soli ma solo tutti insieme era una cazzata; quel momento in cui tutti si sono buttati nel privato, chi a far soldi e chi a far corna, e chi s’è visto s’è visto. Per poi pentirsi, farsi male, capire sulla propria pelle che i soldi erano finiti e gli amori dopo due mesi già non tornavano più; questi sogni nuovi sono più storti e ottusi di quelli vecchi, non funziona niente, e si può solo cercare di tornare a quello che c’era prima: prima che le cose si rompessero, prima che rovinassimo tutto o che ce lo rovinassero gli altri, al bel tempo di quando ancora eravamo “noi”: coi nostri desideri ancora integri e nostri, coi nostri primari bisogni di felicità.
Il cinema di Muccino è, in fondo, questo grande sogno di ritorno al passato: un paradiso perduto indietro nel tempo, a cui disperatamente si cerca di tornare. I proverbiali eccessi di patetismo mucciniani vengono sempre da questo doloroso e spesso velleitario tentativo di recuperare gli sbagli del passato: il pubblicitario che si fa la scappatella con la diciassettenne ma poi rivuole la moglie, di cui in fondo era sempre stato innamorato; la donna borghese che riprende il vecchio sogno di diventare un’attrice teatrale; l’uomo in carriera che ritrova la vecchia fiamma del liceo e se ne innamora di nuovo; l’ingegnere aerospaziale che prova a espiare quel vecchio tragico sbaglio che non riesce a perdonarsi; i tre amici che si scoprono invecchiati e corrotti, e vorrebbero ritrovare l’innocenza di una volta. Tentativi di riallacciarsi alla giovinezza. Non è un caso che il riferimento autoriale più ricorrente in Muccino sia Scola: come lui, grande scrittore di rimpianti, frustrazioni, impotenze, sconfitte generazionali.
Il cinema di Muccino sembra un’enciclopedia dell’amore ma è, in fondo, un gran teatro della nostalgia. Un cinema che racconta sempre il perenne, disperato e sempre un po’ patetico tentativo di ritornare indietro: correggere quello che si è sbagliato, riafferrare quello che si è perduto, dare spazio a quello che si è tralasciato, continuare quello che si è interrotto. Ma non funziona mai. Quelle sue corse forsennate, a perdifiato, riprese di profilo in piano sequenza, non erano dirette al futuro ma al passato, e noi ce ne siamo accorti solo adesso.