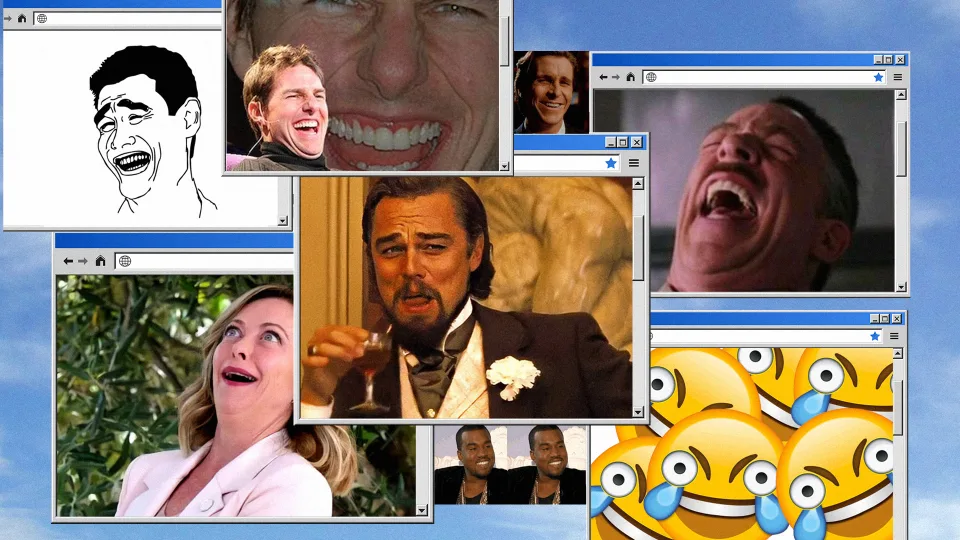Nel libro “Asia ribelle”, lo storico Tim Harper ripercorre le storie straordinarie di uomini e donne che cercarono di eradicare dall’Asia la “malattia” dell’inizio del Novecento: il colonialismo.
Febbraio 1915. Un mercante di seta indiano di stanza a Kobe, in Giappone, viene fermato dai soldati dell’esercito degli Stati Uniti a Zamboanga, nelle Filippine meridionali, all’epoca sotto il controllo di Washington. Gli americani lo accusano di essere un agente provocatore sotto copertura arrivato per scatenare la rivolta dei musulmani filippini, ma si sbagliano. Benché sia davvero un rivoltoso, non è musulmano e le Filippine non gli interessano. Il suo vero nome è Bhagwan Singh, rivoluzionario indiano di rientro dagli Stati Uniti in missione nel Sudest asiatico per organizzare la liberazione dell’India dalla stretta coloniale della corona britannica.
L’intrico non finisce qui: Singh è in attesa di ricevere dai tedeschi “un milione di fucili” e portarli nella regione del Punjab, dove lo aspetta un esercito di “tre-quattromila uomini”, altri agenti della rete rivoluzionaria indiana che si tengono pronti per insorgere “in tutte le parti del mondo dove vive la nostra gente”, il che all’epoca significava dall’Egitto a Hong Kong, da Vancouver a Lahore. Gli americani, constatando che Singh non ha commesso né sta per commettere nessun reato contro gli Stati Uniti e le loro colonie, lo liberano all’istante “pur confiscandogli baffi finti, parrucche, tesserini della polizia e da detective privato”.
Sono storie come questa, straordinarie eppure reali, che innervano le pagine di Asia Ribelle (add editore, traduzione di Anita Taroni e Stefano Travagli), il saggio dello storico inglese Tim Harper dedicato ai primi decenni del Novecento asiatico. Un mondo in cui la tenuta dei domini coloniali europei sta cedendo e le potenze imperialiste si ritrovano minacciate da una rete clandestina tanto vasta quanto sfuggente. Uomini e donne che per trent’anni seminano il panico dal Sudest asiatico al Canada, dall’Indocina a Londra, dal Raj britannico agli Stati Uniti, tessendo reti di spionaggio, traffici illegali, sabotaggi e attentati nel tentativo di “guarire” centinaia di milioni di persone affette dalla “stessa malattia”, scrive Harper, e cioè il colonialismo.
M. N. Roy, Phan Boi Chau, Tan Malaka, Nguyen Ai Quoc, Rash Behari, Har Dayal, Nguyen Tat Thanh sono solo alcuni dei protagonisti di un’epopea rivoluzionaria di cui in Occidente, nella migliore delle ipotesi, sappiamo poco. Perché guardare alla Storia da est a ovest è ancora un esercizio poco diffuso da noi: ci obbligherebbe a una rilettura della presenza occidentale in Asia, che è stata all’insegna dell’infamia, della tortura, dell’istituzione di infernali e disumane carceri come quello delle “acque nere” di Port Blair, la prigione inglese nel paradiso tropicale delle isole Andamane che per decenni ha inghiottito la dissidenza coloniale dell’Asia meridionale.
Per ricostruire le vite drammatiche di questo gruppo di illustri sconosciuti è servito allora il rigore accademico di Harper, che per anni si è immerso negli archivi di Stato di Francia, India, Malaysia, Paesi Bassi, Filippine, Singapore, Regno Unito e Stati Uniti incrociando dispacci dei servizi segreti, rapporti di polizia, lettere intercettate dalle autorità coloniali, foto segnaletiche, pamphlet e riviste clandestine. Nel volume in italiano, le sezioni “principali fonti d’archivio” e “note” occupano più di cento pagine.
Harper ricompone tutti questi frammenti con una scrittura da storia di spionaggio ma ci restituisce una cronaca dettagliatissima di eventi centrali nel processo di decolonizzazione del continente più popoloso del mondo, messi in moto da una dozzina di “freedom fighter” provenienti da territori che si sarebbero poi chiamati India, Pakistan, Vietnam, Indonesia, Malaysia. Condannati alla clandestinità perpetua, le loro esistenze si incrociano in quelli che Phan Boi Chau chiamava i “villaggi all’estero”, ovvero le comunità dissidenti di Singapore, Shanghai, Hong Kong, Tokyo, Berlino, San Francisco, Vancouver, New York, Parigi, Londra, Mosca attraversate da questi uomini in fuga con idee incendiarie.
Agli inizi del Novecento, quando l’anarchismo faceva sembrare tutto possibile, immaginavano una grande Asia indipendente, senza confini, cosmopolita, proprio come lo erano le loro vite al fianco dei lascari e dei coolie cinesi a bordo dei transatlantici imperiali. Scrivono e diffondo giornali e pamphlet sovversivi, talvolta si lasciano alle spalle una scia di sangue europeo e manuali per costruire esplosivi imbottendo le noci di cocco di polvere pirica e vetri rotti, chiodi, denti di pettini usati per la cardatura della iuta. Alcuni esaltano il potere salvifico della bomba, lo strumento con cui “gli schiavi possono ottenere la libertà” e unica via per “riportare in vita una nazione morta”.
Agiscono come fantasmi, approfittando di un’impreparazione sistemica del controllo coloniale che mai prima di allora aveva dovuto porsi il problema di chi fossero precisamente i sudditi dell’impero, di dare a tutti un nome, un’origine, una faccia per poter sorvegliare meglio i movimenti di una massa considerata informe, inferiore, mansueta, naturalmente predisposta alla subordinazione.
Solo quando le prime bombe esplodono, lavoratori e portuali scioperano e i sobillatori si dlieguano senza lasciare traccia, allora le autorità imperiali introducono i primi documenti d’identità e i primi registri di identificazione, inaugurando una tassonomia dei sudditi che si sarebbe poi diffusa in tutto il mondo assieme alla nascita degli Stati-nazione. Lo fanno per stanare i rivoltosi e istruire processi sommari a Lahore, a Londra, a San Francisco, per sedare sul nascere le ambizioni rivoluzionarie che minacciano il potere costituito. Ci riescono in parte: la lotta anticoloniale subisce una battuta d’arresto ma non abbandona i propri obiettivi, si limita a ripensarli in chiave pragmatica.
Il panasiatismo senza ideologie, religioni e confini diventa un’utopia e, braccati dalle rispettive autorità di competenza, i rivoluzionari asiatici iniziano a ridimensionare la portata dei propri sogni. C’è chi immagina una liberazione collettiva trainata dall’Islam, chi punta a una “Grande India spirituale”, chi cerca alleanze temporanee fondate su una comunione d’intenti urgente: prima cacciamo gli invasori, il resto si vedrà.

Nguyen Ai Quoc a Mosca insieme ai delegati al V congresso del Comintern, 1924 (Sputnik/Almay).
Tra il 1915 e il 1923 la prima guerra mondiale e la rivoluzione russa rilanciano gli sforzi antimiperialisti e offrono ai rivoluzionari clandestini nuove sponde ideologiche.
Nel 1918, il movimento islamico Sarekat Islam – due milioni e mezzo di iscritti in tutto l’arcipelago indonesiano – rigetta ufficialmente il “capitalismo perverso” e approva un “programma minimo” che comprende: “salari in linea con il costo della vita e senza differenze tra uomini e donne a parità di lavoro; settimana lavorativa di sei giorni e giornata lavorativa di otto ore; ferie pagate, assicurazione e fondo pensione; assistenza medica gratuita e indennità di malattia; congedo di maternità; fine delle sanzioni comminate dai datori di lavoro; divieto del lavoro minorile”.
Due anni dopo, nel 1920, viene fondata l’Associazione comunista delle Indie: è la prima formazione politica esplicitamente comunista del continente asiatico, fondata prima che in Francia, Italia e Gran Bretagna ci fossero “partiti comunisti ufficialmente attivi”. Prima la Prussia (in chiave anti-britannica) e poi la Russia bolscevica garantiscono un flusso di denaro costante che finisce nelle tasche di sindacalisti indonesiani, dandy indiani, comunisti olandesi spediti in Cina a governare una rivolta sempre più ispirata alla Rivoluzione d’ottobre. È una rivoluzione in cui anche le donne si ritagliano un ruolo da protagoniste ispirate da Wong Sang, la donna cinese che nel 1925 cerca di far saltare in aria un funzionario britannico di stanza a Kuala Lumpur con una valigetta esplosiva portata di persona sulla scrivania del burocrate: si salvano entrambi, ma il processo a carico di Wong lancia la moda della “donna col caschetto”, simbolo di emancipazione che immediatamente contagia gran parte dell’Asia orientale spingendo migliaia di donne a tagliarsi i capelli, abbandonare le famiglie e unirsi alla prima linea della guerriglia indipendentista.
Asia ribelle si chiude appena prima della deflagrazione continentale dei movimenti di liberazione. Il crollo degli imperi è all’orizzonte ma la generazione che aveva innescato la miccia della rivolta globale finisce quasi tutta in miseria. Tranne Nguyen Ai Quoc, meglio conosciuto come Ho Chi Minh, i rivoluzionari del “villaggio all’estero” muoiono soli, da falliti, dimenticati dalla Storia: “Al vincitore, un monumento nella piazza della città; allo sconfitto, una fossa nella foresta”. In questo senso Asia ribelle, oltre a fissare un nuovo punto di partenza per la ricerca storica, è la celebrazione delle vite di uomini e donne che per troppo tempo non siamo stati in grado di raccontare come meritano. E che oggi, un secolo dopo, hanno ancora molto da offrire a chi cerca la cura a una nuova “stessa malattia” che ci ha contagiato ben oltre i confini geografici del continente asiatico: il nazionalismo.
“Un mondo in cui la tenuta dei domini coloniali europei sta cedendo e le potenze imperialiste si ritrovano minacciate da una rete clandestina tanto vasta quanto sfuggente”.
Il freedom fighter indiano Har Dayal già nel 1915 metteva in guardia i suoi compagni rivoluzionari dal “culto della forza” e dalla “conquista del mondo” alimentati proprio dal “lugubre nazionalismo” dell’epoca. Oggi viviamo esattamente in quel mondo lugubre: le crepe dei sistemi democratici sono evidenti, il controllo è totale e la discriminazione delle persone migranti è la continuazione della “tassonomia dei sudditi” di epoca coloniale.
E se la cura oggi ancora non si vede, da qualche parte sicuramente esiste un “villaggio all’estero” – magari digitale – dove un gruppo di illustri sconosciuti e sconosciute già sta immaginando la prossima rivoluzione.
Domenica 17 novembre alle ore 18.30, Matteo Miavaldi e Marina Forti saranno in dialogo su Asia Ribelle, il saggio di Tim Harper, alla libreria Spazio Sette di Roma.
Nelle foto in copertina figurano: Aurobindo Gose nel carcere di Alipore, 1908 (Historic Collection/Alamy); Borodin a Canton, secondo da sinistra, con il suo assistente Zhang Tailei e con Wan Jingwei, 1926 (Fotografia di Fu Binchang. Per la gentile concessione ringraziamo C.H. Foo, Y.W. Foo e Historical Photographs of China, University of Bristol); Xian Jing-yu, capo della sezione femminile del Partito comunista cinese, giustiziata dal Kuomintang a Hankou, 1928 (Fonte sconosciuta); Tan Malaka, L’Indonesia e il suo posto nell’Oriente che si risveglia, Mosca, 1924 [Copertina del pamphlet di Tan Malaka, Indonezija i eë mestona probuždajuščemsja vostoke, 1924. International Institute of Social History, Amsterdam (1992/3905)].