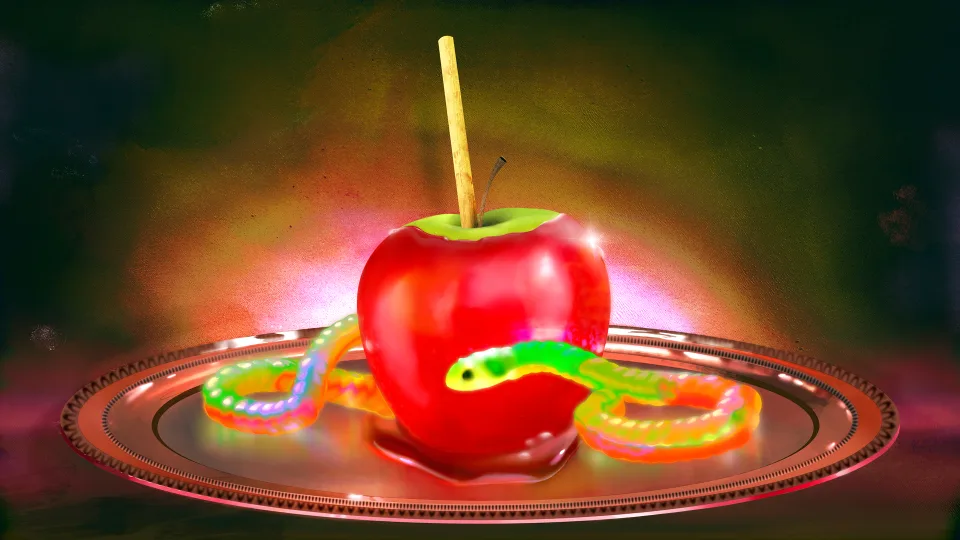A meno che la politica, che oggi finge impotenza, non contrasti davvero rendita e speculazioni dei privati.
Il 5 dicembre 2014, un gruppo di circa 280 persone – perlopiù famiglie con bambini, tra italiani, cinesi, marocchini, palestinesi e qualche cubano – occupa a Bologna una palazzina in via Fioravanti. L’edificio, che aveva ospitato gli uffici della Telecom, si trova proprio di fronte alla nuova sede in vetro del Comune, disegnata dall’archistar Mario Cucinella e inaugurata pochi anni prima. Alcuni sono facchini a servizio della logistica, quelli che oggi chiameremmo working poor, ovvero persone che lavorano ma non riescono a permettersi un affitto per via dei prezzi troppo alti.
“Prima di quel giorno – scrivono i Wu Ming sul loro blog – il problema abitativo a Bologna era un fantasma che non aveva consistenza.”
Il 20 ottobre 2015 circa duecento tra poliziotti, carabinieri e vigili del fuoco intorno alle 6.30 del mattino danno il via alle operazioni di sgombero. I bambini vengono portati fuori, alcuni trascinati dagli agenti in tenuta antisommossa; uno di loro è malato, ha un respiratore artificiale, e viene colpito da una crisi respiratoria. Fuori, per ore, la polizia carica chi prova a resistere con i collettivi sociali accorsi in aiuto. Dall’altro lato della strada, dietro un vetro, l’assessora al Welfare Amelia Frascaroli guarda la scena impotente. “Lo sgombero – dichiara il Sindaco per scagionare il Comune – è stato richiesto dalla procura ed eseguito dalla questura”.
La palazzina, di proprietà di un fondo immobiliare, viene acquistata un paio d’anni dopo dal gruppo olandese The Student Hotel (oggi The Social Hub), catena che ha portato in Italia il concetto di “ospitalità ibrida”, “Uno spazio” – come lo definiscono loro – “che unisce studenti, imprenditori, turisti e nomadi digitali in un’unica community inclusiva”. Inclusiva sì, ma sopra un certo ISEE: per una singola, infatti, il costo parte dagli 850 euro, 660 per una doppia.
Dieci anni dopo lo sgombero dell’Ex Telecom, alle prime luci dell’alba del 23 ottobre 2025, davanti a un condominio a due passi dalla Fiera di Bologna, in via Michelino 41, sono appostati decine di agenti con caschi e manganelli. Il palazzo, insieme a quello accanto, è stato acquistato da un gruppo imprenditoriale che, dopo averlo messo a nuovo grazie al Superbonus 110%, ha raddoppiato i canoni mensili, riconvertito le cantine in monolocali e trasformato alcuni appartamenti in Airbnb. Risultato: alla scadenza dei contratti, i vecchi inquilini sono costretti ad andarsene. Tutti tranne due famiglie con bambini che, dopo aver sperimentato sulla propria pelle l’ormai cronica assenza di alloggi a prezzi calmierati, restano lì per non finire in strada.
In un appartamento c’è Abdur, fa il fruttivendolo e vive con sua moglie e i tre figli, il più piccolo di 10 mesi. Nell’altro Hicam, impiegato di una ditta di ceramica a Pianoro, con moglie e due figlie adolescenti.
La polizia ha l’ordine di sfrattarli. Insieme alle famiglie, barricate in casa, ci sono gli attivisti di PLAT, che da anni portano avanti una tenace lotta contro l’emergenza abitativa.
Il resto è cronaca. Dai video che negli ultimi giorni sono stati molto ricondivisi sui social: si vede il proprietario del palazzo in testa agli agenti della celere che distrugge a martellate una parete della casa (pare per preservare la porta blindata di valore) e una volta radunati in strada gli inquilini, le manganellate inferte agli inquilini davanti ai bambini terrorizzati.
C’è un filo rosso che collega l’Ex Telecom a via Michelino e si chiama rendita. Anche solo dieci anni fa, operazioni immobiliari così spregiudicate e sfratti violenti come questi, sarebbero sembrati un’eccezione, ma oggi sono diventati la regola. Queste cose accadono nell’indifferenza generale, soprattutto della politica, che resta a guardare dalla finestra, impotente ma non innocente – non è infatti affatto esente da responsabilità, né a livello nazionale né locale.
Pochi anni dopo lo sgombero dell’ex Telecom, l’assessora all’Urbanistica Valentina Orioli vola al MIPIM di Cannes – considerata da molti una fiera della speculazione edilizia – per partecipare a una conferenza dal titolo Urban Renewal District: The role of public-private partnership to increase city attractiveness. Al tavolo, accanto a lei, siedono proprio i rappresentanti di The Student Hotel.
Come in molte altre città, anche a Bologna l’infatuazione per l’attrattività dei grandi capitali e l’idea che questi potessero risolvere i problemi economico-finanziari hanno trasformato la città in uno spazio sempre più esclusivo. E non si può comprendere la crisi abitativa odierna senza considerare l’impatto che, oltre alle piattaforme digitali, hanno avuto – e continueranno purtroppo ad avere – sul mercato locativo le grandi operazioni immobiliari: dagli studentati di lusso alla “valorizzazione” del mattone, spesso mascherata da rigenerazione urbana, sostenuta da leggi regionali che hanno di fatto sancito la fine della pianificazione pubblica (si veda per questo il volume Consumo di luogo, edito da Pendragon).
Anche a Bologna, infatti, mentre turisti e city users crescevano grazie a sapienti strategie di marketing territoriale progettate negli uffici comunali, mentre l’aeroporto accumulava utenti promettendo una crescita senza limiti (l’obiettivo per quest’anno è raggiungere la soglia degli 11 milioni di passeggeri, più del doppio rispetto a 15 anni fa), e aumentavano le risorse pubbliche per i servizi al turismo, gli airbnb e i ristoranti della city of food, sono cresciuti anche i prezzi delle case e le disuguaglianze.
Secondo l’inchiesta del 2024 Città del lavoro o città della rendita?, realizzata da Ires (l’Istituto ricerche economiche sociali della CGIL), nel capoluogo emiliano chi guadagna 1500 euro e non ha una casa di proprietà può considerarsi povero: “Il benessere – si legge nel report – autoalimenta se stesso acuendo la diseguaglianza”.
L’Osservatorio affitti di Nomisma riporta che dal 2021 “i canoni di locazione sono aumentati più della media nazionale con i nuovi contratti che registrano un canone medio di 813 euro (dati 2023) rispetto a una media nazionale di 541 euro”. Immobiliare.it ha invece rilevato che a settembre 2025 il prezzo medio per gli affitti residenziali è stato di 17,06 €/m², in aumento rispetto ai 16,64 €/m² di settembre 2024.
Oggi a Bologna – come racconta bene anche il libro Città in affitto (Laterza, 2025) – fanno fatica a trovare casa a prezzi dignitosi anche medici, forze dell’ordine e dipendenti comunali, che hanno annunciato uno sciopero nei prossimi giorni.
Sui quotidiani si moltiplicano le notizie di giovani lavoratori costretti a dormire nei pronto soccorso o nelle tende sotto il portico di una delle zone più ricche (e piene di multiproprietari) della città.
Per sfatare però la narrazione attualmente in voga su una presunta “fame di case”, che sembra preannunciare un nuovo boom edilizio e un ulteriore consumo di suolo, non sono gli alloggi che mancano – sebbene sia vero che moltissime siano ancora vuote (solo a Bologna sarebbero circa 18.000 le abitazioni inutilizzate o sottoutilizzate, secondo una stima di Crif) – ma canoni accessibili a salari stagnanti. Non sarà, quindi, cercando di attrarre nuovi costruttori in un contesto come quello attuale che le persone – i lavoratori – come Abdur e Hicam troveranno casa a prezzi decenti, ma iniziando a contrastare le condizioni che alimentano la rendita.
È paradossale, ad esempio, che proprio il denaro pubblico del Superbonus abbia offerto ai privati, come il proprietario di via Michelino 41, il pretesto per aumentare i canoni e airbnbzzare gli appartamenti.
Un recente studio condotto dai ricercatori Alfonso Carfora e Leo Fulvio Minervini e dal professore di Statistica economica dell’Università “Parthenope” di Napoli, Giuseppe Scandurra, dimostra che gli incentivi del 110% hanno favorito in massima parte i contribuenti più ricchi: “Basti notare – scrivono – che circa il 50 per cento delle detrazioni totali è stato richiesto da poco più del 10 per cento dei contribuenti più abbienti, caratterizzati da elevati redditi, consistenti patrimoni immobiliari e adeguata capienza fiscale”.
L’assenza di criteri sociali, assieme a tutte le detrazioni, i bonus, gli sgravi e gli incentivi statali che negli anni hanno prosciugato le casse pubbliche a favore della proprietà (cfr. Sarah Gainsforth, L’Italia senza casa, Laterza, 2025) smentisce chi oggi sbraita sui social che “con la mia casa faccio ciò che voglio” o “facile fare i comunisti col culo degli altri”. Questo caso, come altri, è la dimostrazione che è la rendita privata a reggersi sul lavoro collettivo e non viceversa, e che anche i proprietari di immobili, in quanto tali, hanno un debito specifico verso le comunità e una responsabilità sociale che bisognerebbe in qualche modo richiedere loro, magari invocando una rivoluzione redistributiva della leva fiscale.
Come ha dichiarato a Radio Città Fujiko l’avvocata Maria Elena Scavariello, che ha seguito la vicenda delle famiglie di via Michelino, quelle persone continuavano a pagare l’affitto, come avviene in tutti gli sfratti per finita locazione, e quindi non privavano la proprietà di alcun diritto. Ma se è vero – aggiunge Scavariello – che “la Costituzione riconosce il diritto della proprietà privata, la subordina anche all’utilità sociale. Significa che c’è una gerarchia dei diritti e nello sfratto di ieri il diritto dei minori alla salute, alla scuola, alla serenità e ad avere una casa dignitosa non è stato preso in considerazione”.
“Il panorama degli sfratti -– spiegava Mariangela Ventura, dell’associazione inquilini e abitanti di Milano a Napoli Monitor – è cambiato dopo la liberalizzazione del mercato privato con la legge 431 del 1998. Prima di allora c’era l’equo canone, i prezzi degli affitti avevano dei tetti massimi in base al territorio e si riusciva a non avere troppe persone inadempienti al canone d’affitto. Dal 2001 in poi, c’è stato un innalzamento crescente della morosità e si è passati dai dodicimila sfratti per morosità del 2000 ai settantamila del 2014. Inoltre, dal 2020 a oggi si assiste a un aumento delle disdette dei contratti vecchi. Questo comporta un maggior numero di esecuzioni di sfratto per finita locazione perché le persone a cui viene data la disdetta, a causa dell’aumento dei prezzi, non riescono più a rientrare nel mercato degli affitti, cioè non hanno le garanzie che vengono richieste dalle agenzie immobiliari e dalla proprietà”.
Il Decreto Sicurezza approvato nel 2025 dal governo Meloni ha aggravato ulteriormente la situazione, accelerando le procedure di sfratto e introducendo il nuovo reato di “occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui” (art. 634-bis c.p.), punito con reclusione da due a sette anni.
A Bologna, secondo i dati del Sunia (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari), nel solo 2024 sono stati eseguiti 635 sfratti, di cui 58 per finita locazione (nel 2023 erano stati appena 18).
La vicesindaca con delega alle politiche abitative di Bologna, Emily Clancy, denuncia la latitanza dello Stato: “Le risorse stanziate dal governo per il tema della casa sono assolutamente insufficienti. Si parla di 600 milioni di euro a livello nazionale, quando il solo Comune di Bologna, per il proprio Piano per l’Abitare, ne ha stanziati 200”.
Un piano che, tuttavia, resta in gran parte subordinato all’intervento dei privati: dei 10.000 appartamenti previsti, 5.000 saranno di edilizia privata e 2.000 destinati alle “alte professionalità” – cioè ai redditi alti – che dovrebbero arrivare per lavorare al Tecnopolo, il nuovo centro gravitazionale della città che sta già portando in alto i prezzi del Quartiere San Donato, in cui si trova anche il palazzo di via Michelino. Il resto, circa 3.000 alloggi, sarà perlopiù housing sociale (ERS), pensato per chi guadagna troppo per un alloggio popolare, ma troppo poco per il mercato libero. La grande assente rimane, come ovunque, l’edilizia residenziale pubblica (ERP), nonostante oltre 5.000 aventi diritto in lista d’attesa.
Sul piano nazionale, nella bozza della nuova Legge Finanziaria è comparsa l’ipotesi di aumentare la cedolare secca per gli affitti brevi (inferiori ai 30 giorni) dal 21 al 26%. L’aumento riguarderebbe il primo appartamento affittato, poiché per i successivi l’aliquota è già al 26%. La misura ha fatto infuriare Lega e Forza Italia, che di tasse sulla rendita non vogliono sentir parlare.
Come spiegano gli attivisti veneziani di OCIO, il punto è l’iniquità del regime fiscale: chi affitta con cedolare secca può scorporare il reddito da locazione dal proprio reddito complessivo, eludendo la progressività. In pratica, una flat tax.
“La verità – scrivono – è che, se proprio si vuole ripristinare una tassazione più giusta, anche rispetto alle differenze che corrono tra i diversi proprietari-locatori, la soluzione è una: cancellare la cedolare secca per i redditi da affitto breve. Non sei ricco ed integri il tuo magro reddito con l’affitto di una piccola seconda casa? Pagherai secondo la tua aliquota, proporzionalmente molto meno del ricchissimo che affitta la seconda casa in centro a Milano, che invece sinora ha pagato esattamente la tua stessa aliquota (del 21%!). Alla faccia dell’equità e dell’integrazione del reddito».
Intanto però il tempo passa e la rendita distrugge le città a colpi di piccone.
*Poche ore dopo lo sfratto di via Michelino, la rete di attivisti e attiviste PLAT ha occupato uno stabile di via Don Minzoni 12, portando all’interno 142 persone, di cui 72 minori, tutte in emergenza abitativa. La scelta non è casuale: il palazzo è l’ex Aiuto Materno, un edificio imponente di proprietà pubblica – più precisamente di ASP Città di Bologna, l’Azienda dei Servizi alla Persona del Comune – oggi destinato a diventare “Molo Bolo”, un nuovo studentato “ibrido” gestito da una società belga, la Life NV, cui ASP ha ceduto il diritto di superficie per 99 anni.
Il progetto prevede circa 300 alloggi, di cui solo il 30% a canone calmierato. Il resto sarà a prezzi di mercato, cioè fuori portata per chi oggi è senza casa.
L’assessora al welfare Matilde Madrid ha definito l’occupazione una “provocazione”, sebbene a provocare sia stata ASP, che, invece di garantire un uso sociale del proprio patrimonio, ha scelto di consegnarlo per un secolo a un soggetto privato trasformandosi in azienda di servizio alla rendita.