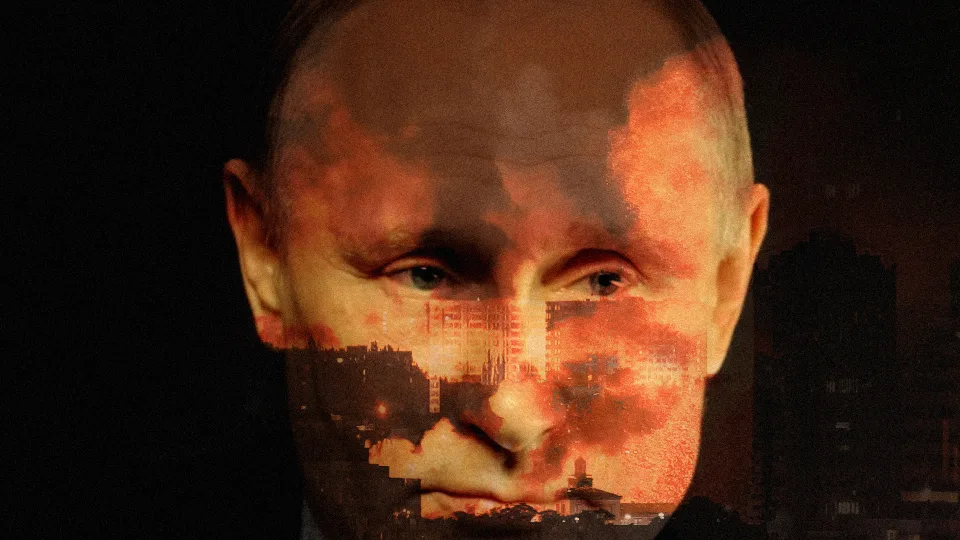Esistono tante teorie e pratiche pensate per aiutare a superare un evento traumatico o particolarmente stressante. L’EMDR, scoperta da Francine Shapiro alla fine degli anni Ottanta, è una di queste. In cosa consiste? Funziona davvero? Il racconto di una tecnica molto popolare, affascinante e controversa, nelle parole di chi l’ha provata.
Ho scritto un libro autobiografico scaturito da un dolore: mio padre non mi parla da molti anni e mi sembra di non sapere il perché. Mio padre è stato – ma a volte non sono sicura neanche di questo – un padre duro. Forse – mi sembra invece di sapere – è per via del materiale difficile, per via dei ricordi difficili che ho cercato di ritrovare durante la scrittura, che alcuni sintomi delle mie fobie sono aumentate. La mia fobia più grande è sempre stata quella degli spazi chiusi, ma se prima di scrivere questo libro non riuscivo a prendere alcuni tipi di ascensore, quando ho consegnato il manoscritto non riuscivo più a prendere nessun tipo ascensore e neanche a usare le scale di servizio – comprese quelle con le maniglie antipanico. Dovrebbero essere porte appunto antipanico, perché non possono mai bloccarsi, neanche quando sei in panico; a me scatenavano il panico. Non riuscivo a chiudere la porta dei bagni, a stare in stanze con le porte scorrevoli chiuse – ce ne sono molte più di quanto uno ragionevolmente potrebbe aspettarsi – non riuscivo a entrare nei tornelli girevoli: quindi in banca, in molti alberghi, in alcuni aeroporti. Non riuscivo a stare seduta dietro in macchina. A chiudere la porta di casa a chiave nel caso non fossi poi riuscita a riaprirla. Quando un giorno ho dovuto raggiungere un blocco operatorio perché mio figlio veniva operato d’urgenza e nonostante la sua e la loro urgenza, ho dovuto farmi accompagnare da una infermiera per sette piani di scale – accentrando su di me l’attenzione che avrebbe meritato mio figlio e sottraendo l’infermiera a chi ne aveva più bisogno – ho pensato che di essere comandata dalla paura degli spazi chiusi o dei traumi del passato non mi andava più.
Alcuni amici avevano provato l’EMDR – acronimo di eye movement desensitization and reprocessing – per lavorare su traumi molto specifici e molto chiari, che comandavano, decadi dopo, il loro presente. Grandi perdite. Malattie. Incidenti quasi mortali. Shock evidenti e assoluti che marcavano nettamente un prima e un dopo nella loro vita. Un prima e un dopo l’incontro con la morte. A me non sembrava di avere un trauma molto specifico – quello che in EMDR, ma mi pare anche in molti altri posti, si chiama il trauma con T maiuscola. Mi sembrava di avere una notevole collana di traumi medi, con la t minuscola, alcuni dei quali erano legati ai miei genitori e quasi tutti gli altri agli adulti, maschi, che avevo incontrato quando i miei genitori non guardavano e, forse, avrebbero dovuto guardare. Maschi che si erano approfittati di me, dell’assenza di protezione, di una libertà che somigliava alla libertà ma anche alla distrazione, alla solitudine, all’essere trascurata. Sul momento nessun trauma e nessun abuso mi era parso un trauma o un abuso. Non l’avevo nominato. Non avevo consegnato l’evento e il mio dolore a nessuno. Avevo rapidamente trovato delle scuse, dimenticato la loro età e la mia, imparato a sentire l’oppressione sul petto, come avevo imparato altre cose di me come che spesso mi fa male la gamba destra o che alle cinque di pomeriggio ho fame. Da grande invece, a dirle ad alta voce e a scriverne, mi sono accorta che lo erano.
Quello che mi era accaduto da bambina e da adolescente avevo potuto viverlo in unico modo: cercando di non provare niente e di non pensarci mai più. Non avevo gli strumenti per capire cosa fosse successo e per processare e organizzare la miriade di pensieri e sensazioni che mi avevano travolta. Non avevo la forza di accogliere il male e il dolore – il male e il dolore che mi veniva fatto anche se non lo meritavo, il male e il dolore che scoprivo esserci nel mondo anche se non avevo avuto fino a quel momento nessun motivo per concepirlo – e quindi sono passata oltre.
“Sul momento nessun trauma e nessun abuso mi era parso un trauma o un abuso. Non l’avevo nominato. Non avevo consegnato l’evento e il mio dolore a nessuno”.
A quanto pare però, non sono passata oltre. Mi sono solo dissociata. La parola “solo” andrebbe tolta. La verità è che mi sono dissociata. Sono andata avanti con una parte di me che a volte sentiva sì quell’oppressione sul petto e non riusciva a respirare, ma per il resto funzionava bene. Non vista, non integrata, l’altra me, la me delle stanze del trauma, è rimasta nelle stanze del trauma a provare il terrore che aveva provato, per sempre. Da sola e inaccessibile. Almeno fino a quando non sono andata a cercare di riaprire la porta, chiusa a chiave o meno. Di ascensore, di tornello, antipanico. E sono andata a riaprirla proprio perché al presente non funzionava più stare chiusa dietro nessuna porta. Ero anche certa che nel giro di poco avrei cominciato a trovare claustrofobica non solo una stanza con una porta o una rampa di scale costellata di maniglioni antipanico, ma anche un parco, una foresta, il mondo. C’era sempre meno ossigeno, ovunque. A un certo punto l’ossigeno sarebbe finito del tutto.
“E’ come se all’inizio della vita fossimo un unico stelo” mi ha detto la psicologa al primo incontro. A quarantacinque anni non ero mai stata in analisi e non avevo mai intrapreso una terapia psicologica che mi portasse a parlare di me. Mi ero raccontata che approfondivo quel che c’era da approfondire con la scrittura. E che se avessi approfondito troppo avrei compromesso la maniera in cui arrivavano le storie. “Quando avvengono i traumi, lo stelo a volte si frammenta, fa gemme e steli altrove. Si dissocia”, ha continuato la psicologa. “Dobbiamo riunire lo stelo”.
Lo stelo si può riunire in molti modi, con molte terapie e con molti approcci ma io avevo appunto scelto l’EMDR. Da un lato perché i risultati degli amici mi colpivano e poi perché è una terapia relativamente breve e che ha a che fare con il corpo, e non solo con la parola. Visto che io la mia storia l’ho raccontata in vari modi, anche nei libri, e l’ho saccheggiata magari per un film o un racconto, una parte della dissociazione è stata di sicuro rinforzata dalla me che racconta il mio dolore non per curarlo o capirlo – per capire me e aiutare me – ma per raccontarlo agli altri, per intrattenerli, magari per far ridere, piangere. Per far funzionare un capitolo, un giro di frase. Il mio dolore approfondito così non è quindi esattamente il mio dolore, ma un simulacro, scelto, corretto e editato perché nel racconto funzioni. Perché le cause, gli snodi, gli atti e i payoff siano chiari. Ho cancellato o modificato alcune cicatrici. Certi lividi al plurale. Ho evitato di raccontare alcune ore e giornate terribili, in cui ho visto e sentito cose terribili. L’ho fatto perché anche quando si parla di sé non sempre si può o si vuole parlare degli altri, non sempre si può aggirare il problema emotivo, etico, legale o narrativo che chiamare in causa altre persone comporta. E non sempre raccontare tutta la verità – anche se raccontare la verità è comunque impossibile – nei libri funziona o è giusto, da nessun punto di vista. L’EMDR mi sembrava poter aggirare l’io narrante, che potesse distrarlo, così da non lasciarmi controllare del tutto la trama, le ellissi, i tagli, e le sensazioni che avrei provato. Nell’EMDR si parla forse meno e in più si fa – o si sta – in un’azione ripetuta e continua: si guarda a destra e sinistra seguendo una luce, o si tengono delle manopole in mano che vibrano alternate a destra e sinistra. E il lavoro sul corpo in generale mi attira di più di un lavoro in cui, per esempio, bisogna dialogare e la parola sta al centro di tutto.

Mi interessava anche la piccola storia – la leggenda forse – di come la possibilità di questa terapia fosse stata intuita dalla psicologa americana Francine Shapiro durante una passeggiata al parco di Los Gatos, in California, alla fine degli anni ottanta. Shapiro era diventata psicologa da poco: stava completando il dottorato in Letteratura alla New York University quando aveva ricevuto una diagnosi di cancro al seno. La diagnosi l’aveva fatta desistere dal discutere la tesi e le aveva fatto decidere di spostarsi invece in California per studiare psicoimmunologia e specializzarsi nella relazione tra stress e sistema immunitario. Guarita dal cancro, ormai psicologa, Shapiro aveva camminato in quel parco e mentre era stata sopraffatta da un ricordo traumatico, aveva osservato come il movimento degli occhi che stava facendo – da destra a sinistra appunto, per seguire il movimento delle foglie mosse dal vento – riducesse il disagio causato dal ricordo e le emozioni negative che da sempre vi erano collegate. Secondo Shapiro, muovere gli occhi in questa maniera, poteva forse aiutare lo scambio di informazioni tra i due emisferi cerebrali.
Partendo da questo presupposto, aveva condotto molte altre ricerche su se stessa, su volontari prima e pazienti poi, circa l’elaborazione adattiva dell’informazione. Secondo il suo paradigma quindi, il trauma che una persona subisce viene immagazzinato nella memoria insieme alle emozioni e alle sensazioni disturbanti di quel momento. Ma tutte le informazioni immagazzinate in modo non efficiente o integrato – sono tantissime ed elaborarle al momento è impossibile – restano in superficie all’interno delle reti neurali e non riescono più a connettersi agli altri ricordi. Le informazioni bloccate non vengono più elaborate e così continuano a scatenare disagio. L’obiettivo dell’EMDR è riattivare l’elaborazione e trovare una risoluzione diversa, grazie a nuove connessioni più funzionali.
Durante una seduta si ritorna allora al ricordo del trauma più e più volte e lo si elabora mentre si usano appunto forme di stimolazione alternata, per aiutare la comunicazione intra-emisferica. Dopo una o più sedute i ricordi traumatici possono essere desensibilizzati, perdono parte o molta della loro carica emotiva, i pensieri intrusivi iniziano a regredire, le sensazioni fisiche a perdere di intensità. Le cause non sono del tutto chiare e per questo l’EMDR è una terapia evidence based: semplicemente, guardando ai risultati, si è visto che pare funzionare. Dalla camminata nel parco di Shapiro a oggi, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2013, ha infatti riconosciuto l’EMDR come trattamento efficace per la cura del trauma: i cambiamenti neurobiologici che accadono durante le sedute sono ritenuti mappabili e confermano l’associazione tra i risultati clinici e i cambiamenti a livello delle strutture e del funzionamento cerebrale.
“Scegli un posto sicuro”, mi ha detto la psicologa alla quarta o forse quinta seduta. Avevo, come spesso lì dentro, le manopole dell’EMDR in mano ma le tenevo coi guanti di lana, che comunque, a sentire vibrare un po’ meno, mi pareva di rimanere più in controllo. Nelle sedute precedenti avevamo individuato alcune aggressioni chiave. Le sensazioni che avevano scatenato e cui non avevo mai più pensato apposta. La vibrazione alternata sui palmi doveva calmarmi, favorire la concentrazione – ho letto, che forse funzionano così anche i tamburi degli sciamani nelle cerimonie – e aiutare il cervello a rivivere il passato non permettendogli di complicare troppo il mio presente.
“Ho scelto un posto sicuro. Ho cambiato scenografia a certi ricordi. La terapia mi sembrava funzionare”.
Ho scelto un posto sicuro. Ho cambiato scenografia a certi ricordi. La terapia mi sembrava funzionare. Tornare sempre nelle stesse stanze al ritmo dei tamburi, e delle manopole anche. Attraversare la città ogni lunedì per andare a ficcarsi nel trauma non era ovvio o sempre desiderabile, ma riattraversarla dopo averlo fatto era sempre più facile e desiderabile. Così, settimana dopo settimana ho continuato ad andarci, a riaprire il passato e quindi alcuni spazi chiusi che nel presente finalmente soffocavano meno. La paura di avere paura non era più un tema troppo pauroso. Se mai lo era confrontare la rabbia e la delusione che non avevo mai affrontato, con le persone che non avevo mai affrontato. L’EMDR mi sembrava una terapia potente, efficace.
Fino a che ovviamente non ho iniziato a scriverne, dissociandomi credo un poco dall’esperienza, dalla pratica, dalla me che viveva a pieno la terapia senza raccontarla e senza per forza, o subito, farne teoria. Non raccontarla è durato di certo troppo poco rispetto a raccontarla. E per raccontare la terapia, credo di averne indebolito ulteriormente l’impatto cercando di sapere di più. Mi sono messa a leggere articoli e saggi sull’EMDR, ad ascoltare podcast sull’EMDR, ho scaricato playlist di Spotify con colonne sonore di ritmi EMDR.
Forse l’ho fatto per rimanere in controllo. Forse, oltre ai guanti di lana per ammorbidire l’esperienza della vibrazione, ho usato le solite strategie che mettono al riparo dal cambiamento. Mi ero detta che ne leggevo per curiosità – perché era rivoluzionario quello che stavo provando – ma forse volevo proprio fermare la rivoluzione, nella speranza di non modificare un equilibrio cui ero affezionata, lasciando che a comandare fosse il solito io narrante.

Ho continuato e continuo lo stesso a fare EMDR, ad attraversare la città per ritornare nelle stanze del trauma, a mettermi i guanti e a tenere le manopole in mano. E farlo a volte è ancora potente. Altre ho solo molto sonno. Nel frattempo ho visto i video di YouTube di un corso per terapeuti dell’EMDR e analizzato come il conduttore ha diviso la seduta in minuti e poi in atti. Ho studiato le registrazioni di alcuni elettroencefalogrammi durante il riposo, messi a confronto con quelli di una seduta di EMDR. Ho letto di come alcuni scienziati in queste mappature vedono che l’attivazione delle aree cerebrali deputate a elaborare il trauma, con l’EMDR, si trasferiscono da un emisfero all’altro. Altri propongono l’ipotesi del doppio-distrattore: “distrarre” la memoria somatica durante la rievocazione, permette di accedere alla memoria episodica. Elettroencefalogrammi alla mano, si vede anche che nella prima seduta di terapia c’è un’attivazione di aree prefrontali e limbiche, mentre nell’ultima quella di aree visive. La maggiore attivazione di aree sensoriali ed associative, temporali ed occipitali, dopo il ciclo di terapia, indica un’elaborazione della memoria traumatica più efficace e anatomicamente ristretta. Si passa cioè da zone frontali del cervello, a zone posteriori. Da livelli profondi e impliciti, a zone corticali ed esplicite. Tutto questo vuol dire: il risultato secondo noi c’è, si vede, la terapia EMDR, seppur controversa e ancora misteriosa, funziona, e le mappe lo mostrano.
Io anche credo che questa terapia funzioni, almeno con me funziona nel senso che mi sento meglio, ma non ne ho mai provata nessun altra e quindi non ho visto cosa succede quando comunque, in una stanza, si decide, finalmente e ogni lunedì, di affrontare il dolore. Con i tamburi vicini o meno, con le manopole che vibrano in mano o meno. So che di certo non mi sembra più di soffocare sempre e che per esempio le porte antipanico non scatenano più il panico. Mi sembrano anzi carine, ricordano delle bocche, delle risate.
L’ascensore però, va detto, non lo prendo ancora. Non so se ci vorrà più tempo. Se in terapia devo finalmente togliere i guanti e permettere alle manopole di funzionare meglio. Se dalle manopole devo passare alla stimolazione visiva che dicono tutti essere più potente. Dicono anche però, che la stimolazione visiva a volte fa venire la nausea e a me non va per niente di avere la nausea. Non so neanche se è obbligatorio sconfiggere proprio tutte le paure e riuscire per forza a salire su un ascensore. Se un giorno scoprirò che qualcosa di terribile mi è successo proprio in un ascensore. O se sono magari una sensitiva e in ascensore mi succederà qualcosa di terribile e quindi non salendoci, mi sto mettendo in salvo nel futuro… Non sono neanche del tutto certa che il passato sia il passato, il futuro il futuro e che il tempo nella forma in cui lo pensiamo, esista. Non conosco neanche la mappa del mio elettroencefalogramma – quali aree si sono attivate durante la mia prima seduta – e quali si attivano adesso. So però di certo che il mio elettrocardiogramma, con tutte le scale che faccio sempre, da sempre e che probabilmente farò per sempre, dice che il mio cuore, dal punto di vista fisico, sta una bomba. Saperlo mi fa stare bene, mi fa salire le scale per la terapia al lunedì bene, mi fa respirare tutto l’ossigeno che ora so di nuovo che c’è e che sembra mi potrà bastare per sempre. Che poi, anche il sempre, chi lo sa. Se esiste. Se serve che esista.