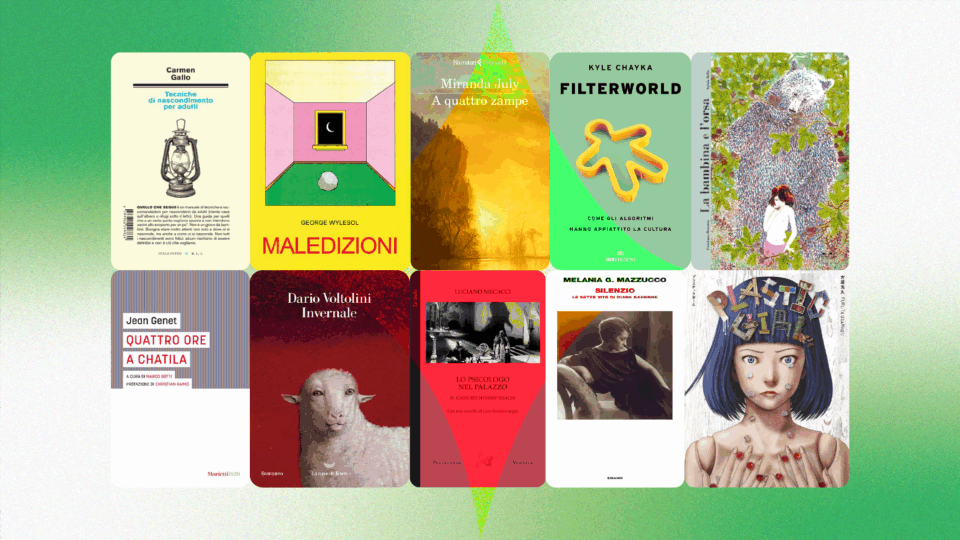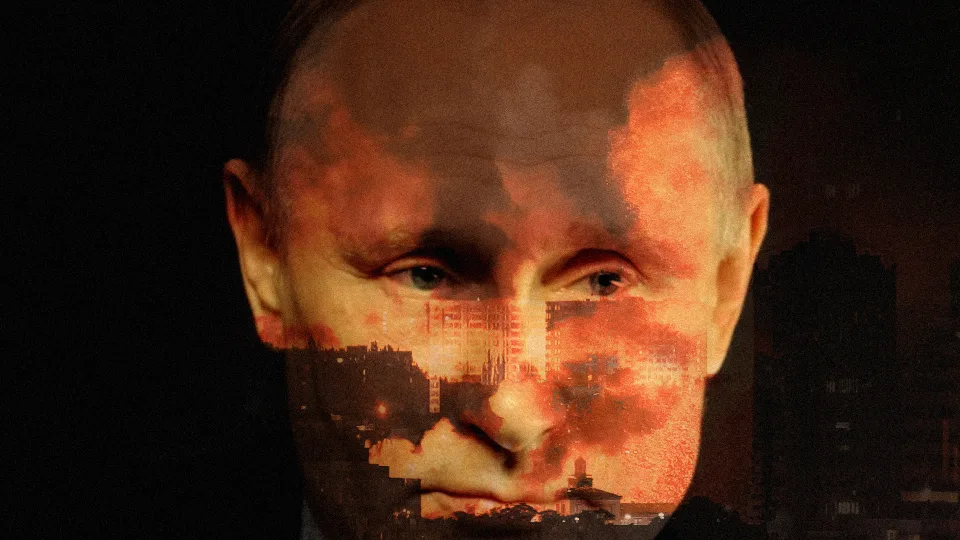Alcuni consigli letterari a cura della Redazione, tra loro diversissimi, dedicati a chi aspetta le feste per poter leggere un po' di più.
Quattro ore a Chatila di Jean Genet (Marietti 1820, nuova edizione, cura e traduzione di Marco Dotti, prefazione di Christian Raimo)
La strage di Sabra e Shatila si consumò tra il 16 e il 18 settembre del 1982. Le falangi libanesi massacrarono oltre duemila civili, perlopiù palestinesi e sciiti libanesi, con la complicità dell’esercito israeliano. Jean Genet arrivò a Beirut il 12 settembre, e il 19, all’indomani della strage, entrò nel campo profughi di Chatila. Si trovò davanti uno scenario da incubo e lo documentò in un modo mai sperimentato prima. Che cos’è dunque questo libro? Un documento? Un reportage letterario? Una poesia impossibile? Davanti alle tragedie della Storia, Genet si permette ciò che al giornalista e allo storico è interdetto, ma non a chi, usando la letteratura, rivela la realtà sotto una luce livida, scabrosa e sacra. Parole al calor bianco nel buio delle nostre vite.
Di Nicola Lagioia
Silenzio, Le sette vite di Diana Karenne di Melania Mazzucco (Einaudi)
È il 1914 quando una donna di nome Dina Karren giunge a Roma con un passaporto russo. Alloggia in un hotel sfarzoso di cui, a un certo punto, sa che dovrà capire come saldare il conto. Parla poco l’italiano e a Roma non conosce nessuno. Questo è l’inizio perfetto per il grande gioco, quello che richiederà a Karren di muoversi con astuzia e cuore, districandosi tra relazioni d’amore e rapporti professionali che via via la condurranno a liberarsi di sé e diventare un’altra, molte altre, mentre in Europa infuria la guerra.
Ma non corriamo: il primo livello del gioco richiede che Karren si faccia notare, che attragga l’attenzione di qualcuno disposto ad aiutarla. Non c’è occasione migliore della prima al Teatro Costanzi, dove sarà presente la crème de la crème romana e internazionale – per esempio l’ambasciatore imperiale dello zar di tutte le russie. Ma come fare senza soldi in un paese straniero? Tutte le donne presenti saranno ingioiellate e vestite all’ultima moda, tra cappellini elegantissimi e i fruscii seducenti delle gonne. Ed ecco il colpo di genio, uno dei tanti di Karren raccontati nel corso delle pagine di Silenzio, Le sette vite di Diana Karenne, scritto da Melania Mazzucco. La donna opterà per un abito semplicissimo che le lascia scoperte le braccia, e ciò su cui punterà sarà invece la sua testa. Ispirata da Maria Antonietta, si presenta a teatro con una parrucca bianchissima che, non appena spente le luci in sala, attirerà gli sguardi di chiunque, come una perla scintillante negli abissi, come un astro che indica la via di casa.
Melania Mazzucco, dopo L’architettrice e Self-Portrait. Il museo del mondo delle donne, prosegue l’esplorazione di coloro che in vita sono state animate da un desiderio così potente da renderle invulnerabili alle leggi implicite e scritte del mondo che le avvolgeva – e che spesso, per questo, sono state definite “bizzarre”, come Mazzucco stessa. Nel farlo, le bastano pochi tratti per condurre chi legge all’interno di scene ricchissime, cinematografiche nel pathos e nell’accuratezza d’immagine, che riecheggiano certe scene tolstoiane – l’autore che più di tutti, prima che il cinema esistesse, ha avuto il talento di rendere indimenticabili luoghi mai visti: la stazione ferroviaria moscovita, una pista di pattinaggio affollata, l’alba su una battaglia in cui non si distingue l’uniforme amica da quella nemica.
Tangenzialmente succede poi qualcos’altro: la ricostruzione minuziosa di Mazzucco, che si serve sì degli archivi e delle cineteche in giro per il mondo nell’inseguimento dei suoi personaggi, non si dimentica dei dettagli all’apparenza meno significativi, eppure imprescindibili per raccontare una storia svoltasi ormai cento anni fa. E quindi una Roma – o una Parigi o una Napoli o una Berlrino – che dalle vecchie foto in bianco e nero sembra immobile al pari dei volti delle donne eleganti che la popolavano e di cui è impossibile definire l’età improvvisamente prendono vita; sappiamo di cosa parlavano le persone, cosa andavano a vedere al cinema, come erano ammobiliate le le loro stanze, come si esprimevano i rapporti di potere e quelli di genere, cosa succedeva a queste stesse città e persone quando su di esse si allungava l’ombra lunga della guerra.
Oltre tutto non credo che ci sia un momento migliore delle vacanze di Natale per leggere questo libro, che richiama un inverno lungo, eppure stranamente confortevole, stemperato dalla luce calda di un’avventura.
Di Irene Graziosi
Maledizioni di George Wylesol (Coconino)
Il 2024 è stato uno degli anni più sciagurati della mia vita.
Sventure prevedibili o tutto sommato fisiologiche sono state accompagnate da avvenimenti paradossali che mi hanno spinta a considerare seriamente l’esistenza del malocchio: quando le cose sembrano ammantarsi di qualcosa di particolarmente oscuro, ci si appella all’inspiegabile – soprattutto se si hanno delle origini calabresi.
Le storie a fumetti che compongono la raccolta Maledizioni sono state realizzate da George Wylesol tra il 2016 e il 2023 e non hanno alcun legame tra di esse eccetto, secondo le parole dell’autore, la presenza di una “qualche maledizione ultraterrena su ogni personaggio”. E in effetti i protagonisti vagano come ectoplasmi nelle loro vicende surreali, su cui aleggia qualcosa che a volte prende le sembianze di una creatura soprannaturale e altre si limita a restare sensazione – una sensazione di turbamento, di mistero, di poesia.
Così come in 2021, libro-game pubblicato sempre da Coconino nella collana Brick (curata da Ratigher, una garanzia), Wylesol ripropone la propria ambientazione d’elezione: spazi liminali affini all’estetica internettiana delle backrooms, stanze abbandonate in cui sembra possibile percepire quella “ondata di malvagità che scorre tra il nostro e l’altro mondo”. Maledizioni è un graphic novel misterioso, fatto di atmosfere che ti lasciano addosso un’inquietudine difficile da definire, ma è anche un’eloquente raccolta delle tante possibilità artistiche di George Wylesol, che col suo solidissimo tratto alterna minimalismo e psichedelia, realtà e magia, analogico e digitale.
Comunque ho chiesto a mia nonna di togliermi il malocchio e da allora va tutto decisamente meglio.
Di Giada Arena
Tecniche di nascondimento per adulti di Carmen Gallo (Italo Svevo)
Forse la prima volta in cui l’umanità ha osservato due linee incontrarsi fino a formare un angolo ha covato il desiderio di nascondervisi: il ricordo del primo gioco da bambini, per molti, una triangolo di sedie giustapposte – sopra una coperta a fare da capanna.
Del resto la letteratura racconta il desiderio di nascondimento sin dalle origini (Λάθε βιώσας, il precetto antimondano di Epicuro), certo poi tramutatosi in sogno di sparizione: i Radiohead di How to Disappear Completely.
A un genere più attraversato di quanto appaia si ascrive allora questo sfuggente manuale (in realtà fototesto o trattato-manifesto?) che esce per la “invero utilissima” “Biblioteca inutile” di Italo Svevo: Tecniche di nascondimento per adulti.
Lo ha scritto Carmen Gallo, che è traduttrice e studiosa di letteratura inglese: autrice abituata, cioè, a celarsi tra le pieghe dei testi altrui (a lei si deve il nuovo – per ora definitivo – titolo del capolavoro di T.S. Eliot, La terra devastata).
Ma pure nella prosa elegante in cui è composto questo volume si indovina una diversa forma di nascondimento: quella dei versi cifrati, dei metri occultati oppure dissimulati in una voce solo all’apparenza algida o impersonale però, in realtà, piuttosto benevolente; il ritmo segreto, cioè, di chi sa andare a capo (“Il diritto di nascondersi per un po’ dovrebbe essere garantito a chiunque. Anche perché non è una scelta”). E giusto L’arte della fuga, con titolo musicale, aveva chiamato Giuseppe Pontiggia il suo libro più diffratto, con un protagonista (al solito) braccato sin dalla copertina: a ricordare il nesso armonico (ritmico e invisibile) tra inseguimento e partitura. Gli occultamenti di cui parla Gallo nel libro, del resto, sono solo momentanei e coincidono spesso col desiderio di sottrarci che istintivamente avvertiamo in certi frangenti di pericolo. Una scelta che la scrittrice incoraggia, seppure per poco, suggerendo con voce savia e precisa alcune strategie che appaiono (sospettabilmente) alquanto affinate. A contrappunto di una voce esperta e impersonale, Gallo complica il gioco inserendo delle fotografie invece personalissime immortale col telefono: la poeta aveva chiarito il ruolo dell’occhio-obiettivo in un bel libro a cura di Maria Teresa Carbone e qui le istantanee, alternate al saggismo, collaborano a scavare anditi ulteriori rendendo più eloquente la poetica della fuga. Trattato a scansie o botole segrete: Gallo scrive poi di case Napoli o della pandemia e però senza nominarle.
Tra tutte le tecniche illustrate, la più letteraria è quella della metamorfosi, che la voce dice di aver sfruttato per assumere, con camaleontica indole e a seconda dell’occasione, la fisionomia delll’ascensore, un alone sul soffitto, l’intreccio delle mani della madre. Capitolo che ci ha ricordato l’incipit di Franny e Zooey di Salinger, dove la protagonista, desiderando disertare una brusca conversazione al ristorante, vagheggia di sparire dentro il pozzo scuro delle macchie sulla tovaglia.
Ma a ben cercare, magari frugando tra i versi, si scopre che il motivo, assieme con i rischi che certi espedienti comportano, si annidava in bella vista già tra gli anfratti di una sezione della precedente raccolta di poesie di Gallo, che si intitolava proprio Le fuggitive: “Chi corre scompare / ma si porta dietro tutto. / Chi resta impara a nascondersi. A non essere niente”. Mutuando un’immagine di Cesare Garboli potremmo allora osservare che questo è per Gallo “l’intrico più nodoso, la radice più interrata” della sua scrittura.
Pubblicato in sordina e ora diffuso tramite un passaparola di sussurri, quest’aureo libretto somiglia a certe creature del folklore nordico che attendono le tenebre al riparo di un albero prima di uscire allo scoperto: starà, dunque, al talento cauteloso del lettore riuscire a stanarlo in libreria.
Di Emiliano Ceresi
La bambina e l’orsa di Cristiana Pezzetta e Sylvie Bello (Topipittori).
Quella che vi voglio consigliare è una storia che non appartiene al 2024, ma arriva dalla Grecia del V secolo a.C. Cristiana Pezzetta l’ha raccolta e l’ha raccontata di nuovo, anche ai più piccoli. Sylvie Bello l’ha illustrata, che poi è un altro modo di narrarla. La bambina e l’orsa, uscito questo ottobre per Topipittori, è dunque una leggenda antica, arrivata fin qui dal villaggio di Brauron, sulla costa orientale dell’Attica.
Le due protagoniste sono, appunto, l’orsa, ovvero la natura indomita e selvaggia, e la bambina, cioè l’infanzia, ancora ignara delle paure codificate all’uomo e dotata di una gentilezza priva scopi. La loro amicizia nasce dalla curiosità, dal desiderio di esplorazione. Non importa se appartengono a due specie diverse: l’orsa impara a sentire le piccole dita sul suo grande collo, la bambina prova ad arrampicarsi sugli alberi, nel tentativo di assomigliarsi e condividere tutto – non solo le bacche selvatiche.
L’inconsapevolezza dei limiti della civiltà rende possibile un incontro di due creature che stanno ai margini. “La dea Artemide, che custodisce i luoghi di confine, osservava in silenzio le sue creature”, il racconto si snoda sotto la protezione della dea della foresta e degli animali selvatici, ma anche della caccia, che guida sia gli abbracci delle due amiche, sia l’impeto violento dei fratelli della bambina.
“La paura aveva abbandonato i loro cuori. A volte, però, Artemide le osservava con preoccupazione”. La paura, infatti, arriverà, così come la violenza: “si sentì improvvisamente sola ed ebbe paura. Non sapeva neppure come chiamare l’orsa, perché non c’era stato bisogno di conoscersi per nome per riconoscersi”. Quando la conoscenza richiede definizioni, l’incanto si rompe. La spedizione punitiva da parte dei fratelli è accompagnata da tonalità cupe.
La dolcezza dei colori viene, però, presto recuperata, insieme al senso di comunità: la morte dell’orsa diventa il pretesto per fondare un santuario dedicato alla dea Artemide e un ginnasio dove ogni bambina potrà conoscere quella e altre storie. Brauron ospitava davvero un importante santuario alla dea greca e in suo onore si teneva ogni anno una festa: le giovani ateniesi indossavano abiti color zafferano e formavano gruppi di preghiera chiamati arktoi (‘orse’).
Come per tutti i bellissimi libri della casa editrice Topipittori, sarebbe riduttivo classificare L’orsa e la bambina come storia per l’infanzia: c’è molto, in queste pagine e in questi disegni – sensibilità ambientalista, violenza e desiderio di vendetta, c’è delicatezza e senso di appartenenza, condivisione, soprattutto. I disegni avvolgenti di Sylvie Bello mescolano con tenerezza il bosco, i corpi; le linee sottili descrivono e includono, i contorni non sono netti, non c’è un confine distinguibile tra i personaggi e il luogo, tra la natura e la civiltà. Una lettura che è una carezza, un abbraccio. E di cos’altro si può avere bisogno a fine dicembre?
Di Irene Moro
Lo psicologo nel palazzo. Il caso Bechterev-Stalin di Luciano Mecacci (Palingenia)
Poche cose eccitano l’immaginazione più di un avvelenamento riuscito. Un buon avvelenamento, d’altronde, è quello che non solleva sospetti sul responsabile, che riesce a camuffare l’omicidio da morte naturale, seminando tutt’al più dubbi e legittimando la validità di coincindenze di vario genere.
Lo sanno bene gli uxoricidi, gli agenti segreti e i dittatori.
Stalin vi ha fatto ricorso spesso – e una voce, smentita da alcuni autorevoli storici, sostiene che la sua stessa morte sia da imputare a questa causa.
Vi sono pochi dubbi oggi, invece, sul fatto che la morte, avvenuta nel Natale del 1927, di Vladimir Michajlovič Bechterev, insigne psichiatra, fisiologo e neurologo russo, sia avvenuta per avvelenamento. Ufficialmente, la causa sarebbe del cibo avariato.
Il giorno prima di morire, però, Bechterev incontra Stalin e solo credendo con fermezza al caso si può scartare a priori una correlazione tra i due eventi. Alcune testimonianze, emerse negli anni Settanta, dopo anni di pettegolezzi e voci incerte, sostenevano che Stalin fosse allora afflitto da una acuta depressione e che l’insigne scienziato, convocato al Cremlino per visitarlo, avesse formulato una diagnosi di “grave paranoia” che gli sarebbe stata fatale. Possibile che Bechterev, da scienziato rigoroso ed avvezzo alle accortezze che la vicinanza al potere comporta, si fosse davvero lasciato sfuggire, con tanta avventatezza, una diagnosi di quel tipo? Stalin era davvero affetto da paranoia? O la diagnosi indiziaria, basata su fonti orali e inscritta all’interno di una cornice psicoanalitica, finirebbe per sollevare Stalin dalle sue responsabilità politiche e morali? E poi: altre ipotesi, false piste, la malattia di Lenin (Bechterev è stato molto vicino anche a lui, infatti). Insomma: un giallo.
Luciano Mecacci, psicologo, storico e russista già autore di pregevoli saggi (tra i quali, Besprizornye. Bambini randagi nella Russia sovietica e La Ghirlanda fiorentina e la morte di Giovanni Gentile, entrambi pubblicati da Adelphi), esamina tutti gli aspetti della vicenda, partendo dalla vita di Bechterev e seguendo meticolosamente varie strade e congetture nel suo ultimo lavoro, Lo psicologo nel palazzo. Il caso Bechterev-Stalin, uscito per la giovane (e già dal catalogo molto raffinato) casa editrice Palingenia.
Bechterev, di cui Mecacci traccia un ritratto scientifico, intellettuale e privato, è stato un uomo straordinario, di idee progressiste e innervato da quello spirito emancipatorio che permeava una società giovane, inquieta e violenta come quella russa a cavallo tra il tardo zarismo e le rivoluzioni. I suoi molti talenti e interessi – dalla psicologia delle masse alla telepatia e all’ipnosi – lo rendevano attraente agli occhi di un potere che aveva l’ambizione di consolidarsi anche attraverso la manipolazione e il controllo della psiche.
Mecacci, pur senza sacrificare nulla al rigore e all’accuratezza storica, ha il passo dell’investigatore, assieme deciso e meditabondo. Impreziosito, in apertura, da un racconto dello scrittore tedesco Lion Feuchtwanger che mostra singolari analogie con la vicenda di Bechterev e, in chiusura, dall’intervista piuttosto compiacente che lo stesso Feuchtwanger fece a Stalin, Lo psicologo nel palazzo non vuole offrire risposte certe, ma porre questioni sul potere e sui rapporti che esso intrattiene con la scienza ancora oggi stimolanti – e ha il merito di farsi leggere con piacere, come una spy story.
Di Lorenzo Gramatica
Plastic Girl di Usamaru Furuya (Coconino)
Plastic Girl è un’opera breve ma incredibilmente potente dell’artista giapponese Usamaru Furuya, mangaka dotato di una capacità unica nell’esplorare temi complessi e disturbanti attraverso un’estetica in continuo mutamento. L’ho anche intervistato, se volete saperne di più.
Pubblicato originariamente come racconto illustrato, richiama immediatamente il concetto di artificialità: la protagonista, il cui corpo e identità sono plasmati e manipolati, diventa una metafora della standardizzazione dei corpi e delle personalità, e delle pressioni sociali che riducono gli individui a oggetti da modellare secondo desideri altrui.
E Furuya si spinge oltre, mostrando anche come la mercificazione del corpo femminile e l’alienazione siano intimamente connesse alla società moderna.
Visivamente, Plastic Girl è un vero capolavoro di illustrazioni intricate e inquietanti, che fondono il grottesco con l’onirico. Le immagini spesso deformano i corpi e lo spazio creando un’esperienza quasi claustrofobica per il lettore, muovendosi dentro un labirinto che ha le sembianze di un corpo. Furuya utilizza tecniche artistiche che ricordano tanto il surrealismo europeo quanto la tradizione giapponese dell’ “ero-guro” (erotico-grottesco), mescolando bellezza e orrore in ogni pagina.
Il lettore è costretto a confrontarsi con immagini disturbanti che fungono da specchio della disumanizzazione e della perdita di identità, perdendosi dentro un’opera che sfuma i confini tra arte sperimentale, illustrazione, fumetto e narrativa.
Pochissimi autori possono arrogarsi di possedere un talento poliedrico come Usamaru Furuya, e se anche voi vi siete stufati di leggere il solito libercolo da radical chic sfranti incensato da gente insopportabile che parla della “vera letteratura”, vi consiglio questa lettura da fare comodamente vicino l’albero di Natale.
Di Matteo Grilli
Filterworld di Kyle Chayka (ROI Edizioni, traduzione di Sara Meddi)
Secondo l’Oxford University Press, la parola – o meglio, l’espressione – del 2024 è “brain rot”, la cui definizione può essere tradotta come “il presunto deterioramento dello stato mentale o intellettuale di una persona, soprattutto se attribuito al consumo eccessivo di materiale (in particolare di contenuti online) considerato banale o poco impegnativo”.
Nel 2024 i profili attivi sui social media sono circa 5,04 miliardi. Questo significa che più del 62% della popolazione mondiale possiede uno o più profili online. Sui social si chatta, si compra, si vende, si cerca la propria anima gemella, si condividono foto, video e si scrolla, cercando goffamente di schivare la noia. Allora, forse, può essere utile cercare di capire cos’è un algoritmo, come funzionano queste piattaforme e che impatto possono avere sulla nostra società, a partire dalle relazioni personali fino all’architettura dei luoghi.
Filterworld è un saggio dell’editorialista del «New Yorker» Kyle Chayka, specializzato in Internet culture. E parte da una teoria: i filtri – non sono solo quelli di Instagram o delle app che usiamo per ritoccare le foto, ma veri e propri meccanismi culturali, estetici, sociali – stanno rimodellando il nostro mondo, creando una tensione costante fra comodità e alienazione. “Il filtro” scrive Chayka “non è solo uno strumento, ma un modo di vivere: rende la realtà più facile da consumare, ma allo stesso tempo più distante.”
Per dimostrare questa tesi, l’autore cita, fra le altre cose, il design minimalista delle case Airbnb e il look “curato ma casual” che adottiamo quasi tutti i giorni, entrambi esempi di un’estetica edificata sulla volontà di mostrarsi autentici, ma che finisce spesso per omologarci, per ingabbiarci in un’idea preconfezionata di bellezza.
Leggendo Filterworld, insomma, ci è più chiaro come la corsa a ciò che è instagrammabile stia diventando, da rifugio, una prigione. E come in quella prigione risieda soprattutto l’individualità e l’unicità che tanto cerchiamo, ma cui stiamo rinunciando.
Di Elena Sbordoni
A quattro zampe di Miranda July (Feltrinelli, traduzione di Silvia Rota Sperti)
I gusti letterari non sono una scienza esatta, ma da qualche anno mi sono accorto che se un romanzo mi fa sorridere (e ogni tanto ridere) e parla bene e diffusamente di sesso ha più chance di altri di attirare la mia attenzione. È successo anche nel 2024, con A quattro zampe di Miranda July, tradotto in italiano da Silvia Rota Sperti per Feltrinelli. La storia è quella di una donna facilmente sovrapponibile a July – artista americana di mezza età, famosa ma non famosissima – che decide di fare un viaggio coast to coast da Los Angeles a New York per dimostrare al marito di essere tenace e autonoma, e invece si ferma per due settimane in un motel a mezz’ora da casa senza dirlo a nessuno. Da lì in poi, ogni quindici pagine le succede qualcosa di nuovo e, in un certo senso, rivoluzionario: spende l’intero budget del suo viaggio-non-viaggio in un modo assurdo, si innamora di un ragazzo più giovane, realizza con disperazione di essere entrata in pre-menopausa e decide di prendere sul serio i propri desideri, anche quelli apparentemente egoisti.
“De Beauvoir si sbagliava” dice a un certo punto a un’amica. “Non solo puoi volere quello che vuoi, ma anche averlo”. L’altra risponde: “Ma io voglio solo volere. È questo lo scopo del desiderio”. Oltre a raccontare con intelligenza questa contraddizione a tutti familiare (vivere meglio grazie alle proprie fantasie, temere la possibilità di realizzarle), A quattro zampe è scritto benissimo. E la cosa mi ha sorpreso, visto che conoscevo Miranda July quasi esclusivamente come artista visiva e mi aspettavo un libro sì brillante ma non così ben congegnato, tanto consapevole a livello di lingua e struttura narrativa. Nella terza parte perde forse un po’ di nitore, ma va bene lo stesso, la gratitudine per la genialità delle prime due è un carburante sufficiente a raggiungere l’altra costa ― per finta e da fermi, come fa la protagonista del romanzo, e pienamente appagati.
Di Nicola H. Cosentino
Invernale di Dario Voltolini (La Nave di Teseo)
Invernale si apre con i movimenti di una danza macabra, quella del sabato del mercato ai banchi di una macelleria, quando le carni animali vengono aperte, pulite, squarciate, atti finali ma privi di sadismo, movimenti rituali che richiedono un’esecuzione accorta e precisa dei gesti. Un giorno un colpo va storto di qualche centimetro, quel che basta perché il macellaio si affetti un dito.
Dopo l’incidente qualcosa inizia a disintegrarsi in quest’uomo, nelle certezze che lo tengono assieme, e qualche mese più tardi scopre di avere un tumore. Non c’è alcuna connessione medica con il taglio, ma il macigno dell’imprevedibilità gli frana a questo punto definitivamente addosso.
Solo dopo qualche capitolo capiamo che il macellaio è il padre di Voltolini, e che questo romanzo è il racconto del suo declino, e degli ultimi anni di conoscenza tra il padre e il figlio, vent’anni fa.
Sono centocinquanta pagine in piccolo formato, scritte da Voltolini in pochi mesi, con una lingua levigata che non risparmia nulla del dolore che racconta. È un libro lacerante, a volte difficile da leggere.
Il lutto non è un episodio drammatico ma una frattura che riorganizza il tempo e lo spazio della nostra esistenza. Per Voltolini il racconto della perdita del padre è la descrizione di questa sospensione. Invernale non è uno di quei libri terapeutici sul trauma, sul superamento del trauma. È un libro che tenta di ricostruire lo sconcerto. Non si lascia andare e non si tira indietro. È confortante pensare che ci sia ancora chi crede a un’idea di letteratura così potente, lontana dalla pura evasione o dal consumo, capace di confrontarsi con l’indicibile.
Di Matteo De Giuli