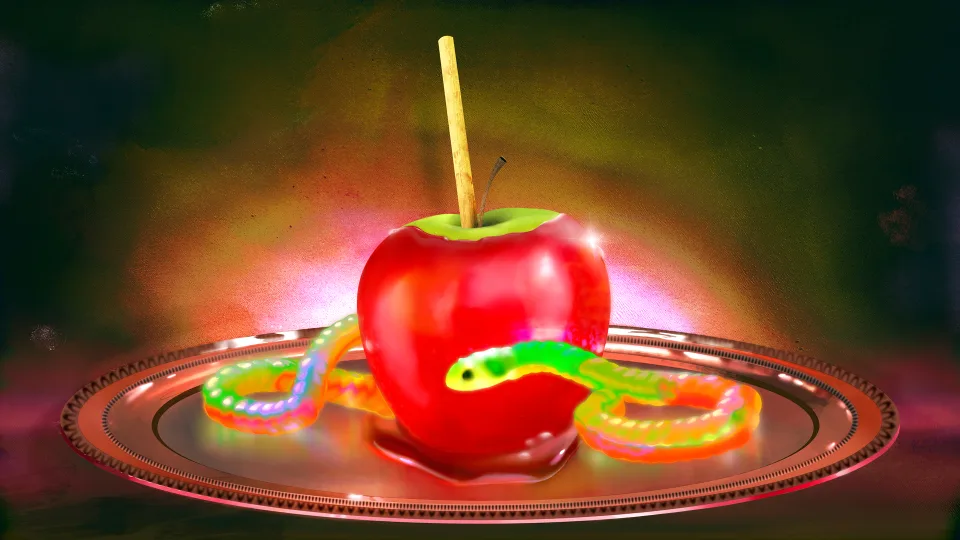La canonizzazione del giovane Carlo Acutis, il “santo di internet”, ha suscitato parecchie perplessità. Ma la Chiesa può fare a meno dei santi?
Nel caos del centro storico di Napoli, a piazza Dante, la seicentesca Chiesa di San Domenico Soriano è sede di un intenso pellegrinaggio: sotto l’altare vi si trova infatti, perfettamente imbalsamato, il corpo di san Nunzio Sulprizio, giovane e povero fabbro morto tra mille sofferenze all’Ospedale degli Incurabili nel 1836, appena diciannovenne. Oggetto fin da subito di devozione popolare, il suo processo di canonizzazione fu aperto da Pio IX e nel 1963 fu beatificato da Paolo VI; riconosciuto infine il miracolo di un giovane di Taranto uscito dal coma vegetativo dopo un incidente in moto nel 2004, papa Francesco lo ha fatto santo nel 2018 proclamandolo “protettore dei giovani”. Di giovani santi e persino santi bambini è pieno il martirologio romano. Per un certo periodo, dopo la Controriforma, fu una vera e propria moda: a Napoli si chiamavano “santolilli” e dovevano la loro fama in vita a visioni spirituali e prodigi, anche se non mancavano i casi di “falsi santi”: per dimostrare di non mentire o essere indemoniato, il piccolo Francesco Bartolomeo Belli, un bambino di cinque anni in odore di santità, dovette subire nel 1675 un impegnativo esorcismo a suon di schiaffi, pugni, calci e bastonate da parte di un prete domenicano.
I santi giovani esercitano una fascinazione particolare sulla Chiesa. Sebbene a ogni piè sospinto le autorità vaticane ripetano che servono più santi laici, la stragrande maggioranza, per non dire la quasi unanimità delle canonizzazioni riguarda fondatori di ordini religiosi ed esponenti del clero regolare. Per la loro età, i giovani morti in odore di santità sono giocoforza rimasti fuori dal mondo ecclesiastico, il che li rende candidati ideali. In ogni epoca storica, i santi bambini o adolescenti rappresentano lo specchio della società del loro tempo. André Vauchez conta nel medioevo dodici casi di bambini o ragazzi vittime degli ebrei e proclamati santi martiri: tra questi il celebre Simonino, la cui morte a Trento nel 1475 fu attribuita alla presunta pratica ebraica di uccidere bambini cristiani alla vigilia della Pesach per usarne il sangue in parodie blasfeme dell’eucarestia (il culto di san Simonino fu soppresso solo nel 1965 dopo il Concilio Vaticano II). Secondo Giordano Bruno Guerri la storia di Maria Goretti, morta a unidici anni nel 1902 per sfuggire a uno stupro, era funzionale alle politiche di moralizzazione del governo fascista e di Pio XII, che la canonizzò nell’immediato dopoguerra con l’obiettivo di contrastare l’immoralità sessuale degli occupanti americani. Si può quindi comprendere l’ambizione di proclamare il primo santo millennial portata avanti con protervia negli ultimi anni dal Dicastero per le cause dei santi, allo scopo di dare alle masse dei giovani che affollano le annuali Giornate mondiale della gioventù (istituite nel 1985 da Giovanni Paolo II) un santo in cui riconoscersi. L’onore e l’onere (che richiede, ça va sans dire, una morte drammaticamente prematura) è toccato al milanese Carlo Acutis, la cui canonizzazione, inizialmente programmata in occasione del Giubileo degli adolescenti in aprile e poi, dopo la morte di papa Francesco, al 7 settembre di quest’anno, insieme a quella del ventiquattrenne Pier Giorgio Frassati. A differenza di quest’ultimo, morto nel 1925, Acutis è morto appena quindicenne nel 2006: una canonizzazione-lampo non esente da forti critiche anche negli ambienti teologici.
A eternare l’immagine del santo millennial, la salma imbalsamata di Carlo Acutis indossa una tuta e scarpe Nike. Il nuovo santo, definito “protettore degli internauti”, deve la sua fama sanctitatis alla spiccata devozione eucaristica: poco prima di morire a causa di una leucemia fulminante, Acutis aveva messo su un sito web dedicato ai miracoli eucaristici, da cui è stata poi realizzata una mostra itinerante che negli ultimi anni ha fatto letteralmente il giro del mondo. La sua convinzione che l’eucaristia rappresenti “l’autostrada per il Cielo” ha spinto il teologo Andrea Grillo, autore di una ponderosa monografia dedicata all’eucaristia nell’ambito del Nuovo Corso di Teologia Sistematica della Queriniana, a chiedersi come sia possibile “che un giovane beato [ora santo, n.d.r.] possa comunicare una teologia eucaristica così vecchia, così pesante, ossessiva, concentrata sull’inessenziale e tanto trascurata invece sulle cose decisive”. Nonostante, in effetti, le proclamazioni agiografiche sulla capacità del giovane di “carpire i segreti del web”, il modello di santità rappresentato da Carlo Acutis possiede “tutta una serie di caratteristiche tradizionali della santità giovanile, di sapore vagamente ottocentesco, come l’interesse per i santuari e le apparizioni mariane o la viva pietà eucaristica”, come osserva Alessandro Serra, docente di Storia del cristianesimo all’Università di Perugia.
Ma il giovane santo non ha ovviamente colpe. Il problema risiede piuttosto nella difficoltà che le stesse gerarchie ecclesiastiche incontrano nel tentativo di svecchiare e riformare il modello di santità proposto dalla Chiesa. Chi sono, in effetti, i santi? Tutti gli esseri umani sono chiamati alla santità, ci ricordano gli ultimi papi, ma questa visione “aperturista” è estremamente recente. “Molti sono i chiamati, pochi gli eletti” aveva chiarito Gesù, stando al vangelo di Matteo (22,14). Dottrina “orribile e spaventosa”, la definì nel XVII il cardinale Bona, che limitava il novero dei santi a pochissime unità. Eppure, nell’Apocalisse (7,9) leggiamo della “moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, razza popolo e lingua” che si presenta davanti al trono dell’Agnello con vesti bianche e palme nelle mani. Sono i santi martiri, come si può intuire dal simbolo della palma; e in effetti nei primi secoli, fatti salvi i pochissimi casi di santi pre-cristiani, ossia di persone vissute prima della morte di Gesù ma la cui santità si deve all’aver riconosciuto tra i primi la divinità di Cristo (Giovanni il Battista, Lazzaro di Betania risuscitato da Gesù, Maria Maddalena e gli altri discepoli), la santità veniva attribuita “d’ufficio” solo ai martiri: morire per la fede, subire torture e tormenti per il proprio credo era considerato il modo più sicuro per ottenere un biglietto di prima classe per il paradiso. Non a caso il primo santo cristiano fu Stefano, che fu anche il primo martire. Le persecuzioni a cui, a ondate, erano sottoposti i primi cristiani entro i confini dell’Impero romano, rendeva il martirio un’eventualità non così improbabile per i battezzati. L’Apocalisse fu scritta all’epoca della persecuzione di Nerone, e il futuro prefigurato da Giovanni ipotizzava un’ultima grande persecuzione di cui avrebbero fatto le spese tutti i cristiani dell’epoca.
Già dal III secolo emerse una seconda fattispecie di santità: il confessore, che non indica come oggi il sacerdote che confessa le colpe dei fedeli, ma colui o colei che confessa pubblicamente la propria fede e in ragione di essa subisce vessazioni, prigionia o tormenti, ma senza arrivare alla morte vera e propria. Confessores era il termine usato dal vescovo Cipriano di Cartagine per distinguere, al termine della persecuzione dell’imperatore Decio, a metà III secolo, chi era rimasto fermo nella fede dai lapsi, coloro che avevano abiurato ottenendo in cambio un certificato di conformità al decreto imperiale che obbligava tutti i cittadini dell’Impero a sacrificare alle divinità tradizionali. Cipriano, che in seguito sarebbe stato martirizzato e quindi canonizzato, insisté che solo il vescovo poteva riammettere i lapsi nella comunità cristiana, perdonando i loro peccati. La via per il paradiso era allora davvero stretta.
Un altro modo per assicurarsi la santità era l’eremitaggio. La Vita di Antonio, il primo degli anacoreti che nel IV secolo abbandonò la ricca famiglia copta di origine per ritirarsi nel deserto dell’Egitto isolandosi dal mondo, divenne un best-seller dell’antichità. Stando al suo autore, Atanasio, gli eremiti dovevano affrontare prove assimilabili a quelle dei martiri: per vent’anni, Antonio affrontò nella solitudine le più subdole tentazioni del maligno, prima di ritornare nel mondo già adornato dell’aureola della santità per insegnare ad altri le pratiche ascetiche necessarie per affrontare i rigori dell’eremitaggio. Agostino d’Ippona ne fu talmente colpito da decidere di diventare lui stesso santo. Ciò che la Vita di Antonio di Atanasio rappresentò nel mondo orientale trovò un corrispettivo in Occidente nella Vita di Martino di Sulpicio Severo, che raccontava con dovizia di miracoli la vita di Martino da Tours, primo eremita europeo e fondatore in seguito di comunità monastiche in Gallia, la cui esperienza influenzò per tutto il medioevo il monachesimo, considerato un altro modo per passare per la “porta stretta” che conduce al Regno di Dio.
In realtà per molti secoli i criteri di santità furono piuttosto laschi. Per esempio, a causa dell’abitudine nel mondo pagano di utilizzare l’aggettivo sanctus per designare tutte le autorità preposte ai riti religiosi, nei primi secoli tutti i vescovi cristiani si trovano a essere designati come santi, anche se il significato del termine era ben diverso da quello attuale. Poi, con il passare del tempo, lo slittamento semantico fece sì che il novero dei santi accogliesse ex officio tutti questi antichi prelati, il che spiega perché tutti i primi cinquanta papi siano santi, benché molti di loro difficilmente meritassero questo titolo (fa eccezione Anastasio II, il cui carattere conciliante nei confronti dell’eresia ariana gli valse la damnatio memoriae, che lo vuole morto per improvvisa eviscerazione mentre era intento a defecare, venendo poi debitamente collocato da Dante all’Inferno). Viceversa, a partire dal X secolo i papi santi scomparvero, con rarissime eccezioni (tra cui quella celebre di Pietro da Morone, papa Celestino V) fino al XX secolo: segno delle notevoli restrizioni che il processo di canonizzazione avrebbe subito fino a Giovanni Paolo II.
In pieno medioevo si contavano ormai oltre diecimila santi, al punto che, secondo lo storico Peter Brown, il cristianesimo del primo millennio rischiò di trasformarsi in una specie di induismo d’Occidente. Pratica comune era l’inventio, la scoperta apparentemente casuale di spoglie di martiri cristiani durante i lavori di ristrutturazione di una chiesa, che in tal modo diveniva meta di pellegrinaggi remunerativi per il clero locale: fu così che Sant’Ambrogio venne costretto dalla pressione dei fedeli a “scoprire” i resti di due presunti martiri cristiani, Gervasio e Protasio, durante il rifacimento della basilica di Milano. Per porre fine a quest’indebita proliferazione di santi, con il consolidarsi del potere pontificio Roma decise di avocare a sé il processo di canonizzazione. Nel 993 papa Giovanni XV proclamò santo Ulrico, vescovo di Augusta: era la prima volta che un papa proclamava un santo al di fuori dell’Italia, indice della pretesa universalistica del pontefice. Non a caso nei registri ufficiali sant’Ulrico è “il primo santo”, perché il primo a beneficiare della canonizzazione pontificia. Non fu facile. Nel 1171 Alessandro III dovette scrivere al re Kol di Svezia per precisare che non si poteva proclamare santo un ubriacone morto in stato di ebbrezza solo perché dopo la morte gli venivano attribuiti miracoli. L’ubriacone in questione era in realtà il vecchio re Erico, che proprio Kol aveva ucciso per assumerne il trono. La questione era di per sé abbastanza scabrosa, ma ciò che interessava al papa era che la venerazione pubblica di un santo avvenisse solo con l’autorizzazione della Chiesa di Roma. Questa lettera, Audivimus, entrò poi a far parte del corpus canonico e divenne la base su cui si fondò la centralizzazione nella sede apostolica di tutti i processi di canonizzazione. Il primo che si completò formalmente sotto l’autorità papale fu quello di san Galgano, nel 1185. Per secoli, tuttavia, si confermò una distinzione tra santi e beati secondo cui i primi erano coloro che avevano ricevuto la canonizzazione ufficiale da Roma, i secondi quelli il cui culto restava locale perché non confermato. Bisognerà aspettare Urbano VIII perché, nel 1634, Roma avocasse a sé anche la beatificazione.
“A eternare l’immagine del santo millennial, la salma imbalsamata di Carlo Acutis indossa una tuta e scarpe Nike. Il nuovo santo, definito ‘protettore degli internauti’, deve la sua fama sanctitatis alla spiccata devozione eucaristica: poco prima di morire a causa di una leucemia fulminante”.
Il processo di canonizzazione romano era inizialmente alquanto semplice. Sant’Ulrico fu proclamato santo al termine di una procedura di appena quattro giorni. Ma la naturale tendenza della Chiesa a caricare di barocchismi e bizantinismi ogni cosa giunse a rendere la canonizzazione, alle soglie del Novecento, un autentico incubo burocratico. Non solo il vescovo locale doveva farsi carico di tutti i costi della prima fase del processo, acquisendo le testimonianze coeve e la documentazione comprovante le virtù eroiche del candidato; ma una volta giunta a Roma, la pratica iniziava a fare il classico giro delle sette chiese. Innanzitutto occorreva un nulla osta dal Sant’Uffizio, che comprovasse l’inesistenza di dossier pendenti nei confronti dell’ortodossia del candidato (e i dossier degli archivi del Sant’Uffizio erano tradizionalmente numerosi e puntigliosi, per cui le probabilità che il proprio nome vi finisse sopra non erano per nulla basse). Poi occorreva la nomina di un postulatore della causa e di un promotore della fede, il famigerato “avvocato del diavolo”, chiamato a fare le pulci ai documenti e alle tesi fornite del postulatore. Quando, dopo lunghi anni e persino decenni di battibecchi tra i due, il postulatore riusciva ad avere la meglio, occorreva il placet del pontefice, con cui si apriva il processo apostolico: una replica del processo ordinario, che a sua volta veniva replicato altre due volte ancora, la prima alla presenza dei cardinali, la seconda alla presenza del papa. Solo allora il candidato riceveva il titolo di “venerabile”. Poi occorrevano i miracoli: almeno due per essere proclamato beato, altri due per diventare santo. Un tale iter spiega perché le beatificazioni e le canonizzazioni finirono per ridursi a meno di un centinaio per secolo, talvolta solo poche decine. Ancora nel Novecento, Pio XII proclamò solo 72 beati e santi, Giovanni XXIII nel suo più breve pontificato appena 15.
Fu Wojtyla a cambiare tutto. La sua prassi di accompagnare la visita apostolica in qualche paese più o meno remoto del mondo con l’annuncio della canonizzazione di un beato locale impose alla curia romana ben più che fare gli straordinari. Occorreva semplificare, e di parecchio. La costituzione apostolica Divinus perfectionis Magister provvide nel 1983 alla semplificazione, scindendo le antiche competenze della Sacra Congregazione dei Riti – che dal 1588 era preposta alle cause di canonizzazione – in due nuove congregazioni, quella per il Culto divino e quella per le Cause dei santi. Venivano accorpate le fasi del processo apostolico e rimossa la figura dell’avvocato del diavolo, sostituita da un prelato teologo. Il procedimento risultante, decisamente più rapido, non è più fondato come in passato sulle capacità dialettiche delle controparti di fa risaltare pregi e difetti dei candidati (cosa, questa, in grado di generare parecchi imbarazzi nelle cause più sensibili, come quelle dei pontefici del passato), ma sul metodo storico-critico: compito primario del postulatore della causa, se vuole che il suo candidato abbia qualche chance, è redigere o promuovere la redazione di una biografia fondata su solide basi scientifiche del potenziale santo.
In seguito alla riforma, la “fabbrica dei santi” ha iniziato a lavorare a ritmi inimmaginabili fino a pochi anni prima: sotto il pontificato di Giovanni Paolo II furono riconosciuti ben 1.827 tra beati e santi. E nonostante il suo successore, Benedetto XVI, nelle vesti di prefetto del Sant’Uffizio avesse velatamente criticato questa prassi sostenendo che si fossero canonizzati troppi santi di scarso significato per la maggioranza dei fedeli, sotto il suo pontificato ci furono 914 beatificazioni e canonizzazioni, salite a 2.483 sotto Francesco, che ha aggiunto anche una nuova fattispecie per la santità: l’offerta della vita, valida per coloro che “hanno offerto volontariamente e liberamente la vita per gli altri ed hanno perseverato fino alla morte in questo proposito”. Un crescendo che testimonia di una concezione diversa della fede, dove i “chiamati” sono forse sempre pochi, ma comunque non così pochi come si credeva nel medioevo e nella prima età moderna, e dove la santità può essere davvero alla portata di tutti. Di contro, resta il problema di una maggioranza di santi e beati provenienti dalle file degli ordini religiosi che poco hanno da dire alla comunità cristiana contemporanea, mentre i tanto auspicati santi laici restano un’esigua minoranza.
La spiegazione profonda risiede nel meccanismo più controverso del processo di canonizzazione: il miracolo. Certamente un santo è tale per la sua vita irreprensibile, le opere pie, carità, misericordia e via dicendo, ma senza miracoli non si hanno santi. Dopotutto, il principio vale anche per Gesù: cosa distingue un uomo saggio e illuminato da un messia? Risposta: i miracoli di guarigione e la resurrezione dai morti. Se si presta fede alle tante storie agiografiche del medioevo, gli exempla delle vite dei santi, di cui la Legenda aurea di Jacopo da Varazze (risalente alla seconda metà del XII secolo) rappresenta il più vasto compendio, i santi una volta compivano i miracoli da vivi. Col tempo, lo scetticismo dei moderni ha reso questa prassi quasi impossibile. La Controriforma, in particolare, diede vita a un processo di “disciplinamento” della vita religiosa di cui fecero le spese anche i santi. Fu Prospero Lambertini, poi papa Benedetto XIV, con la sua opera De servorum Dei beatificatione et beatorum canonization, a subordinare nella metà del Settecento l’aspetto prodigioso del santo a quello delle virtù del personaggio. “Virtù eroica” fu il termine usato per la prima volta nel processo di canonizzazione di Teresa d’Avila nel XVII secolo. Miglior modello di virtù è naturalmente la castità irreprensibile ed è per questo che, nel “clima misogino diffusosi in età post-tridentina”, come ha osservato Ottavia Niccoli, il numero di donne sante crolla vertiginosamente.
Ma se ai prodigi compiuti in vita nessuno crede in più, restano i miracoli post-mortem: la capacità del santo di intercedere presso Dio è testimoniata dai miracoli operati su coloro che ne invocano il nome. Miracoli che possono essere delle più disparate tipologie, ma che essenzialmente si riducono a una sola casistica: i miracoli di guarigione. Lo testimonia, storicamente, la prassi devozionale degli ex voto (che persiste ancora oggi, e si ricordi come Antonella Clerici abbia rivelato di aver voluto pregare sulla tomba di Carlo Acutis perché durante la convalescenza da un intervento chirurgico per un tumore le appariva sempre sullo smartphone l’immagine del santo). Ma lo testimonia anche il fatto che il riconoscimento dei miracoli necessari per la canonizzazione chiama in causa una speciale commissione di medici chiamati a pronunciarsi sull’effettiva inspiegabilità scientifica della guarigione. Solo i martiri sono esentati dalla prova del miracolo post-mortem, ma soltanto per la beatificazione: se vogliono diventare santi, devono darsi da fare come tutti gli altri.
La questione dei miracoli è fonte di profondo imbarazzo. Già Prospero Lambertini (papa Benedetto XIV) credeva che la maggior parte di essi potesse essere spiegata altrimenti. Nel 1988 i componenti della consulta medica vaticana e dell’ufficio medico internazionale di Lourdes lamentarono che “i progressi della medicina stavano rendendo sempre più difficile la dimostrazione dei miracoli” e che “i casi di guarigione fisiche stanno diventando sempre più rari”, secondo quanto riportato da Kenneth Woodward nel suo celebre libro-inchiesta La fabbrica dei santi (1990). Le guarigioni miracolose riconosciute per il processo di Carlo Acutis riguardano un bambino brasiliano affetto da una rara malformazione congenita al pancreas e guarito istantaneamente dopo aver pregato Acutis, e una ragazza costaricana finita in coma irreversibile a Firenze dopo la caduta da una bicicletta e risvegliatasi senza più tracce di emorragie cerebrale, dopo che la madre era andata a pregare sulla tomba del beato.
Errori diagnostici, autosuggestioni o autentici miracoli? I medici della consulta, che pure scartano la maggior parte dei casi derubricandoli a guarigioni scientificamente spiegabili, ammettono che la medicina, non essendo una scienza esatta, include moltissimi casi del genere. Ma cosa c’entra il miracolo col fatto che la maggior parte dei santi sono religiosi? C’entra perché, affinché sia possibile l’intercessione di quel particolare santo, occorre innanzitutto pregarlo. E quanto più grande e persuasiva è una lobby che promuove la causa di canonizzazione, tanto più è in grado di convincere molte persone a pregare quel particolare candidato alla santità. Negli ordini religiosi, il desidero di vedere canonizzato il proprio fondatore o la propria fondatrice fa sì che tutte le preghiere di guarigione siano a questi invariabilmente destinate, cosicché, anche solo per la legge dei grandi numeri, una presunta guarigione è più probabile che si verifichi lì che altrove. Carlo Acutis in questo è stato favorito dalla nascita di un’associazione a lui dedicata molto influente, finanziata anche grazie alla famiglia facoltosa a cui il giovane apparteneva, che attraverso un’imponente operazione di marketing è stata in grado di convertire alla sua devozione milioni di persone, intervenendo con efficienza e rapidità ogni qualvolta veniva comunicato un possibile caso di guarigione miracolosa. Occorrono macchine organizzative del genere perché la canonizzazione possa procedere fino al suo esito finale, dal che si spiegano i costi molto elevati che richiede una causa di successo, nonostante gli interventi fatta da papa Francesco per calmierarli.
Potremmo immaginare un futuro in cui la santità non sia collegata ai miracoli? Ciò avrebbe pesanti implicazioni. Bisognerebbe ammettere o che i casi precedenti di miracoli fossero, in maggioranza, degli abbagli, o che l’intervento soprannaturale di Dio nel mondo appartenga ormai al passato: in entrambi i casi, le fondamenta della fede verrebbero scosse. Una religione senza miracoli è senz’altro possibile, ma forse allora il mondo non avrebbe più bisogno di una religione. E i santi? Si potrebbe fare a meno di loro? Nella concezione cattolica, i santi trovano la loro giustificazione nel dogma della “comunione dei santi”, il rapporto continuo tra i vivi e coloro che non sono più di questo mondo, che i primi cristiani inserirono nel Simbolo apostolico, il “credo” recitato nei primi secoli, dove si pronunciava appunto la fede nella comunione dei santi: “Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la Comunione dei Santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna”.
Un bellissimo crescendo, che ancora oggi a volte si recita in luogo di quello più celebre, il credo niceno-costantinopolitano, che sintetizza gli ultimi passaggi nella formula “aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà”. Concetto oscuro, la comunione dei santi, che dovette svilupparsi allorquando divenne chiaro che l’atteso ritorno di Cristo e la fine del mondo non sarebbero stati così imminenti, spingendo a chiedersi che ne sarebbe stato dei credenti defunti. Sarebbero finiti nello Sheol, l’oltretomba della fede ebraica, dove i morti sono dimenticati persino da Dio? O sarebbero andati direttamente in paradiso, come il “buon ladrone” morto sulla croce insieme a Gesù? Paolo fu molto angustiato quando seppe che i cristiani di Corinto non credevano alla resurrezione dei morti.
Ma, lungi dall’essere una eresia, si trattava di una convinzione di senso comune: Gesù stesso aveva detto che Dio era il Dio dei morti, non dei vivi. Che dire, allora, di tutti quelli che erano morti nel frattempo per difendere la loro fede, che dire degli stessi apostoli, o addirittura di san Giuseppe, che a differenza di Maria – per la quale si sviluppò la leggenda dell’assunzione diretta in cielo – era sicuramente morto? La soluzione fu di prevedere una comunità cristiana divisa in tre Chiese: quella “militante”, che combatte ogni giorno sulla terra per la sua sopravvivenza; quella “paziente” o “purgante”, costituita da tutti coloro che dopo la morte stanno espiando i loro peccati in attesa della resurrezione; e la Chiesa “trionfante”, costituita dai santi che sono già in cielo insieme a Dio. E queste tre Chiese, pur divise da confini soprannaturali, costituiscono al tempo stesso un tutto indiviso, sono membra di un unico corpo, come spiegò già Paolo. Cosicché, i membri di queste tre Chiese sono in costante rapporto, in continua comunione. Una comunione che si stabilisce – come spiegherà nel 1992 l’allora cardinale Ratzinger nei panni di prefetto per la dottrina della fede – “non solo tra i membri della Chiesa pellegrinante sulla terra, ma anche tra essi e tutti coloro che, passati da questo mondo nella grazia del Signore, fanno parte della Chiesa celeste o saranno incorporati ad essa dopo la loro piena purificazione”.
“Fare a meno dei santi implica dunque fare a meno del rapporto tra aldiquà e aldilà, ammettere che la condizione dei defunti resta un mistero fino al giorno del giudizio. I protestanti, in buona parte, lo accettano, perché credono nel sonno delle anime teorizzato da Lutero”.
La dottrina della comunione dei santi non è pura teologia, ma è la spiegazione teologica che giustifica il culto dei santi. Fin dai primi secoli, i cristiani svilupparono una profonda devozione nei confronti dei defunti morti “in odore di santità”. Una devozione che non è semplice esercizio di memoria: se i santi sono già con Dio, allora possono pregare Dio perché interceda a favore di chi è ancora quaggiù, perché possa godere di grazie particolari. Avere “un santo in paradiso” è dunque un’ottima cosa, ma come accertarsi dell’effettiva santità del defunto? La domanda non è oziosa.
Per chi crede, l’ignoranza sul destino del proprio caro – se sia finito cioè all’inferno, in purgatorio o direttamente in paradiso (beneficio concesso ai soli santi) – può essere fonte di ansie. Almeno in passato lo era senz’altro: messe in suffragio, ceri votivi, culto delle anime del purgatorio appartenevano alla vasta serie di strumenti messi in campo dai vivi per assicurare una migliore sistemazione dei morti nell’aldilà. Questo per tacere dei medium, delle sedute spiritiche, dei sogni e di altri modi – disconosciuti dall’autorità religiosa – per entrare in contatto con i defunti e assicurarsi della loro condizione. Di una cosa, però, fin dai tempi antichi si poteva essere sicuri: i santi si trovano sicuramente in paradiso e dunque riconoscere la santità di un defunto equivale a un riconoscimento formale della sua condizione di beatitudine nell’aldilà.
Fare a meno dei santi implica dunque fare a meno del rapporto tra aldiquà e aldilà, ammettere che la condizione dei defunti resta un mistero fino al giorno del giudizio. I protestanti, in buona parte, lo accettano, perché credono nel sonno delle anime teorizzato da Lutero: tra la morte e la resurrezione le anime dormono in attesa del giudizio, per cui è inutile interpellarle.
Ma c’è qualcosa di anacronistico e al tempo stesso coraggioso nell’insistere ancora oggi sulla comunione dei santi; qualcosa che ha a che fare certamente con pratiche di devozione popolare troppo ancorate al folklore per poterle scardinare, ma anche, più universalmente, col non arrendersi alla concezione moderna per cui la morte è relegata ai margini dell’esistenza e i defunti sono condannati a essere dimenticati. No, alcuni di loro forse sono già nell’eterna beatitudine, e tuttavia si ricordano di noi, intercedono per noi pellegrini nella terra delle ombre. Ciò che li ha resi santi, la carità, vale a dire la compassione nei confronti degli altri, continua a motivare le loro azioni anche dopo la morte. Perché, come si rese conto Simone Weil, è la carità il vero atto soprannaturale: le lacrime che Gesù versa non per il proprio dolore, ma per quello degli altri, sono frutto di un processo fisico motivato da una causa soprannaturale. “In tal senso ed esclusivamente in tal senso i miracoli di un santo sono soprannaturali”, scrisse nella lettera a padre Marie-Alain Couturier nel 1942. “Lo sono allo stesso titolo di tutti gli effetti materiali della carità. Un’elemosina compiuta per pura carità è un prodigio grande quanto camminare sulle acque”. Si tratta di miracoli ancora più rari di quelli di guarigione, dai quali potremo riconoscere, forse, i santi di domani.