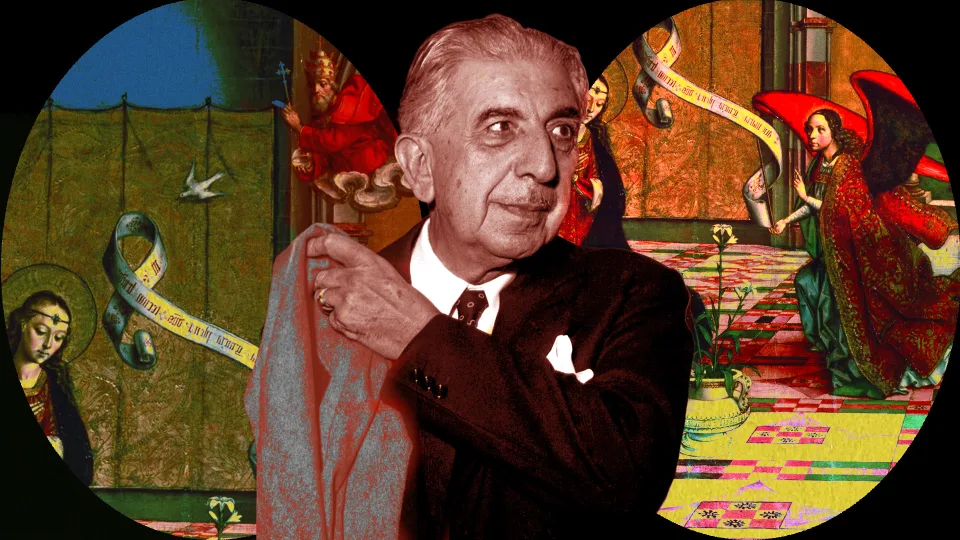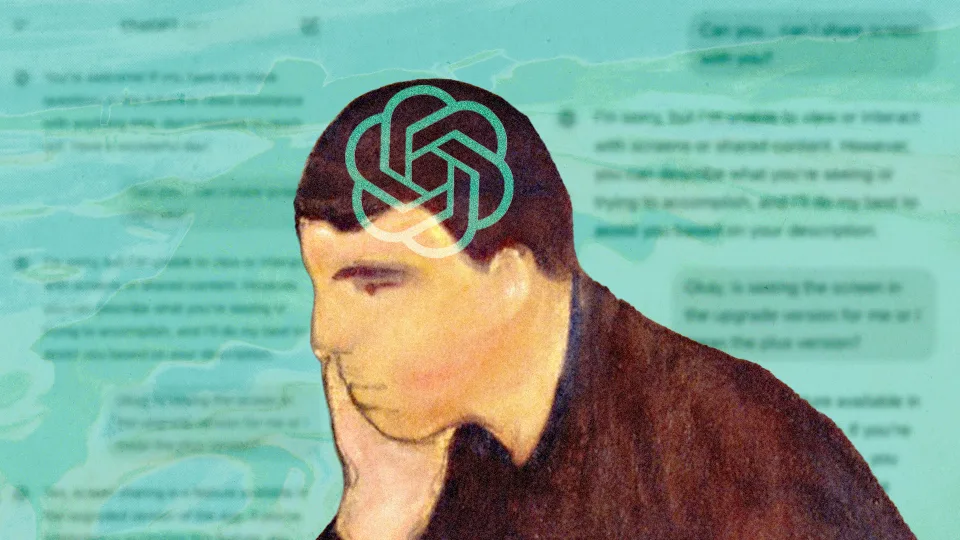Le riviste letterarie hanno da sempre rappresentato lo spazio ideale per scoprire nuove voci, coltivarle, permettergli di sperimentare. Oggi, l’annuncio della chiusura di «Colla», dopo sedici anni e trenta numeri, segna la fine di un’epoca, ma forse anche l’inizio di un nuovo ciclo.
Nella lista dei miei desideri stupidi e impossibili da realizzare, c’è una realtà alternativa fondata sul fatto che Michael Chabon è nato in Italia a cavallo degli anni Ottanta. Non ha scritto Le fantastiche avventure di Kavalier e Clay perché non si è mai appassionato di storia del fumetto americano e supereroi. Non ha neanche vinto un Pulitzer, ma non se ne rattrista perché ignora che sarebbe potuto accadere.
In compenso, questa versione alternativa ma non meno talentuosa di Michael Chabon, che chiameremo Michele Cabone, ha potuto seguire da vicino, ma da posizione defilata, lo sviluppo delle riviste di racconti in Italia e, a un certo punto, con la spavalderia di chi se ne infischia delle regole (e nello specifico di quella per cui a nessuno frega niente dei romanzi che parlano di editoria), decide di convogliare le proprie energie su una storia che racconti la scena editoriale italiana degli anni Duemila.
Senza farla più complicata di quel che è, i protagonisti del suo romanzo non creano un fumetto con un supereroe originale, ma una rivista letteraria indipendente.
Qualche settimana fa io e Marco Gigliotti abbiamo caricato online il nuovo numero di «Colla – una rivista letteraria in crisi». Il nuovo e l’ultimo. Dopo sedici anni e trenta numeri, abbiamo deciso che fosse arrivato il momento di staccare.
«Colla» ha esordito nel 2009 con uno scimpanzé viola in copertina e, tra gli altri, un racconto dal titolo Un pezzo dolce dolce dolce che farà sciogliere i cuori di tutti come panna montata.
Volevamo scoprire autori e pubblicare racconti che ci piacessero. Niente che non avessero già fatto e che non stessero facendo altre riviste. Semplicemente volevamo procedere a modo nostro, seguendo i nostri gusti e alcuni punti fermi.
Primo: pur esistendo solo online, avremmo pubblicato racconti più lunghi e articolati di quelli che giravano normalmente su internet. Il supporto digitale stava spingendo molte riviste a puntare su narrazioni in cui trovavamo delle caratteristiche ricorrenti: una situazione originale di partenza; una scrittura brillante; una progressione rapida verso il finale. Leggevamo moltissimo sia le riviste online sia quelle cartacee sia le antologie collettive dedicate agli esordienti. Non di rado c’erano nomi che ritornavano e spesso le cose che pubblicavano su cartaceo ci colpivano maggiormente. Erano più rifinite, compiute, curate.
Insomma, puntavamo a narrazioni capaci di mantenere la loro vitalità sulla lunga distanza e non volevamo che l’esigenza di una fruizione veloce da schermo ci limitasse nella ricerca e nella selezione dei racconti (in fondo chiunque avrebbe potuto stamparli).
Secondo: avremmo editato con attenzione ogni racconto, cercando di arrivare insieme agli autori alla migliore versione possibile.
Terzo: avremmo fatto da ponte con le case editrici.
Dal 2005 al 2007 tre antologie minimum fax (Best off 2005, a cura di Antonio Pascale; Best off 2006, a cura di Giulio Mozzi; Voi siete qui, a cura di Mario Desiati) avevano annualmente scandagliato le riviste letterarie per poi proporre i migliori racconti e interventi apparsi.
Sempre nel 2007, a Cuneo, nell’ambito della manifestazione Scrittori in città, era nato Esor-dire. A un gruppo di addetti ai lavori, scuole di scrittura, riviste letterarie, veniva chiesto di segnalare scrittori esordienti con un progetto di romanzo o raccolta in corso. Di questi ne venivano selezionati otto, che avrebbero letto degli estratti davanti a diversi editor. La stessa formula era poi stata ripresa da Roland Macchine e Animali.
La sensazione era che i nuovi autori di cui avremmo letto le opere più importanti degli anni a seguire sarebbero arrivati da lì, da quel sottobosco fatto di riviste e blog letterari eterogenei. Luoghi a volte più formali, quasi istituzionali, come «Nazione Indiana» o «Carmilla Online», spesso invece caratterizzati da un approccio rilassato, al limite del cazzeggio. Un sottile equilibrio tra il non prendersi sul serio ma fare le cose sul serio, che spesso era già racchiuso nei nomi: «Toilet – racconti brevi e lunghi a seconda del bisogno», «inutile», «FoLLeLFo», «Il traghetto mangiamerda», «Teflon – la rivista a cui non si può aderire» (diventata «Tupolev – la rivista che cade circa una volta l’anno» dopo aver rischiato di essere trascinata in tribunale dalla marca di padelle che deteneva il marchio Teflon), «Eleanore Rigby – Il più importante pamphlet letterario al mondo», «FaM – Frenulo a Mano. Rivista di letteratura fica».
Ed erano state proprio «Eleanore Rigby» e «FaM» a organizzare nel 2007 il primo meeting delle riviste letterarie: BIRRA (Bagarre Internazionale Riviste Alternative). Altro nome cazzeggiante per un festival che è rimasto impresso nella memoria di chiunque frequentasse l’ambiente, ospitando rappresentanti di «McSweeney’s», «The Believer», «Granta». Quando due anni dopo abbiamo annunciato «Colla», la scena delle riviste stava cambiando. Alcune di quelle che consideravamo dei riferimenti si erano fatte da parte ed era in corso uno dei tanti periodici, e fisiologici, passaggi di testimone a cui avremmo assistito in seguito.
La quasi totalità di riviste letterarie, intese come riviste di racconti, soprattutto online, non ha un piano a lungo termine. Il fine economico manca, non ci sono entrate e non sono previste. Fedeli allo spirito delle vecchie fanzine, il motore è la voglia di esprimere la propria visione, aggiungere un tassello al discorso letterario, lasciare un segno, mescolarsi e confrontarsi con gente che prova a fare lo stesso. Un divertimento e un’attività militante insieme, da portare avanti con la convinzione di alimentare qualcosa di importante, perfino necessario (almeno per chi si rivede in un certo tipo di letteratura). Una passione che a volte incrocia il percorso professionale, spesso no, a cui dedicare energie nel tempo libero, e che per sua natura è destinata a perdere centralità man mano che la vita adulta avanza e gli impegni (lavorativi, personali, familiari, ecc.) si moltiplicano.
Anche nel momento di maggior splendore delle riviste letterarie indipendenti degli ultimi venticinque anni, la dinamica è stata più o meno la stessa: progetti nati in un ambito universitario o post universitario, che nei casi più riusciti si sono imposti all’attenzione con impeto, diventando presto dei punti di riferimento per chi volesse pubblicare racconti, leggere autori ancora sconosciuti o testi inclini alla sperimentazione; ma che hanno esaurito la propria spinta altrettanto presto: due, tre, cinque anni. È sempre stato nell’ordine delle cose, come il fatto che altre riviste sarebbero arrivate a colmare quel vuoto.
In questo senso, i sedici anni di «Colla» costituiscono un’anomalia, pur essendo stati segnati da una frequenza delle pubblicazioni e da una partecipazione al dibattito culturale che, col tempo, si sono progressivamente attenuate.
Come rappresenta un’anomalia il fatto che «‘tina», fondata nel 1996 da Matteo B. Bianchi con la semplice intenzione di diffondere i racconti meritevoli di amici, conoscenti, emeriti sconosciuti, e diventata nel tempo un faro per chiunque voglia “fare rivista”, a distanza di quasi trent’anni sia ancora lì, capace di cambiare, rinnovarsi, passare dall’online al cartaceo, restando sempre fedele a se stessa.
A differenza di quanto accade con le chiusure di librerie e case editrici indipendenti, legate a una crisi dell’editoria sempre più tangibile, la chiusura di una rivista letteraria si inserisce allora spesso in una dinamica diversa e inquadrabile in un naturale cambio generazionale.
«Colla» è stata fin dall’inizio anche un modo per metterci alla prova. Lo spazio in cui fare scouting, scoprire per primi voci che valesse la pena seguire, imparare a confrontarci con gli autori a partire dai loro testi.
Per tanto tempo mi è sembrato incredibile che la partecipazione a una rivista letteraria non fosse considerato un requisito chiave per chiunque immaginasse di lavorare in editoria. Ben più di un master. Quando ho iniziato le prime collaborazioni con agenzie letterarie e case editrici, mi stupivo nello scoprire che chi animava “l’editoria ufficiale” spesso avesse un’idea solo vaga di ciò che succedeva tra le riviste. Era passato appena qualche anno da Voi siete qui, dal primo Esor-dire, dal BIRRA, e quel fermento, quel filo conduttore tra riviste letterarie e editori sembrava già un lontano ricordo. Nel tempo la frattura si è allargata, con le ricerche editoriali che hanno virato in modo deciso su scritture e romanzi di cui (a eccezione di memoir e autofiction) è obiettivamente difficile intercettare i prodromi su rivista. Storie, temi, più che voci, con uno spostamento dell’asse verso il “cosa” si racconta. Il “come” continua a essere importante, ma spesso in un rapporto di subordinazione e funzionalità.
“La quasi totalità di riviste letterarie, intese come riviste di racconti, soprattutto online, non ha un piano a lungo termine. Il fine economico manca, non ci sono entrate e non sono previste. Fedeli allo spirito delle vecchie fanzine, il motore è la voglia di esprimere la propria visione”.
Questo non è però un problema di cui le riviste possono farsi carico. Venuto meno il senso di quel dialogo instaurato in passato con gli editori, le riviste letterarie indipendenti hanno ancora più ragione di esistere. Non come un ingranaggio della macchina, piuttosto come una realtà a sé stante. Uno spazio parallelo in cui continuare a cercare un concetto di letteratura lontano dal mainstream. Progetti con un’identità forte, originali nelle premesse, magari strani, folli, o solo portati avanti con un tale livello di eccellenza e cura da meritarsi il proprio gruppo di affezionati. Penso a quanto fatto in passato da «Watt» in soli tre numeri, da «Abbiamo le prove», o più recentemente da «Apri» con i suoi racconti per corrispondenza.
Tornando a Michael Chabon/Michele Cabone, ho solo un’altra richiesta per il suo romanzo immaginario. Mi piacerebbe che fosse pieno di personaggi e che tra questi avesse un ruolo centrale un alter ego di E.P.
Oggi non so più nulla di E.P., ma negli anni iniziali di «Colla» avevamo una corrispondenza abbastanza fitta. Chiunque fosse nel giro delle riviste, e non gli stesse sulle palle, aveva una corrispondenza abbastanza fitta con lui.
E.P. era tra i fondatori di un blog letterario collettivo. Sapeva moltissimo di narrativa italiana contemporanea e, in particolare, dava l’idea di conoscere ogni autore che avesse pubblicato racconti su spazi da lui ritenuti validi. Simpatizzante e curioso nei confronti dell’editoria indipendente (ma non senza sguardo critico), mostrava diffidenza verso tutto ciò che avesse vagamente a che fare con l’editoria generalista.
Nei miei ricordi è passata qualche ora da quando abbiamo pubblicato il primo numero di «Colla» a quando ci è arrivata la prima email di E.P. In poche righe ci faceva i complimenti, ci dava non troppo velatamente dei fighetti, mostrava un sincero interesse a sapere tutto di noi. Non gli avevamo ancora risposto che si era già attivato per metterci in contatto con qualsiasi altra rivista esistente nel 2009.
In quel periodo sembrava che niente accadesse nel giro delle riviste e della piccola editoria senza che E.P. fosse più o meno implicato. E al contempo in pochi potevano dire di averlo davvero visto o incontrato. Era come se, per un tacito accordo stipulato alla sua nascita, gli fosse stato affidato all’unanimità il ruolo di centro focale ed equilibratore di quel mondo sommerso. Un ruolo che, nell’insensatezza e nel romanticismo della cosa, ricopriva con sorprendente naturalezza.
Per qualche anno, due, tre, forse cinque, E.P. ha creato connessioni, sviluppato progetti, organizzato eventi, perseverando nello scopo di “fare rete”.
Poi, semplicemente, come fosse lui stesso una rivista, a un certo punto si è fatto da parte.