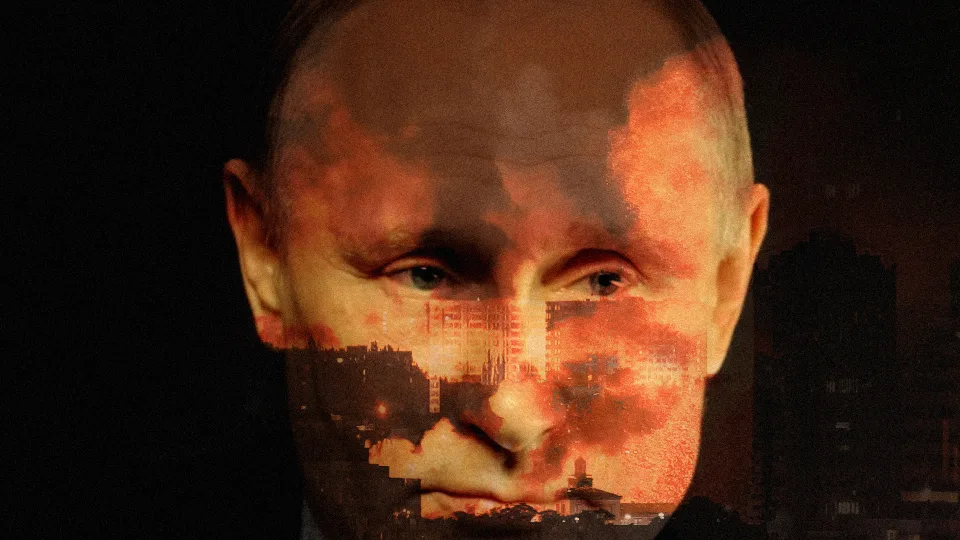Raccontare il trauma, disegnare il paesaggio, non smettere mai di sperimentare: una conversazione con una delle fumettiste europee più interessanti, in occasione della sua prima mostra italiana.
Dominique Goblet è una delle fumettiste e illustratrici più interessanti del panorama europeo. Nata nel 1967, ha iniziato a fare fumetti negli anni Novanta. Pioniera della graphic novel e del fumetto d’autore per come lo conosciamo, non ha mai abbandonato la ricerca e la sperimentazione.
Quella che segue è parte di un’intervista realizzata dall’associazione Hamelin durante la progettazione della mostra Costellazioni, la prima monografica di Goblet in Italia, presentata durante la seconda edizione del festival bolognese A occhi aperti. Disegnare il contemporaneo. L’intervista integrale è stata pubblicata nel volume Paesaggi di carne, edito da Sigaretten Edizioni Grafiche. Si tratta del primo libro di Goblet uscito in Italia. Un estratto di questa intervista è uscito anche sullo speciale che la rivista «Gli Asini» ha dedicato all’edizione 2024 del festival e al suo tema: il rapporto tra corpi e paesaggio.
La mostra è aperta e visitabile a Bologna, alla ex Chiesa di San Mattia, fino al 15 dicembre.
Le tue opere si collocano in un territorio difficile da circoscrivere: fin dai tuoi esordi, infatti, ti sei avvicinata al fumetto con un approccio sperimentale. Come è nata questa tua relazione particolare con il disegno?
Ho cominciato a disegnare molto presto, non per passione ma per noia. Sono cresciuta in una famiglia modesta, per non dire povera. Mio padre faceva due lavori, pompiere e carrozziere nel garage di mio nonno; mia madre a volte faceva le pulizie a casa di una baronessa e mi portava con sé. Mi metteva al tavolo, mi dava dei fogli e mi diceva: “Vai, disegna”. Non so se avessi già allora un talento, penso piuttosto che ogni persona abbia delle inclinazioni, come preferire il suono all’immagine. Io sono sempre stata affascinata dalle immagini, fin da piccola mi piacevano i libri con le figure. A casa c’erano pochi fumetti perché mia madre, una donna piuttosto colta, li trovava inutili. Lei leggeva moltissimo perciò avevamo una libreria molto fornita; mio padre invece non era particolarmente interessato alla cultura.
Se ripenso a quando ho iniziato a leggere, credo che soffrissi di una forma di dislessia mai diagnosticata; non capivo le lettere e tutte le cose astratte che rappresentavano. Allora mia madre si arrabbiava con me e, per la disperazione, aveva chiesto a mio fratello di due anni più grande di insegnarmi a leggere. Per lui la lettura era sempre stata facile e grazie al suo aiuto ce l’ho fatta anche io. Ma quello che mi interessava più di tutto erano le figure.
Quali sono stati i tuoi primi incontri con i libri con le figure?
Se penso alla mia relazione con le immagini, mi vengono in mente due ricordi chiave. Abitavamo a Tervuren, vicino a Bruxelles, in una casa senza acqua calda, senza bagno, senza televisione, quasi senza riscaldamento: avevamo appena due stufe per tutta la casa. Eppure, non so per quale motivo, i miei genitori erano riusciti a trovare una casetta al mare che hanno affittato per qualche anno. Era in pessimo stato, ci pioveva dentro. Ogni tanto ci andavamo anche noi, e ho in testa una scena molto chiara: mio fratello aveva portato lì uno dei suoi fumetti, forse un Tintin, e io mi ero divertita a disegnarci sopra. Quando i miei lo scoprirono mi fecero una predica: non avrei dovuto farlo perché “i libri sono amici”. Io non capivo: con gli amici si gioca e si disegna, dunque per me era normale disegnare sui libri.

L’altro ricordo risale a un regalo di compleanno che mi fece mia nonna paterna: un grande libro di fiabe russe, pubblicato negli anni ’70, con grandi illustrazioni romantiche a matita e acquerello. Leggendo mi perdevo in una sorta di contemplazione, una reverie. E leggevo davvero, perché il testo era accompagnato da immagini straordinarie, che mi facevano sognare. Iniziai anche a copiarle. Quel libro è stato la prima volta in cui mi sono completamente innamorata di un’immagine. Oggi mi rendo conto che la mia fascinazione per l’illustrazione e il fumetto si è ribaltata: adesso ho più a cuore la scrittura che il disegno, ma il punto da cui sono partita è esattamente l’opposto. E ho sempre pensato che, quando si sceglie un linguaggio per la propria pratica artistica, questo vada usato secondo le sue specificità.
Quali sono per te le specificità dell’illustrazione e del fumetto?
L’aspetto che più mi affascina del fumetto e dell’illustrazione è che hanno tre livelli di lettura: il disegno, la scrittura e l’incontro fra i due, che è una terza lettura. Ad esempio: se vediamo l’immagine di una bambina che corre in un giardino di notte e il testo recita “La bambina dormiva”, dobbiamo fare una somma dei due elementi. Siamo testimoni del fatto che i genitori pensano che la piccola dorma, mentre lei vive un’avventura in giardino. Questo meccanismo permette di raggiungere un grado di complessità impressionante.
Un’altra caratteristica è che la scrittura è incorporata nel disegno: è un’immagine grafica, anche quando si decide di renderla il più neutra possibile. Allo stesso tempo, l’immagine è scrittura: si può raccontare una storia intera senza usare nemmeno una parola. Nonostante questo, nella nostra società il valore letterario delle immagini non viene riconosciuto; se un bambino o una bambina parla di una figura non si dice che “legge”. Già da piccola, però, io avevo capito che sapevo leggere e scrivere benissimo con le figure, e nel tempo questa è diventata la mia caratteristica.
“L’aspetto che più mi affascina del fumetto e dell’illustrazione è che hanno tre livelli di lettura: il disegno, la scrittura e l’incontro fra i due, che è una terza lettura”.
Uno dei tratti distintivi del tuo lavoro è proprio l’approccio “laterale” al disegno. A ogni nuovo progetto scegli una struttura, una forma e una tecnica diverse. Questa attitudine all’esplorazione è legata inevitabilmente anche all’epoca in cui hai iniziato a pubblicare: i primi anni Novanta hanno segnato una fase di rivoluzione nel fumetto, e in quel periodo sei entrata in contatto con il gruppo di artisti che poi ha dato vita all’avventura editoriale di Frémok. Ci racconti di quella stagione?
Ho conosciuto il gruppo che avrebbe dato vita a Frémok quando studiavo illustrazione all’Institut Saint-Luc a Bruxelles. Avevo sentito dire che alcuni ragazzi del corso di fumetto avevano fondato un collettivo per creare storie completamente diverse dal cosiddetto 48 CC, il classico volume cartonato in stile linea chiara franco-belga che allora era ancora considerato la norma. Incontrarli è stata una grande rivoluzione per me. All’epoca conoscevo poco il fumetto, ma il mio carattere ribelle mi ha spinto ad abbracciare la sperimentazione come una causa.
Come avete iniziato?
Siamo partiti dalle riviste. Dal 1992 al 1995 abbiamo pubblicato “Frigobox”, e una volta all’anno “Frigorevue”, un’edizione speciale e più raffinata che usavamo per fare ricerca sui formati e sulla carta. Volevamo innovare e avevamo deciso che le nostre produzioni sarebbero state una combinazione di fumetto e illustrazione. Fin dal primo anno in cui ci siamo costituiti in gruppo, Thierry van Hasselt, futuro fondatore di Frémok, ha avuto un’idea geniale di cui ancora oggi si vedono le conseguenze. Lui ha sempre creduto alla forza del gruppo, alla necessità di unirsi per fare fronte al potere dei grandi editori mainstream, così nel 1992 inventò il festival Autarcic Comix, che riuniva editori indipendenti di fumetto da tutta Europa. Alla prima edizione, a Bruxelles, parteciparono editori che hanno fatto la storia della scena alternativa: L’Association, Le Dernier Cri… La seconda edizione si tenne a Parigi, e fu lì che incontrammo Amok, un’altra casa editrice fondata da Yvan Alagbé e Olivier Marboeuf. Nel 2001 ci siamo fusi con loro dando vita a Frémok. Anche grazie al festival, i gruppi si sono rinforzati a vicenda e il paesaggio del fumetto si è trasformato. Autarcic Comix ha fatto spostare la scena franco-belga verso quello che oggi chiamiamo fumetto indipendente.
In quel contesto tu eri una delle poche voci femminili…
All’epoca ci saranno state dieci donne in tutto nel fumetto indipendente. L’anno in cui mi sono diplomata, il festival di Angoulême organizzò una mostra di fumettiste a cui era invitata un’artista per ogni paese europeo. Io dovevo rappresentare il Belgio ed ero eccitatissima. Grazie a quella mostra ho incontrato Anke Feuchtenberger e mi sono innamorata del suo lavoro. Più tardi, insieme a lei e ad altre autrici, come Caroline Sury, provammo a creare un gruppo, ma eravamo talmente scoraggiate dalle reazioni dei nostri colleghi che alla fine abbiamo desistito. Gli uomini del nostro campo opponevano una resistenza assoluta ai nostri tentativi di unirci. La parola femminista era praticamente un insulto per loro, le femministe erano donne arrabbiate che non si depilavano e rifiutavano il sesso. Erano le brutte, le rozze, le represse, le aggressive. Ai nostri tempi – parlo di donne che oggi hanno tra i cinquanta e i sessant’anni – sarebbe stato importante mettersi insieme, ma era difficile. Molte di noi hanno trovato dei modi per resistere, ma fuori da una dimensione collettiva.
Nel contesto che descrivi l’innovazione è un elemento imprescindibile, che ha dato forma al tuo lavoro ed è rimasto centrale nel discorso che ancora oggi porti avanti. Quali sono state le tue influenze visive, i riferimenti più importanti?
Da giovane non mi approcciavo troppo al fumetto perché non volevo che le mie influenze artistiche provenissero dal mio stesso territorio e dalla mia stessa generazione. Quando cercavo ispirazione nel fumetto mi rivolgevo per esempio a quello giapponese; non quello contemporaneo, perché già all’epoca era pieno di persone affascinate dal manga, ma al disegno classico. Se ti lasci influenzare da ciò che, in un dato momento storico, rappresenta lo spirito del tempo finisci per aderire a quello spirito, e io non mi sono mai fidata dello spirito del tempo. Mi è sempre sembrato più importante andare alla ricerca di uno shock, spingermi oltre i confini del linguaggio con cui lavoro.
Una delle mie influenze principali è stata la pittura medievale. Un artista fondamentale per me è Stéphane Mandelbaum, pittore e disegnatore neoespressionista belga, assassinato durante il furto di un quadro di Modigliani. Alcuni aspetti del suo immaginario combaciano con il mio: un universo adulto ma con echi d’infanzia, un modo particolare di rappresentare la violenza e l’unione di testo e immagine.

Poi è venuta la fotografia, una mia grande passione. Un fotografo che amo molto è Nick Waplington, che lavorava sulle fotografie di famiglia in modo immersivo. Uno dei suoi marchi di fabbrica sono le foto in cui l’elemento principale è cancellato; ricordo una sua foto di famiglia con otto persone in posa, tutte senza testa. Le sue immagini mi hanno insegnato molto sulla composizione e sui modi non convenzionali con cui si può creare intensità.
Per quanto riguarda il cinema, invece, la mia influenza più grande è Fassbinder.
Un’altra grande rivelazione è stato un pittore minimalista statunitense, Ellsworth Kelly, di cui ho visto diverse mostre, e che realizza quadri con forme geometriche molto semplici, giocando tutto sul rapporto tra vuoti e pieni.
Arriviamo al paesaggio. Attualmente stai lavorando a una trilogia, Derrière, che esplora proprio questa dimensione, ma in realtà il paesaggio ha sempre avuto un ruolo importante nei tuoi libri. Sembra quasi avere un potere rivelatorio, fare da eco ai personaggi e alle loro storie.
A un certo punto della mia carriera, ho cominciato a disegnare paesaggi. È successo mentre lavoravo a Souvenir d’une journée parfaite. In testa avevo la nozione di pausa: fare un paesaggio voleva dire concedermi il piacere di disegnare qualcosa che non fosse un personaggio, di portare il disegno verso l’astrazione. Quando uscì quel libro, nel 2001, era raro che una fumettista dedicasse tanto spazio a pagine del tutto prive di figure umane. Nel fumetto tradizionale, infatti, c’è una focalizzazione estrema sul personaggio, mentre io volevo invertire la tendenza, dare spazio allo spazio, chiedere ai personaggi di farsi piccoli in un paesaggio molto grande.
Il paesaggio mi permette di lavorare alle immagini in maniera musicale: il ritmo, le accelerazioni, le tensioni e i momenti di pausa, le ripetizioni, le diverse declinazioni di uno stesso tema… Sono tutti elementi che generano un senso di narratività anche dove la narrazione in senso canonico svanisce.
Il disegno di paesaggi è stato anche una scusa per sperimentare con l’astrazione e aprire un dialogo con la pittura, lasciandomi alle spalle la questione del realismo. Del resto, se disegno un albero chi potrà venire a dirmi che è troppo grande o troppo piccolo?
Nei tuoi ultimi lavori – Ostende e Les forêts sombres, i primi due capitoli della trilogia – la riflessione sugli elementi naturali e sugli spazi sembra farsi sistematica.
In realtà, quando ho iniziato a lavorare a questo progetto non avevo in mente di fare uno studio sul paesaggio. Sono arrivata nel mio studio di Ostende, sul Mare del Nord, dopo la fine di una lunga relazione; era il 2020, un giorno prima dell’inizio del confinamento durante la pandemia da Covid-19. Avevo portato con me delle tempere, non le avevo mai usate prima e ho cominciato a dipingere il paesaggio pensando fosse il soggetto più facile da fare con quella tecnica. Possiamo dire che Ostende è il risultato di un incontro fra tempo e spazio: a causa della pandemia, era come se il tempo si fosse fermato e la città, un luogo di villeggiatura che di solito è pieno di gente e di confusione, all’improvviso era deserta. Mi sembrava di essere precipitata in un quadro di Ensor, era il surrealismo.
“Fare un paesaggio voleva dire concedermi il piacere di disegnare qualcosa che non fosse un personaggio, di portare il disegno verso l’astrazione”.
Come si sono inserite le figure umane nella narrazione? C’è un’ambivalenza che emerge molto forte quando disegni un personaggio nella foresta o sulla spiaggia di Ostende. Come se ci fosse una contrattazione continua tra il bisogno umano di dire “Io sono qui, questo adesso è il mio posto” e una natura che appare indifferente.
Non avrei saputo dirlo meglio. In Ostende ci sono due personaggi che sono entrati quasi per caso nella storia. Uno è Irène, che viene dalla mia collezione di foto erotiche degli anni ‘30-’70. L’ho trovata in un ritratto di tre donne intorno ai sessant’anni, catturata nell’atto di slacciarsi il reggiseno e lanciarlo verso l’obiettivo. Ho scritto un testo a partire da quella fotografia, immaginandola connessa al paesaggio che stavo disegnando. Volevo far emergere un senso di erotismo da dietro il paesaggio; infatti, uno dei primi titoli che avevo pensato per il libro è proprio Dietro. Irène poi è diventata un’ossessione. Sembrava così radiosa nell’atto di togliersi il reggiseno! Non riuscivo a smettere di pensare a lei, a quella donna che ritrovava il suo corpo oltre da ogni canone di bellezza, si scopriva libera nella carne. L’altro personaggio è la majorette che compare alla fine del libro mentre marcia fiera sul paesaggio, come se fosse la direttrice d’orchestra della sua stessa vita.
C’è un grande scarto tra Ostende e Les forêts sombres in termini di colore, di regime… Come sei passata da un libro all’altro?
A dire la verità, il ciclo Les forêts sombres nasce prima di Ostende. È un progetto cominciato due volte: avevo disegnato una quarantina di foreste a carboncino e le ho riprese in mano dopo la pubblicazione di Ostende perché a quel punto avevo capito di voler lavorare a una trilogia. La scelta del carboncino non è casuale: è un frammento di legno bruciato che racconta il ciclo di vita degli alberi. La foresta è uno spazio ambivalente nella mitologia umana, perché è allo stesso tempo un luogo di pace e un teatro delle paure. Ed è anche legata all’infanzia: perdersi, il mostro della foresta, l’animale feroce che potrebbe divorarti…
Nella riflessione sul paesaggio, il valore simbolico della luce è centrale. Come hai lavorato su questo elemento?
Credo che l’unica chiave per raccontare il trauma sia cercare la luce, e per trovar la luce bisogna lavorare con l’ambivalenza, la propria e quella degli altri. In tutti i miei libri, io cerco la luce. Anche Les forêts sombres ruota intorno a questa ricerca: in quale punto della foresta emergerà la luce?
Lavoro spesso dandomi sistemi di regole molto rigide a cui puntualmente disobbedisco. Les forêts sombres avrebbe dovuto essere in bianco e nero, invece all’improvviso è arrivato il colore: un rosa cipria che scivola verso un rosso vermiglio, non minaccioso ma splendente, festoso. Il passaggio è avvenuto gradualmente: all’inizio l’ho usato per creare una luce simile a un’aurora e mostrare il sole che si alza sulla foresta.

Di recente, ho iniziato a preparare un fondo grigio ogni volta che faccio un disegno a carboncino. Uso pochissimo bianco, faccio un primo disegno molto realistico e lo riproduco più volte cercando di spingerlo verso il nero oppure verso una sovraesposizione. Mi ritrovo così con molte variazioni della stessa immagine, come uno slittamento generato dalla luce. Questo mi permette di semplificare: la prima volta che disegno un’immagine ho paura di non riuscire a renderla nel modo giusto ma, se la rifaccio una seconda volta, la paura diminuisce e riesco a lavorare con la pancia più che con la testa. Così, via via che procedo, non sto più disegnando il paesaggio ma la mia impressione del paesaggio. Ed è lì che voglio arrivare, perché in realtà non me ne importa nulla della foresta in sé. Se però riesco a fare in modo che un’altra persona, guardando le mie foreste, provi la stessa emozione che ho provato io davanti a quel paesaggio, allora sono riuscita nel mio intento.