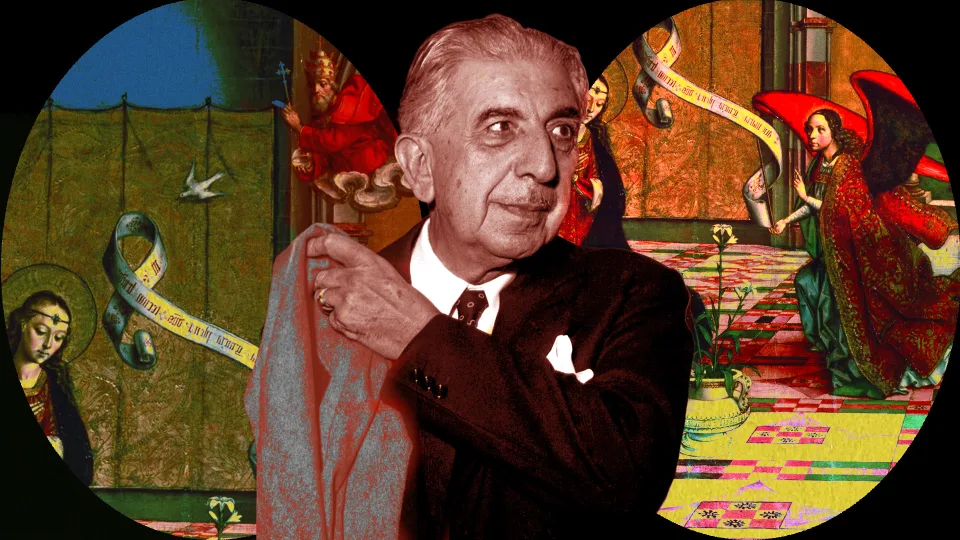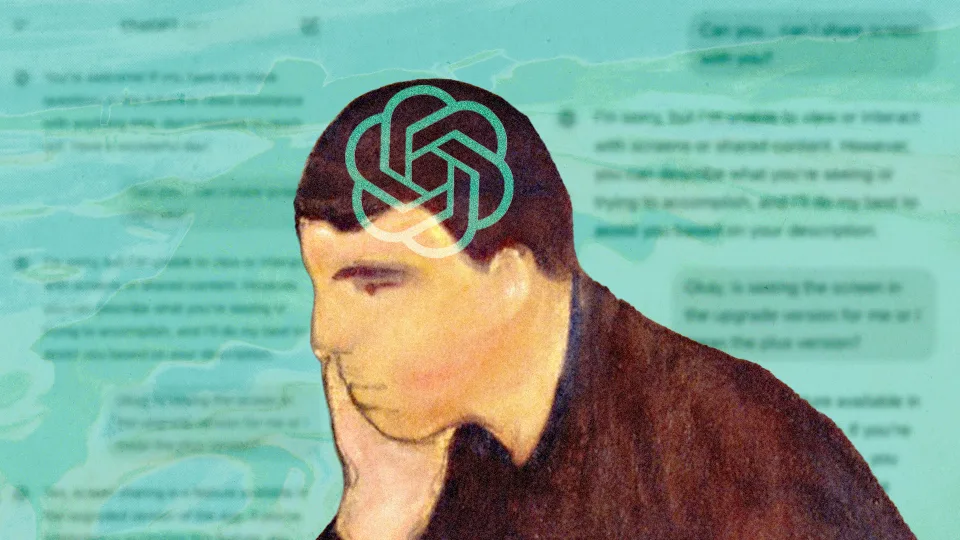Con il suo ultimo romanzo, "Disertare", lo scrittore francese prosegue un percorso originalissimo in cui intreccia storia, territorio e memoria personale,
La prima volta che ho incontrato Mathias Enard mi sono alzata alle quattro del mattino. Lo scrittore avrebbe parlato a un incontro al Salone del libro di Torino in un evento con posti limitatissimi; ecco perché la sveglia. In quell’occasione si discuteva del suo Il banchetto annuale della confraternita dei becchini, appena uscito in Italia nella traduzione di Yasmina Melaouah, per E/O. Un romanzo lungo e rabelaisiano che in esergo riporta la dedica ai pensatori selvaggi, perché “la noia e la curiosità sono le due mammelle della scienza”.
Per scoprire da quali noie e curiosità attinga lo scrittore per il suo ultimo Disertare (sempre per E/O, sempre tradotto da Melaouah), stavolta lo raggiungo al telefono mentre lui è in viaggio verso Roma, come il suo Francis del romanzo Zona, ma senza pensieri altrettanto cupi. Anzi, risponde alle mie domande con grande gentilezza e un pizzico di divertissement.
“Raccontare storie non è un affare da poco”, scriveva Tahar Ben Jelloun, e Disertare affronta questa faccenda con l’imponente serietà di due uomini che si sono accostati all’abisso della guerra: un disertore senza nome che sfugge all’orrore per scoprire che ormai quell’orrore è dentro di sé, e il matematico Paul Heudeber, illustre scienziato antifascista della DDR passato per le atrocità del campo di Buchenwald, personaggio che vive di radicalità scientifica, “nell’incrocio, nel cuore del XX secolo, tra disperazione storica e speranza matematica”. Attraverso loro, Enard racconta di trincee e linee del fronte da oltrepassare schivando i proiettili degli inseguitori: è qui che il disertore protagonista sceglie la via “dell’eremitaggio, per sfuggire alla sofferenza, per farla finita con la lunga quaresima del sangue”.
Enard ha studiato e si è formato in Medio Oriente e in Egitto negli anni Novanta, un periodo che, a dispetto delle guerre praticamente ininterrotte, sembrava contenere anche una certa dose di speranza per una pace futura. Ora, a causa dei conflitti, molti di quei luoghi sono inaccessibili, e l’impermeabilità delle frontiere, la fuga e la divisione dei muri disegnano le geografie del nuovo romanzo. Se esiste un modo per attraversare le frontiere violente, gli dico, può trovarlo solo la letteratura.
“Ma forse soltanto la letteratura ci dà la possibilità di conoscere gli altri, quando la guerra non ci concede di andare al di là di certi confini, in Paesi che sono adesso purtroppo vietati per noi. Anche il tempo, l’ultimo confine, si abbatte con il romanzo: la letteratura ci permette di tornare indietro per mostrarci cosa è successo ieri, o l’altro ieri ma anche secoli fa, ci regala da esplorare un mondo a cui non accediamo fisicamente” mi dice Enard, suggerendo le infinite possibilità della scrittura e del romanzo, la sua forma letteraria d’elezione, “capace di raggiungere oltre i confini paesi impossibili o improbabili, di conoscerli quasi di persona, perfino nel futuro, perché la letteratura può immaginare cosa succede fra dieci, venti o cent’anni. La nostra possibilità, il romanzo, è anche una forma di pensare al nostro futuro e alle nostre relazioni con gli altri”.
Se compito del narratore non è solo quello di spostare in avanti o indietro le lancette del tempo per guadagnare trame da scrivere, ma è necessario che vada alla ricerca dell’avventura umana, allora lo scrittore francese coglie nel segno. La sua scrittura attraversa lingue e paesi, riemerge da una sponda all’altra del Mediterraneo, da un confine all’altro dell’Europa. Le sue suggestioni culturali si toccano, entrano in dialogo tra loro, ed è questo che ne rende prezioso l’esercizio, si trasforma in capacità di comprendere le altre culture. “La posta in gioco è immensa: perdere una lingua, smarrirne la traccia, significa perdere parte dell’avventura umana”, affermava lui stesso durante una conferenza nel 2019, riportata in J’y mets ma langue à couper (Bayard Éditions).
“La prima volta che ho incontrato Mathias Enard mi sono alzata alle quattro del mattino. Lo scrittore avrebbe parlato a un incontro al Salone del libro di Torino in un evento con posti limitatissimi; ecco perché la sveglia”.
Nel frattempo ho recuperato il suo ultimo libro da poco pubblicato in Francia da Actes Sud, Mélancolie des confins. Nord, in cui ritornano i confini: “Le frontiere sono perlopiù invisibili. Le linee del fronte, dimenticate, non ricompaiono quasi mai. Non vediamo più nemmeno quelle che passano in mezzo a noi, così come quelle che un tempo attraversavano le città: passiamo oltre senza nemmeno accorgercene”.
Il romanzo Disertare ha una geografia ampia ma molto precisa: il Mediterraneo, Berlino, le due Germanie, il Cairo. I miliardari, in questa nuova America che Paul Heudeber odia, si spingono a conquistare Marte, e il colonialismo occidentale si sposta nello spazio. Ma quale rimane l’ultimo “altrove” della scoperta?
“L’altrove è ovunque, come diceva il filosofo francese Lévinas” (autore molto amato da Enard) “l’altrove comincia nel volto e nello sguardo dell’altro, magari non è importante capire, ma entrare in comunicazione con le differenze, osservare nell’altro da sé la bellezza della differenza, è qui da dove comincia il nostro viaggio”.
Se la Germania novecentesca di Paul Heudeber tenta con la guerra e i campi di sterminio di estirpare l’altro dalla propria cultura, sulla bellezza della differenza mi torna in mente una frase di Bussola sul genio: “tutti questi grandi uomini usano ciò che viene dall’Altro per modificare il Sé, per imbastardirlo, perché il genio vuole l’imbastardimento”. Lì il musicologo Franz ci parlava della musica orientale che si insinua nella tradizione europea dando vita a capolavori duraturi, e in Disertare Irina, figlia di Paul Heudeber, raccoglie la storia della matematica araba nella vita di Nasir al-Din al-Tusi. Forse dunque non c’è scoperta senza una mescolanza di orizzonti diversi? “Il genio vuole l’eccezionale, anche nei rapporti con l’altro, desidera la possibilità di una comunicazione molto speciale con il mondo. Se pensiamo a al-Tusi, ebbene lui era il punto più altro del sapere del suo tempo: filosofo, matematico, poeta, fisico, racchiudeva in sé tutto il sapere scientifico ed era anche un uomo politico. È stato lui ad accompagnare l’esercito mongolo nelle sue conquiste in Persia, era uomo del suo tempo in tempi molto violenti” e anche l’esercito mongolo è una sferzata di novità che scuote impetuosa l’Occidente, l’Orda d’oro che si spinge fino al Mediterraneo e cambia le sorti delle terre che attraversa.
Qualche tempo fa, durante Calibro Africa Festival di Città di Castello, ho avuto la fortuna di incontrare la scrittrice tunisina Amira Ghenim: mi disse che la letteratura nasce per consentirci di mentire, lei che da storica utilizzava la fiction proprio per giocare con gli interstizi che la storia ufficiale lascia vuoti. Allo stesso modo, Enard inventa trame intrecciandole strettamente con fatti realmente accaduti, dove la distanza tra narrazione e realtà sfuma senza più lasciarci distinguere le due forme. Accade anche in Disertare con la vita fittizia del matematico Heudeber, che attraversa una storia fin troppo reale. In che modo, gli chiedo, attinge da questo materiale reale per trasformarlo in romanzo? “L’invenzione è fondamentale per la possibilità di raccontare la storia, e il suo racconto è per necessità fiction. Non sappiamo, e non sapremo mai, cosa è successo veramente l’altro ieri, è un momento scomparso che non tornerà: ecco perché per raccontarne la storia abbiamo bisogno anche di finzione, di mettere in parole tutto quello che non c’è più. E non esiste altra possibilità se non immaginarlo, quindi la Storia degli storici è anche due parole coesistono nella stessa forma, una storia è anche la Storia, anzi, direi che tutte le storie sono la Storia. Con la letteratura dobbiamo raccontare affinché sia possibile poi leggere quello che è stato: se non fosse così, se non usassimo l’immaginazione per coprire gli angoli ciechi, non ci sarebbe neanche la Storia, svanirebbe tutto quello che non possiamo più toccare”.
Immagino, dunque, che in qualche modo lo scrittore si avvicini a una delle protagoniste del suo romanzo, Irina Heudeber, che è una storica della matematica, e quindi di fatto riporta la vita dell’illustre padre Paul attraverso i ricordi personali, vissuti però come fonti storiografiche. “Certamente, perché lei è una storica, quindi ha una forma nel raccontare le cose, anche quando parla di suo padre, come se stesse tracciando la Storia” mi dice Enard. Per Irina, tutto deve essere oggettivo, e anche nei racconti famigliari “utilizza le fonti come fanno i ricercatori, persino per parlare di suo padre e di sua madre. Le carte, i ricordi, le testimonianze della gente che li ha conosciuti, tutto concorre a diventare testimonianza. Eppure, si tratta di qualcosa di molto personale per lei, ed è proprio qui che si mescolano la Storia della ricerca e il suo racconto intimo. Irina è una narratrice che è intenta a lasciare ai margini i sentimenti per scrivere una ricognizione più o meno oggettiva della vita di suo padre, per scoprire alla fine che ciò è impossibile: non possiamo essere oggettivi con i fatti nostri”.
I ricordi sono presenti anche come materiale letterario. Il disertore del romanzo cerca un rifugio tra i monti, il mare in vista, gli ulivi e gli aranci nel profumo che porta il vento, nella baita arroccata che a lui parla di infanzia e violenza paterna. Scappa dalla guerra e dall’odore sempre presente di grasso sul fucile, di acciaio, di sudore, “puzzi di sangue e di merda, puzzi di sonno e di fame” gli dice il narratore. E difatti, “non tutto finisce con la guerra perché c’è ancora la memoria”. “Io credo che forse la letteratura sia il luogo della memoria. Un romanzo riesce a modellare e rimettere insieme brani di memoria e farne un libro, un’unità omogenea unendo i frammenti che riesce a ricostruire. Questo mosaico è l’essenza del romanzo stesso, come in Disertare, in cui tutti i frammenti compongono un ritratto più o meno complesso ma comunque unitario dei personaggi, alla fine fatti essi stessi di frammenti, cose vaghe, ricordi, paesaggi, sensazioni. E tutto può finire insieme in un composto che chiamiamo letteratura”.
“I ricordi sono presenti anche come materiale letterario. Il disertore del romanzo cerca un rifugio tra i monti, il mare in vista, gli ulivi e gli aranci nel profumo che porta il vento, nella baita arroccata che a lui parla di infanzia e violenza paterna”.
Credo di aver letto in una vecchia intervista a Enard, in cui parlava del libro precedente, Il banchetto annuale della confraternita dei becchini, che per prepararsi al romanzo aveva accumulato moltissimo materiale che si accatastava sui tavoli, e poi però aveva deciso di mollare tutto, rinchiudersi e lavorare solo di memoria su quello che aveva letto, costruendo dunque il romanzo come una riscrittura mnemonica e creativa. Sono curiosa di sapere allora come nascono i suoi romanzi, e glielo chiedo. “Io credo che se esiste un mestiere non riconosciuto, è il lavoro dello scrittore che si occupa di romanzi storici, o romanzi che hanno qualcosa a che vedere con il passato e la documentazione. Perché io in effetti non lavoro come uno storico, io non voglio dimostrare niente”, mi risponde. “Leggo molto, fonti, saggi storici, negli ultimi tempi testimonianze sulla guerra, sul Novecento, sui campi di concentramento: c’è sempre un periodo di alcuni mesi o anche di più in cui leggo e prendo appunti, ma alla fine non sono mai sistematici. Faccio sempre molto lavoro, ma da scrittore: posso permettermi di non leggere libri considerati importanti perché magari non mi interessa la forma in cui sono scritti; o posso anche viaggiare, andare a vedere una città, un monumento, ed essere totalmente libero dalle impressioni che ne ricaverò. Il mio vagabondare nella storia è da flaneur, perché alla fine è il progetto la cosa più importante, cosa voglio scrivere, ed è lì nel mio progetto che devo avere tutto quello di cui ho bisogno per la narrazione, che mi consente di costruire il mondo dei miei personaggi”. Mentre lo scrittore si racconta, a me viene in mente il Francis di Zona che elenca i luoghi che scorrono fuori dal finestrino del treno in viaggio da Milano a Roma, in un movimento perpetuo tra osservazione e racconto: “Ma io posso permettermi di dormire, a volte!” ride Enard.
Quando con Disertare comincia la scrittura di una biografia inventata di un matematico della Germania Est, la Russia invade l’Ucraina, le destre si riaffacciano prepotentemente in tutto il mondo, e la guerra entra con forza nella fiction: “A quel punto il romanzo non poteva più essere come lo avevo pensato. La Seconda guerra mondiale tornava a minacciare il mondo. L’imperialismo russo rialzava la testa, i tank sovietici T-72, che avevamo visto sparare a Vukovar, avanzavano su Odessa”. Ma è una guerra in tempo reale, un racconto che ancora non si è fatto Storia, quello su cui Enard ha deciso di lavorare: “Ho preso la decisione di raccontare la guerra che sta accadendo ora, ma di fare un passo di lato e ragionare su cosa c’è fra la guerra e la pace. Non un dualismo perfetto, o guerra o pace nell’idea di Tolstoj, ma l’esistenza di uno spazio incredibilmente letterario che si apre tra la guerra – quando il conflitto non è formalmente finito ma non c’è più, in mezzo a noi, sul territorio – e il momento ricostruttivo della pace. Ecco perché il disertore, ma anche gli altri personaggi di Disertare, si trovano in quel preciso spazio, una no man’s land tra la violenza e la pacificazione”. Disertare misura allora una geografia letteraria in scala di grigi, che non prende necessariamente una posizione assoluta tra la ragione e la follia: “Sono d’accordo, la letteratura è la possibilità di vedere quello che c’è in quella gamma di colori, anzi dopo la guerra terribile è di fatto in quei successivi, precari momenti che nasce la letteratura: il racconto che si crea subito dopo il conflitto, il vuoto strano fra due esplosioni. Il progetto di Disertare nasce proprio da questa idea”.
La deflagrazione delle bombe, d’altro canto, non è nuova nella sua prosa: “Se vuoi dedicare la tua vita alla distruzione e agli artifici, devi trovare qualcosa con cui riempire il vuoto e il silenzio che seguono all’esplosione”. È così che l’anonimo Maestro spiega a Virgilio, lo schiavo nero, l’arte dei bombaroli in Breviario per aspiranti terroristi (traduzione di Alice Volpi, Nutrimenti), pamphlet contro il razionalismo occidentale e l’integralismo religioso in cui Enard, oscillando tra Voltaire e Swift (e prendendosi gioco di Defoe) raccomanda agli attentatori non solo come collocare gli ordigni, ma anche (e soprattutto) come “dare un nome al vuoto” creato dopo la deflagrazione. È una legge sempre valida: “La natura ha orrore del vuoto, non dimenticarlo”.
Si misura spesso, lo scrittore francese, col racconto della guerra. Nel 2008 dà alle stampe il capolavoro Zona, incentrato sulla vita di Francis Servain Mirković, spia franco-croata alla sua ultima missione prima di scomparire con un’identità rubata. Francis ci racconta storie dalla sua Zona, quella navigata per lavoro che passa dal Marocco all’Egitto fino al Libano, e quella dei Balcani, attraversata col mitra in mano negli infuocati anni Novanta. Francis si sente più croato che francese, e ricorda spesso a Trieste i compagni morti in Bosnia. Quarant’anni prima di lui i membri dell’Einsatz R. si ubriacavano allo stesso modo in quella città, aspettando la morte e la sconfitta, come gli ucraini stanchi sparpagliati tra Udine, Fiume e Trieste senza parlare mai di Treblinka o di Sobibór. Francis allora ci ricorda di Stangl, ufficiale delle SS a capo di questi due campi di sterminio. Quel Franz Paul Stangl che sognava un’improbabile vittoria del Reich mentre continuava a mandare a Treblinka un numero spropositato di vittime, aggrappato all’illusione di aver nascosto i propri crimini in caso di sconfitta, che bicchiere di cognac alla mano lavava via la fatica della giornata passata a eliminare operosamente i reclusi della Risiera di San Sabba.
Come Francis, anche il disertore del nuovo romanzo non si allontana mai dal suo fucile, pronto a diventare come un poilu, uno di quei soldati del 1914, con il ricordo della guerra cacciato in gola e troppo amaro da raccontare.
Se in Zona i campi sono San Sabba e Theresienstadt, la ceca Terezín (un campo di concentramento modello per artisti e intellettuali assimilando la messinscena all’orrore), in Disertare Paul Heudeber sopravvive a Buchenwald, attraverso la matematica e la letteratura, cogitando sulla matematica che muove il mondo e componendo poesie – lui che aveva vissuto su di sé la distruzione del campo. Con Heudeber Enard racconta l’estrema violenza concentrazionaria mentre il matematico avvia un dialogo immaginario, e lo trascrive, con i geni delle generazioni precedenti nei lunghi giorni della prigionia in baracca: “Vent’anni fa sull’Ettersberg”, Enard fa scrivere a Paul in una lettera alla sua amata Maja, “cercavo le stelle assenti e pensavo agli anelli dei polinomi, ai numeri primi, a tutta la miseria intorno a me, al dolore che si accumulava, alla malattia, alla tortura e alla fame, ma soprattutto a te”.
L’Ettersberg di Paul – la famosa collina a nord di Weimar dove Goethe passeggiava e dove nel 1937 fu creato il campo di concentramento – e la macchia mediterranea chissà dove sulla mappa del disertore rappresentano una terra di pace difficile e mai duratura, in cui la morte incombe e il sangue aggalla in ogni angolo. Come in Bussola, in cui “nessuno poteva fingere di non sapere che la carne tenera degli spiedini proveniva da un mammifero sgozzato, un mammifero lanoso e belante le cui viscere erano in bella mostra fuori da ogni macelleria”, il nostro giovane soldato sogna di sparare agli uccelli, forse a un asino, o a una lepre, lordarsi del sangue caldo, berlo per saziare la fame in una vita su cui la morte si è impressa in ogni angolo.
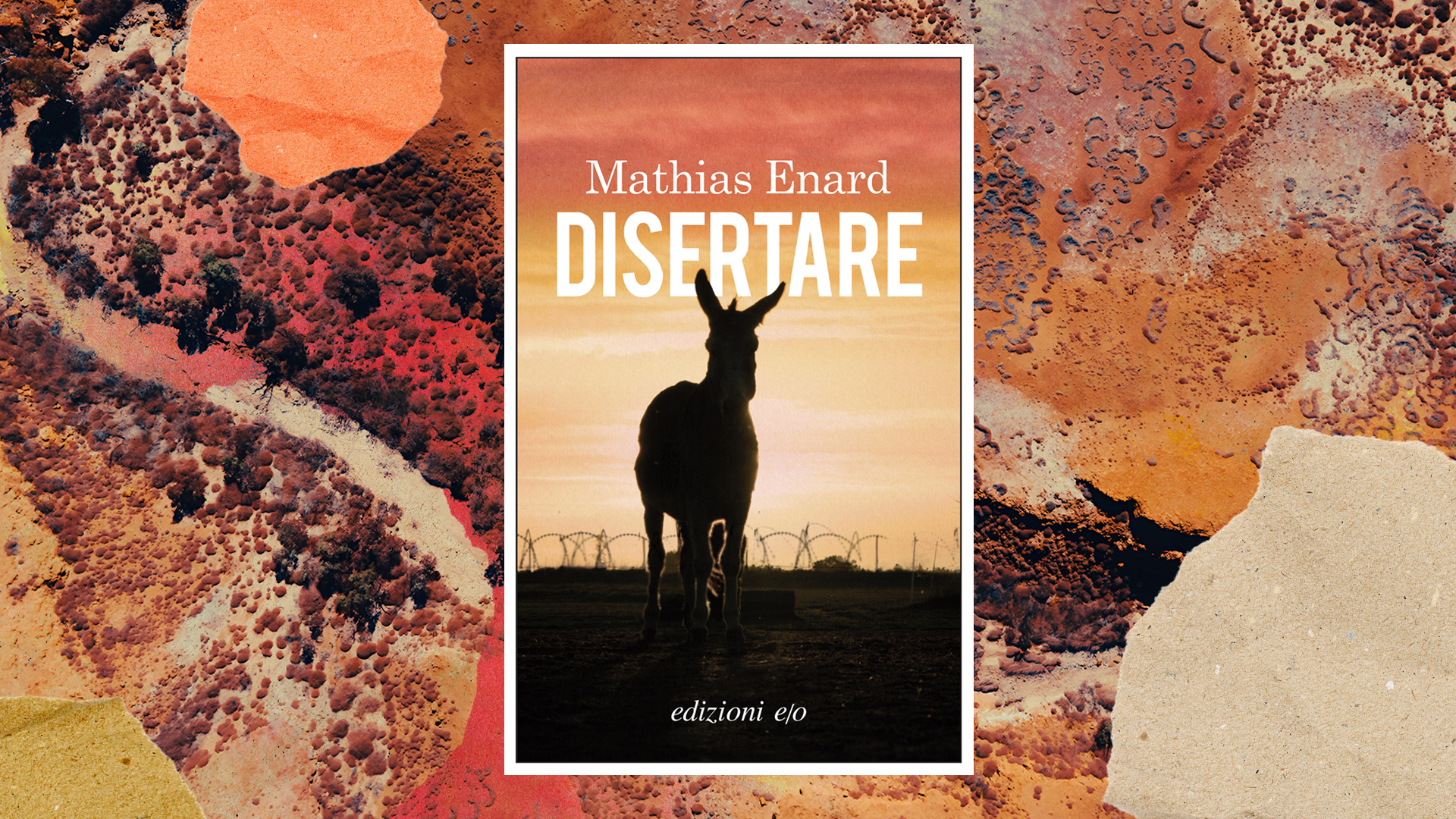
Ma la guerra è una danza sanguinosa, una faida eterna, movimenti di esuli che ne cacciano altri a seconda delle vittorie e delle sconfitte. Come è scritto in Zona, in fondo cosa importano le ragioni, quelle «per uccidere sono tutte buone in guerra». Il disordine fa comodo, favorisce gli intrighi, le razzie nella notte dell’anima, dove l’Europa non ha altra scelta che sostenere regimi moribondi contro la barbarie e l’estremismo per proteggere il petrolio, le miniere, gli abitanti dei villaggi, gli operai, i laici, i miscredenti.
Il conflitto porta nella terra mai nominata che si ritrova tra i palazzi diroccati dove si nasconde il cecchino protagonista di La perfezione del tiro, che sempre sotto il colpo dei mortai coltiva l’illusione che la vita sia altrove, quando per lui esiste solo una cosa: la scintilla del tiro, la velocità del proiettile e del desiderio di bersaglio. “La maggior parte di quelli che ho ucciso hanno vissuto solo nei tre secondi in cui li ho guardati. Sono fantasmi, personaggi, maschere incapaci di vedere” e anche qui il protagonista senza nome racconta le loro storie fissandoli nel momento della morte. Come il cecchino della Perfezione, così il soldato di Disertare è diventato una macchina di morte che non riesce più ad abbandonare la propria arma, apre e chiude la culatta ben lubrificata senza nemmeno più pensarci. Entrambi i due assassini sono curvi “sotto il mondo di ieri, curvi sotto la prospettiva del domani”.
I protagonisti dei romanzi di Enard sono spesso uomini in fuga: in Disertare il soldato, e Paul che si rintana nella DDR fuggendo dal resto del mondo, e Franz il musicologo viennese che scappa dall’amore perdendosi nei ricordi, allora la morte è forse l’ultima diserzione, almeno nei romanzi chiedo a Enard? “La morte è forse la fine delle diserzioni, perché ci arriviamo tutti come se fosse l’ultimo confine, dopo il quale siamo tutti uguali. Non per quelli che rimangono magari, ma per chi oltrepassa cadono tutte le differenze. Derrida ha scritto un breve saggio sulla morte come confine, Aporia: per lui la morte è qualcosa di aporetico, paradossale, un confine che esiste ma non si può attraversare. Lo vediamo, il confine è lì, a volte anche vicinissimo, ma non lo possiamo oltrepassare, perché quando lo facciamo non ci siamo più. È il confine ultimo tra possibile e impossibile. Se per me è vero che della morte in sé non sappiamo niente, quello che conosciamo sono tutte le sofferenze che ci portiamo dietro in questo viaggio della vita, che sono sempre presenti, e che nella letteratura sono quelle che ci interessano di più”. Passato quel confine, poi, saremo materiale per i becchini o per gli storici.