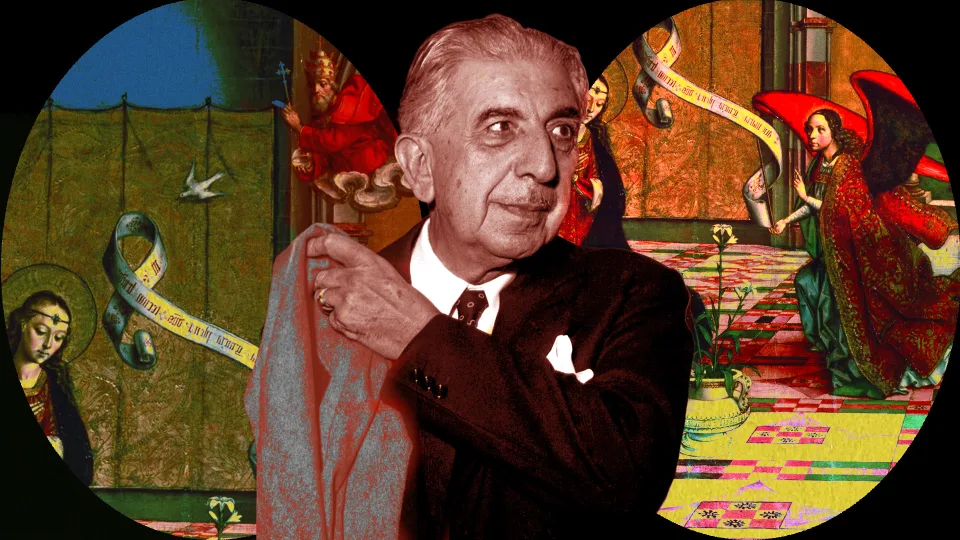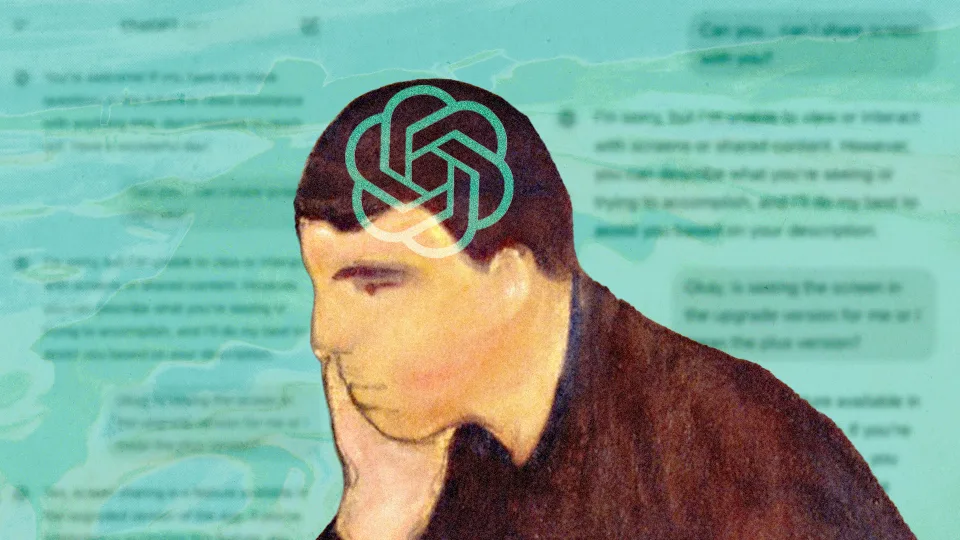Tennis, ma anche atletica leggera, pallavolo, basket femminile: interesse, tifo e senso di appartenenza coinvolgono oggi sport un tempo poco seguiti.
Nessun lutto è tanto grave, per una comunità di calciofili e allenatori, quanto la mancata qualificazione ai mondiali da parte della propria nazionale. Se in Italia, nel 2018, si masticò amaro dopo lo spareggio con la Svezia (era una prima volta) e il capro aveva – bello e pronto – il volto di Giampiero Ventura, nel 2022 la delusione fu ammortizzata dal fatto che il timoniere di allora, Roberto Mancini, avesse conquistato poco prima l’europeo a Wembley, rendendosi emblema di un’impresa che ebbe il sapore di riemersione dal covid per un popolo che raccontava a sé stesso – proprio in virtù della pandemia – di essersi meritato la vittoria quasi più degli altri.
Ora, a qualche settimana dalla nomina di Gattuso, in carica a seguito della cacciata di Spalletti e di un tonfo in Norvegia che ha già fatto presagire uno scenario non dissimile dai precedenti, può avere senso poggiarsi, per un bilancio complessivo, su un concetto espresso dallo stesso Mancini, interpellato sul tema nei giorni in cui trovare un CT sembrava un’impresa: per il calcio italiano si è, di fatto, conclusa un’epoca. E l’assioma, esteso alla finale di Champions League che l’Inter ha (suo malgrado, visto il risultato) disputato in mondovisione contro il Paris Saint-Germain, ha valore tout court.
La periodizzazione può dunque essere scandita come segue: I) un primo blocco di circa mezzo secolo, dagli albori alla Seconda guerra mondiale, con le due Coppe Rimet (antenata della Coppa del Mondo FIFA) vinte sotto il regime tra 1934 e 1938; II) i settantacinque anni compresi tra 1946 e 2021, passando da Piola a Donnarumma, che includono gli exploit di Messico ’70 (il 4-3 alla Germania allo stadio Azteca), Spagna ’82 (Paolo Rossi e l’urlo di Tardelli; la partita a carte in volo tra Zoff, Pertini, Causio e Bearzot), Italia ’90 (le notti magiche), USA ’94 (il rigore di Baggio) e Germania 2006 (il rigore di Grosso), con piacevoli intermezzi continentali quali l’Europeo del 1968 (con passaggio in finale grazie alla monetina), quello del 2000 (il golden gol di Trezeguet) e quello del 2012 (ma lo 0-4 in finale con la Spagna vanificò lo stato di forma eccezionale del miglior Balotelli di sempre). Ci si troverebbe per ciò, e già da tempo, all’interno di una terza fase, un passaggio dal contemporaneo al post-moderno in cui – oltre agli stessi vertici federali e al calcio italiano tutto – sono i tifosi a doversi adattare.
Diversi i parametri critici: scarsa integrazione di migranti nel tessuto sociale e, come diretta conseguenza, nel sistema sportivo; settori giovanili non sfruttati al meglio, in funzione di un imbuto sempre più stretto che raramente conduce in prima squadra; una storia ancora giovanissima di selezioni “under-23”, approdate al professionismo troppo di recente per poter essere accostate ai luminosi esempi spagnoli, olandesi o tedeschi; pochissimi stadi di proprietà e bilanci spesso in rosso, per lo più in mano a magnati esteri alle prese con giocattoli costosi che non sono necessariamente in grado di far funzionare. Si potrebbe continuare, ma a nulla serve il catalogo di lamentele se non ad alimentare vittimismo e malcontento.
“Nessun lutto è tanto grave, per una comunità di calciofili e allenatori, quanto la mancata qualificazione ai mondiali da parte della propria nazionale”.
All’appassionato non resta che reinventarsi: ne deriva la necessità di trovare surrogati del calcio, di sommare nuove dipendenze a quelle ormai più datate e individuare eroi attingendo, stavolta più che mai, ad altre discipline. Se non – spia di una prospettiva appena un po’ meno retrograda – allo sport femminile. Per capire il livello di astinenza da una certa ritualità estiva tutta divani, maxischermi e aggregazione, si dovrà constatare come l’attenzione del pubblico generalista si sia spostata – mai come in passato – su specialità in precedenza ignorate, declassate o pregiudizialmente ritenute minori: gli anni Venti del secolo XXI hanno fatto registrare inediti picchi di interesse per un universo extra-calcistico a lungo inesplorato. In attesa di ritornare a sostenere l’Italia ai mondiali di calcio (e con la speranza che si tratti dell’edizione 2026, che si svolgerà tra Canada, Messico e U.S.A.), gli italiani si sono accorti in massa dell’esistenza della pallavolo, che pure aveva già attraversato decenni di epoche d’oro – senza mai subire battute d’arresto, a partire dagli anni Novanta – grazie a un ricambio generazionale continuo e (qui sì) efficientissimo. E se una gran parte la fanno i trionfi, per cui il carro si allarga ed è più facile salirvi (oro olimpico nel ’24 ed europeo nel ’21 per la rappresentativa femminile; oro mondiale nel ’22 ed europeo nel ’21 per quella maschile, sorvolando sulle miriadi di medaglie e sulle vittorie in altre kermesse), un peso decisivo si dovrà riconoscere agli atleti eletti a role model: è questo il caso di Paola Egonu, giocatrice-manifesto del movimento, o di Simone Giannelli, palleggiatore di prestigio internazionale che, oltre ad essere un “bravo ragazzo”, ha già vinto tutto più volte, come moltissimi pari grado della sua generazione.
Non si può poi sorvolare sul tennis, che sta conoscendo una popolarità mai vista prima. Non solo Sinner, con tanto di folkloristici fan al seguito (i “carota boys”), chiacchiericci relativi alla sfera privata e altrettanto discutibili polemiche sulla sua “vera” italianità, sul presunto caso di doping o sul forfait alle Olimpiadi. Il discorso è più ampio, e ciò si deve anche alle prestazioni di Musetti, ventitré anni e numero 6 del mondo in singolare, alla parabola di Jasmine Paolini, arrivata al numero 4 della classifica ATP nel singolo e al 6 nel doppio, e alla seconda vita di Sara Errani (finalista al Roland Garros nel 2012 in singolare e doppista leggendaria, ora anche nel misto assieme ad Andrea Vavassori). Non che i risultati di questi atleti abbiano oscurato la memoria di Panatta, Pietrangeli, Bertolucci e Barazzutti (o di Pennetta, Vinci e Schiavone): certo però è che persino un tennista di grande talento come Berrettini, oggi come oggi, è in seconda fila.
Accanto a pallavolo e tennis, l’atletica leggera – disciplina che fino a pochi anni fa viveva del ricordo di antichi record, come quello di Mennea nei 200 metri del 1979 – sta ancora beneficiando dell’onda lunga di Jacobs, Tamberi e Tortu. Anche qui non senza punti oscuri ed episodi tutt’altro che edificanti (più o meno a caso: la spy story tra Tortu e Jacobs; l’anello nuziale smarrito dal funambolico Gimbo; le insinuazioni sull’improvvisa esplosione del nostro Marcell), ma si è giunti – senza dubbio – a un apice altrimenti impronosticabile: tanto che, tornando a Tamberi, l’eroismo si è addirittura arricchito di una cultura per l’estetica della sconfitta, come prova l’esplosione di amore nei confronti dell’altista dopo l’undicesimo posto di Parigi 2024. A fungere da contraltare, è necessaria una menzione per la lunghista Larissa Iapichino, che sta pian piano dismettendo i panni della “figlia di Fiona May” per indossare, a ridosso della maturità, abiti sempre più confacenti ai suoi meriti.
In parallelo, altri vecchi catalizzatori del nazionalismo sportivo risultano, ad oggi, staccati: si è alle prese, in questo caso, con compensazioni “secondarie”. Anzitutto i motori. Sul versante motociclistico, non è bastato un Bagnaia a far dimenticare Valentino, la cui aura continua a nutrire generazioni di aspiranti piloti e non solo in riviera, dove il giallo fluorescente del Dottore campeggia incontrastato. Ma il fatto che Rossi abbia smesso di correre, e non da poco, ha comportato, se mai, un certo calo di interesse verso il motomondiale in toto. Nonostante una carriera fuori dall’ordinario, quale è quella del pluricampione Bagnaia, è bastata un’annata di un redivivo Marc Marquez – ed è la stagione in corso – a rendere evidente il problema: più che di puro tifo per Pecco, si tratta di rancore verso lo spagnolo, le cui ruggini con Rossi da Tavullia non sono mai state davvero archiviate.
Un discorso analogo – con le ovvie proporzioni – è in piedi per la Formula Uno: già bollata come deludente la stagione dell’esordio ferraristico di Lewis Hamilton (per di più in coppia con Leclerc), ciò che rimane è il “contentino” rappresentato dal diciottenne bolognese Andrea Kimi Antonelli, premiatissimo nelle categorie minori e già a podio in Canada nel giugno ’25, cui ci si aggrappa per ripercorrere il solco di Nuvolari, Alboreto, Patrese, Trulli e Fisichella. E se nel basket si è racimolato ben poco a livello maschile, per cui la partecipazione ad una qualsiasi rassegna è già un successo di per sé, lo sguardo dei più è dirottato sulla NBA, dove ancora gioca Simone Fontecchio; è invece in ripresa la selezione femminile, che sta tornando a risultati egregi (si veda il bronzo all’europeo 2025) dopo decenni di appannamento: il plauso, da non limitare alla sola Cecilia Zandalasini (la giocatrice più rappresentativa della squadra), spetta a tutto l’ambiente.
“Per capire il livello di astinenza da una certa ritualità estiva tutta divani, maxischermi e aggregazione, si dovrà constatare come l’attenzione del pubblico generalista si sia spostata – mai come in passato – su specialità in precedenza ignorate, declassate o pregiudizialmente ritenute minori”.
Da ultimo, più mestamente, il ciclismo: senza eredi degli ultimi grandi uomini da corse a tappe (Aru e soprattutto Nibali), e a fronte di episodiche soddisfazioni olimpiche in linea o su pista, rimane il legame territoriale con il Giro, sede di una gara tanto leggendaria quanto, al momento, inaccessibile ad atleti italiani.
Ne risulta, in definitiva, la sensazione di trovarsi nel pieno di una transizione del tifo che ha livellato, verso il basso, le aspettative in ambito calcistico. Eppure, sebbene la cautela sia d’obbligo, non mancano elementi in grado di restituire fiducia anche agli amanti del calcio. La speranza sembra rappresentata dalle giovanili, per definizione portatrici di novità: basti buttare un occhio sull’under-21 di Carmine Nunziata, uscita – tra gli onori – ai quarti dell’europeo di categoria con la Germania, o sull’under-19 (fino a poco fa guidata da Bernardo Corradi, da qualche giorno entrato nello staff del Milan), che ha raggiunto tre podi consecutivi nella medesima competizione, conquistata nel 2023.
E l’under-17? Campione nel ’24, semifinalista quest’anno. Si tratta, certo, di esempi privi di valore in senso assoluto: ma su una simile base – oltre che sulla memoria di ferite ancora difficili da rimarginare – può fare leva la volontà di rinnovamento di chi, sul ricambio, non potrà che investire. Al tutto abbinando, possibilmente, la rinuncia a una mitologia “passatista” – figlia del moderno culto della nostalgia – che rischia, più che di fungere da stimolo, di tramutarsi in fardello, e non solo per il calcio. Vero è che in tempi di magra (complici le regate di Luna Rossa) fummo capaci di puntare sveglie nel cuore della notte e scoprirci, al mattino, esperti di spinnaker: ma forse, prima di ripiegare sull’America’s cup, si può ancora sperare che a farci stare svegli sia il prossimo mondiale americano.