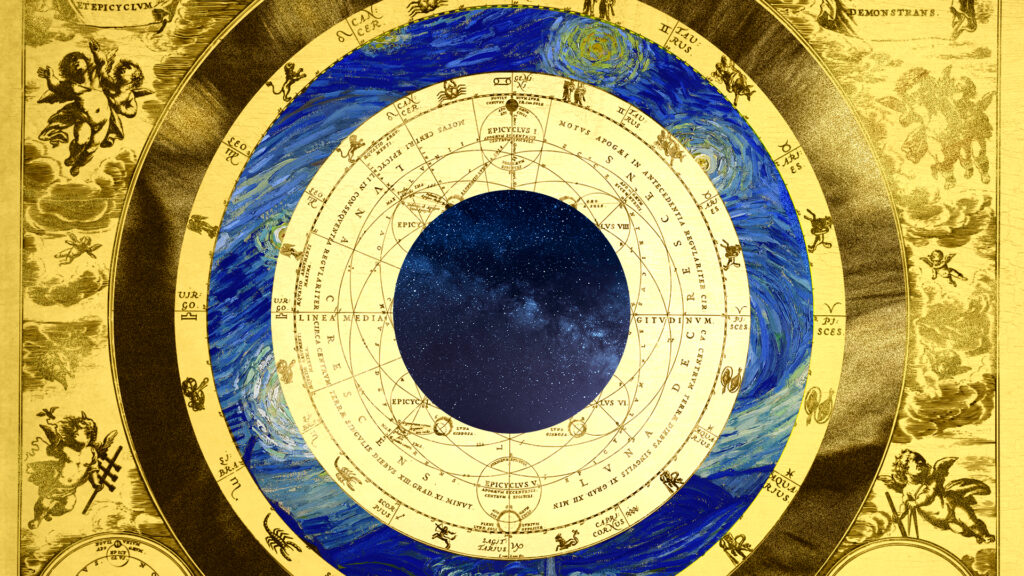Nicola Lagioia
La guerra vista dal mondo arabo: intervista a Paola Caridi

15 Novembre 2023
Paola Caridi è una giornalista di spessore internazionale che da anni racconta e studia il Medio Oriente. Negli ultimi anni, chi come lei vive e conosce l’area, ha assistito allo svolgersi di eventi prevedibili e allo stesso tempo inevitabili, anche a causa del vuoto informativo che ha inghiottito la Palestina e i suoi abitanti. Abbiamo parlato con lei di quello che sta succedendo oggi, tra responsabilità schivate, patti violati e un futuro molto incerto.
Paola Caridi si occupa da oltre vent’anni di Medio Oriente e Nord Africa. Giornalista e saggista, cofondatrice e presidente di Lettera22 (associazione di giornalisti specializzata in politica estera), ha lavorato come corrispondente dal Cairo dal 2001 al 2003, e da Gerusalemme per i successivi dieci anni. Tra i suoi libri c’è Hamas, la cui nuova edizione è in corso di pubblicazione per Feltrinelli ed è appena uscita negli USA per Seven Stories Press. Caridi è un’esperta di mondo arabo, ed è una delle persone con cui ho sentito il bisogno di parlare dopo gli attentati terroristici del 7 ottobre e l’esplosione di questo nuovo terribile conflitto.
Ciao Paola. Mentre scrivo ti trovi in Giordania insieme a tuo marito Filippo Landi, anche lui giornalista. In Italia c’è una discussione molto accesa e molto confusa, mi sembra. Com’è la guerra vista da più vicino?
Ero a Roma, il 7 ottobre, una vera e propria cesura della storia del Medio Oriente. Filippo ed io dovevamo partire il giorno dopo per Amman, per il nostro “solito” viaggio organizzato da mesi nei luoghi in cui abbiamo vissuto tanti anni. Cosa fare, dopo la notizia dell’attacco terroristico dentro Israele compiuto da Hamas? Partire, oppure rimanere in Italia? La risposta è stata semplice, immediata. Partiamo, staremo meglio a osservare ciò che succederà “dall’altra parte”. È tutta una questione di prospettiva.
Ed è questa la risposta alla tua domanda: il problema è proprio da dove guardare la guerra. Molti la guardano da fuori, come fosse un videogame. Anche il sangue, il tremore dei bambini feriti, il brusio delle persone che cercano i propri cari attorno ai crateri prodotti dalle bombe lanciate dai caccia israeliani sul campo profughi di Jabalia. Un formicaio pieno di voci, insostenibile per la coscienza. Anche ad Amman la si guarda da fuori, la guerra. Dagli schermi di al Jazeera e delle altre tv satellitari arabe. Dov’è la differenza tra guardare le immagini trasmesse in tv a Roma o ad Amman? Non è per la distanza, perché tra Amman e Gaza ci sono comunque duecento chilometri. Semmai, ed è quasi scontato dirlo, per la storia, la cultura, la lingua. La differenza più grande, tuttavia, è proprio nelle immagini che giungono da Gaza. Quelle che si vedono in Italia, edulcorate o del tutto ignorate, non sono quelle che si vedono qui.
E tutto è diverso: le immagini, gli oltre novemila uccisi sotto le bombe, i duemila ancora sotto le macerie, le decine di migliaia di feriti che a manciate muoiono ogni giorno perché non c’è carburante per i generatori. E poi ci sono gli astanti, qui, attaccati a quelle immagini ovunque, perché le tv sono accese ovunque, dal barbiere, al panificio, in tutti i locali pubblici, su tutti i telefonini. In un lutto collettivo, silenzioso, non esibito, che coinvolge – qui – intere famiglie dei rifugiati palestinesi del 1948, metà della popolazione. Al contrario dell’Europa dove viene censurata, qui la kefiah è esibita sulle spalle dei commessi dei supermercati. Ed è il simbolo della Palestina, non di Hamas.
Che tipo di guerra si sta combattendo in questo momento nella striscia di Gaza? Dai siti internet arrivano immagini insostenibili. È una guerra con un obiettivo politico chiaro? Con dei nemici chiari?
Delle immagini ti ho detto. L’obiettivo è proprio la domanda cruciale, quella a cui non si risponde in modo chiaro. E il “non detto” è proprio la questione principale, in questa guerra. La paura, qui ad Amman, e in tutta l’area, è che la guerra iniziata dopo il 7 ottobre abbia un obiettivo di fondo, già detto pubblicamente da alcuni dirigenti israeliani e da documenti ufficiali, come quello del ministero dell’intelligence. Espellere più palestinesi possibile da Gaza, oltre un milione, la metà della popolazione, verso il Sinai, e metterli in una città di tende. Un cortocircuito culturale, oltre che un crimine: l’idea di mettere i palestinesi in una città di tende significa non aver fatto i conti con la propria storia, oltre che con quella della regione. I palestinesi del 1948, della cacciata, della nakba, sono chiamati “quelli delle tende”. È una riproposizione, non solo simbolica, della nakba, che non tocca solo Gaza, ma anche la Cisgiordania, dove ormai sono decine le comunità, i piccoli villaggi palestinesi svuotati dei loro abitanti per la minaccia dei coloni radicali israeliani appoggiati di fatto dall’esercito. In Giordania e in Egitto, la paura è fortissima, l’indignazione anche, e quando la Storia ritorna ha le sembianze di un incubo.

Le abitazioni dei coloni israeliani in Cisgiordania.
Una delle questioni su cui in Italia si è molto dibattuto, dopo il 7 ottobre, è come definire Hamas. Ovviamente non si tratta solo di un problema nominalistico. È un gruppo terroristico islamista? Un’organizzazione paramilitare? Un partito politico estremista radicato sul territorio? Tu che lo studi da anni, puoi venirci in aiuto?
Una storia complessa e anche difficile da raccontare. E lo dico ora, che mi accorgo di studiarla da vent’anni. È una storia fatta di capitoli, di fasi. Di attentati suicidi per oltre dieci anni, dal 1994 al 2005. Di un capitolo, successivo, in cui Hamas decide di partecipare alle istituzioni rappresentative, si presenta alle elezioni municipali e poi a quelle politiche, vince tutto, ottiene la maggioranza, con la benedizione dell’intera comunità internazionale, USA e Unione Europea comprese. E poi inizia il disastro, a mio parere. La comunità internazionale non riesce a gestire un compito difficile ma possibile: costringere Hamas a essere inquadrata nel processo democratico, com’è successo a tanti movimenti armati in tutto il mondo.
Hamas prende il controllo di Gaza, nel 2007, in uno scontro con Fatah, che era stata armata anche dalla comunità internazionale. Da allora i palestinesi sono spaccati in due tronconi territoriali, Cisgiordania e Gaza. Gerusalemme è un sogno lontano. E Gaza è sigillata da allora: un catino su cui le bombe sono cadute dal 2008 in poi, nelle quattro operazioni militari lanciate da Israele sulla Striscia, campagne militari da migliaia di morti totali, prima di questa guerra. L’ala militare di Hamas, le Brigate Ezzedin al Qassam, si è militarizzata, armata più di prima, radicalizzata più di prima, e ha lanciato razzi sulle città israeliane.
Cos’è Hamas? Il braccio politico della Fratellanza Musulmana palestinese, nato agli inizi degli anni Ottanta, in contemporanea con la crisi di Fatah e delle altre fazioni. Islamista, irraggiato nella società palestinese da decenni. Il paragone con l’ISIS non regge: l’ISIS è una operazione di vertice calata su paesi in cui non aveva radici né storia. Hamas è nata dentro la società palestinese, ha usato il terrorismo, anche il 7 ottobre, e per questo sarà processata dai tribunali e dalla storia. Ma c’è anche altro: a dirlo è tutta la letteratura scientifica sull’argomento, globale e anche israeliana. Testi come quelli di Avraham Sela e Shaul Mishal sono testi di riferimento, al pari dei testi di Beverley Milton Edwards, Khaled Hroub, Tareq Baconi. E poi c’è il mio.

Hamas.
Un’altra cosa su cui si dibatte molto è il modo in cui Hamas guarda allo stato di Israele. Al di là delle dichiarazioni formali si può dire che tra gli obiettivi di Hamas c’è la distruzione dello stato d’Israele, o le cose sono più complicate di così?
Molto più complicate. Per questo ho dedicato molte pagine ai due documenti, quello fondativo del 1988, e quello riscritto e approvato da Hamas nel 2017. Il primo, scritto da un insegnante di Gaza, ridondante, retorico, quello appunto che parla della distruzione di Israele senza aver avuto alcun suggello da parte dell’organizzazione, e allo stesso tempo mai smentito. Il secondo, frutto anche delle pressioni e soprattutto del pragmatismo di una parte della leadership, che è stato votato da tutta Hamas. Lì c’è, di fondo, il compromesso sui Due Stati. De facto, il compromesso c’era già nel 2006, quando Hamas decide di partecipare alle elezioni dell’ANP, cioè dell’Autorità Nazionale Palestinese nata dal processo di Oslo come primo prodotto della soluzione dei due Stati.
Se Hamas non avesse vinto le elezioni, ma fosse solo entrata in parlamento, non ci sarebbe stato il miope rifiuto della comunità internazionale e questo pezzo della storia israelo-palestinese sarebbe stato molto diverso. Il documento del 2017 rimane certamente ambiguo, su Israele, come una realtà fisica e istituzionale con cui si può arrivare a un compromesso, a una lunga tregua. Proposta, questa che Hamas ha fatto per decenni. Nessun riconoscimento, ma un periodo di calma. La questione di fondo, ieri come oggi, per israeliani e palestinesi, è il 1948, la nascita di Israele e la nakba. È quella definizione della propria terra “dal Mediterraneo al fiume Giordano” che viene affermata da Hamas, anche nel documento del 2017, e dagli israeliani della destra, dell’estrema destra, ma anche di parte del centro. Anche la terra di Israele è definita dal Mediterraneo al fiume Giordano, è su questo che si fondano le colonie in Cisgiordania. Sono le due terre sovrapposte il nodo della questione.
Che rapporto c’è tra Hamas e i palestinesi? Quanto la prima si può considerare rappresentativa dei secondi? La Palestina ha una reale rappresentanza politica? Questo è un altro tema molto dibattuto qui in Italia.
È l’espressione partitica di una parte dei palestinesi. Dunque è rappresentativa di una parte degli elettori e del popolo palestinese. La rappresentanza politica è una cosa diversa. Mi viene un sorriso amaro quando sento discettare chi non è mai stato in Palestina, e lo sento dire: ma i palestinesi si devono rivoltare contro Hamas, contro i loro rappresentanti. Lo diciamo noi, in Italia, paese che dovrebbe essere ancora libero. La Palestina è un territorio occupato da Israele dal 1967, dove Israele esercita non solo il controllo amministrativo, ma il controllo militare. Non solo sulla Cisgiordania, ma su Gaza, sotto embargo e sigillata in modo totale dal 2007.
“La comunità internazionale non riesce a gestire un compito difficile ma possibile: costringere Hamas a essere inquadrata nel processo democratico, com’è successo a tanti movimenti armati in tutto il mondo”.
Israele si è però ritirata formalmente da Gaza nel 2005. Questo non ha migliorato la situazione? Ti chiedo anche se è corretto parlare di un regime di apartheid inflitto dallo stato d’Israele ai palestinesi. O è un’esagerazione?
L’evacuazione dei coloni israeliani da Gaza, il “disimpegno” di Ariel Sharon del 2005, non fa finire l’occupazione: la rende diversa, sterilizza Gaza dall’esterno mentre continua a occupare all’interno la Cisgiordania e Gerusalemme est. Le Nazioni Unite sono chiarissime, in questo: tutto è “Territorio Palestinese Occupato”, detto al singolare proprio per definire la continuità dei territori, seppur separati.
L’Onu lavora a Gaza in un territorio che considera sotto occupazione e ritiene Israele potenza occupante, con tutti i doveri del caso. E rispondo anche alla domanda sull’apartheid: sì, c’è, l’ho visto con i miei occhi, e non solo per le strade separate che coprono la Cisgiordania e per il Muro di Separazione, ma per il confinamento, anche lavorativo, che c’è nella vita quotidiana. Lo dicono gli israeliani, lo ha scritto «Haaretz» nei suoi editoriali, lo dice Amnesty, lo dice Human Rights Watch. All’interno di Gaza, totalmente sigillata, Hamas è diventato un regime che ha amministrato tutto, e contro il quale c’è stato dissenso e opposizione, anche dal basso, con pochissima libertà di manovra. E anche in Cisgiordania le accuse all’Anp di reprimere il dissenso, non solo quello islamista, ma quello laico, dei giovani, sono state molte, in questi anni.
Oltre Hamas, c’è la possibilità in Palestina per la creazione di istituzioni in grado di portare avanti una lotta politica non violenta? E quindi, più in generale, le condizioni per la creazione di quella che noi chiameremmo società civile?
Ma certo che sì. La pratica non violenta, di base, nei villaggi palestinesi in Cisgiordania così come a Gerusalemme nel quartiere di Sheikh Jarrah nel 2021, è un’altra delle pagine invisibili. Una pratica accolta con la repressione, da parte dell’esercito israeliano, e pure dalle forze di sicurezza palestinesi del governo dell’Anp a Ramallah, e di Hamas a Gaza. Una delle personalità palestinesi che, per fortuna, viene intervistata dalla stampa italiana è Hanan al Ashrawi: il suo passato è noto, e lo trovi con una semplice ricerca su internet. Il suo presente, da molti anni, è quello di esponente della società civile, con il suo centro, il suo portale, il suo lavoro quotidiano. È solo uno dei tanti esempi, assieme a quello di Mustapha Barghouthi. E ci sono i giovani, che non credono né all’Anp né a Hamas, e affermano il loro posto nel mondo, come individui portatori di diritti, palestinesi fuori e dentro i confini della Palestina. Simili agli egiziani, ai siriani, a chi ha chiesto democrazia ed è stato messo in galera. Sono durissimi con noi europei, e hanno ragione: sono postcoloniali, conoscono bene ciò che abbiamo fatto e continuiamo a fare.

Hanan al Ashrawi e Mustapha Barghouthi.
Vorrei che ci parlassi delle dimostrazioni non violente che, negli scorsi anni, i palestinesi hanno organizzato al confine tra Gaza e Israele per chiedere che ai profughi venisse data la possibilità di tornare nelle terre da cui erano stati cacciati. Ci sono informazioni confuse su questo tipo di proteste. Ci sono davvero state manifestazioni non violente di questo tipo? Erano anche appoggiate da Hamas? Sono state, come si legge, brutalmente respinte da Israele? Ti faccio tutte queste domande per capire meglio quali possibilità di interlocuzione non violenta potevano esserci tra Palestina e Israele.
Ne hanno ammazzati tanti, sul confine tra Gaza e Israele, nel 2018. I manifestanti palestinesi pacifici, non organizzati da Hamas, sono stati ammazzati dall’esercito israeliano. Era il 2018, e tutti si ricordano – almeno qui – Trump e Netanyahu che inaugurano l’ambasciata statunitense a Gerusalemme, mentre sull’altra metà dello schermo c’è la Grande Marcia del Ritorno e i suoni dei proiettili, il sangue, le ambulanze. Era nata dal basso, Hamas non la voleva, poi ha capito che non poteva opporsi e l’ha cavalcata. Il rischio è sempre stato questo, sin dalla prima intifada, la rivolta delle pietre accolta dalla repressione dei soldati, e Ytzhak Rabin lo aveva capito, dopo esserci passato attraverso. Attenzione infine a non cadere nella trappola dei luoghi comuni messi in giro dalla propaganda di questi giorni: i primi nemici della fragile democrazia palestinese sono stati invece i politici corrotti della ANP e le Forze di sicurezza ad essa collegate. Storicamente i leader e i sostenitori di Hamas hanno prevalso nelle elezioni locali del 2005, e in quelle politiche del 2006, proprio per un comportamento, forse integralista, ma non corrotto.
“L’Onu lavora a Gaza in un territorio che considera sotto occupazione e ritiene Israele potenza occupante, con tutti i doveri del caso. L’apartheid: sì, c’è, l’ho visto con i miei occhi, e non solo per le strade separate che coprono la Cisgiordania e per il Muro di Separazione, ma per il confinamento, anche lavorativo, che c’è nella vita quotidiana”.
Si scrive molto anche a proposito delle responsabilità di Hamas verso i palestinesi. I soldi arrivati a Gaza in questi anni per lo sviluppo del territorio, l’istruzione, il lavoro, la sanità ecc. sarebbero stati utilizzati da Hamas per incrementare la propria forza bellica. È così?
Nei sedici anni al potere a Gaza, dal 2007 a oggi, Hamas è stato, appunto, potere, amministrazione, leva fiscale, servizi sociali e sanitari. Ricostruzione dei palazzi e delle infrastrutture distrutte dai bombardamenti israeliani. Ci sono stati i tunnel che hanno unito sottoterra Gaza ed Egitto. Tunnel cosiddetti civili, in cui passavano mucche, medicinali, macchine e carburante. E tunnel militari, di cui ovviamente nessuno sa nulla. Cosa è passato da lì? Armi, soldi, consulenze militari? Supponiamo di sì. E quindi quel cemento, il carburante, la farina, i medicinali passati attraverso il valico di Kerem Shalom e attentamente vagliati dal Cogat, dall’organismo militare preposto a controllare anche le viti che sono entrate a Gaza, a cosa sono serviti? Credo soprattutto a dar da mangiare alla gente, in una economica di sussistenza – il de-sviluppo di cui ha scritto benissimo la professoressa americana Sara Roy, l’autorità in materia, docente a Harvard, una delle più grandi specialiste di Gaza – che costringe i palestinesi della Striscia, rifugiati del 1948 da tutta la Palestina storica e soprattutto da Giaffa, a campare di aiuti. Come dicono i palestinesi di Gaza, noi non viviamo qui, aspettiamo di morire.
Che rapporti c’erano, prima dello scoppio di questa guerra, tra Hamas e l’estrema destra israeliana?
Nessuno.
Cosa pensi delle manifestazioni pro-Palestina che ci sono state in Occidente, e quanto sono diverse rispetto a quelle che ci sono nel mondo arabo? Quanto la dura critica alla condotta di Israele e al governo di Netanyahu rischia di mescolarsi con l’antisemitismo? Le inquietanti immagini dell’aeroporto di Makhachkala, in Daghestan, hanno fatto il giro del mondo. Vedi un rischio di antisemitismo anche in Occidente?
Certo che vedo un rischio di antisemitismo! Altissimo rischio. E non “anche in Occidente”: lo vedo in Occidente, perché l’antisemitismo è un frutto malato nostro, dell’Occidente, non certo del mondo arabo. E non basta ricordare il caso del mufti di Gerusalemme, Amin al Husseini, alleato dei nazisti per disconoscere la storia araba e la storia delle comunità ebraiche dentro i paesi arabi. L’antisemitismo è nostra esclusiva responsabilità storica: dobbiamo, cioè, distinguere quello che è successo in Europa per responsabilità europea, prima durante e dopo la Shoah, da quella che è stata la storia delle comunità ebraiche nel mondo arabo, una storia intrecciata a quella nazionale, irachena, palestinese, siriana, libanese, egiziana, marocchina, algerina. Con i suoi chiaroscuri, certo, soprattutto dopo il 1948, ma con differenze abissali.
Basta leggere autori israeliani come Sami Michael, tanto per citarne solo uno, e le sue indimenticabili pagine sulla comunità ebraica di Baghdad. O ascoltare i racconti degli ebrei sefarditi che sono arrivati in Israele da Fez. Basta solo questo per capire che la storia è tutta diversa. Quello che, invece, già succede è un travaso dalla questione israelo-palestinese, tutta politica, all’attacco indiscriminato contro ebrei e contro musulmani. Antisemitismo e islamofobia sono le due facce della stessa medaglia: una medaglia fatta di razzismo, suprematismo, patriarcato, ignoranza dell’Altro.
Come definiresti il governo di Netanyahu? E il suo rapporto con il popolo d’Israele?
Del nostro colpevole vuoto informativo fa parte anche il silenzio – assordante! – sulla protesta che per nove mesi, ripeto nove mesi, ogni sabato e poi anche il martedì – ha riempito le strade e le piazze di tutte le città israeliane, da nord a sud. Centinaia di migliaia di persone ogni sabato in strada contro Netanyahu e il suo governo di estrema destra, in cui ancora oggi siedono due ministri razzisti e suprematisti come Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir. In pochi dicono che, tra le persone massacrate da Hamas, ci sono molti esponenti del pacifismo israeliano. O si parla di Israele come una società complessa e spaccata, come una democrazia con vulnus (l’occupazione in primis), oppure stiamo facendo ancora una volta retorica. Netanyahu ha segnato, purtroppo, la storia israeliana già da prima del 1997, quando è arrivato al potere. Ma non è solo lui il responsabile della debolezza di Israele, anche dal punto di vista democratico, a cominciare dal definirsi Stato ebraico, uno Stato di cui sono cittadini quasi due milioni di palestinesi, musulmani o cristiani, il venti per cento della popolazione.
“L’antisemitismo è nostra esclusiva responsabilità storica”.
Il 7 ottobre ci sono stati gli orrendi attacchi terroristici di Hamas. Sono seguiti i violentissimi attacchi di Israele, molto criticati da una parte dei commentatori e dell’opinione pubblica. Credi che con la risposta di Israele – come affermano i suoi critici – si sia superata la linea che separa la legittima reazione dalla vendetta? Quello di Hamas è terrorismo e questi di Israele crimini di guerra? Si può addirittura parlare (come si legge su alcuni giornali) di genocidio o sono termini sbagliati?
Pochi giorni fa è arrivato un uomo a Rafah, al confine meridionale della Striscia di Gaza, quello controllato dall’Egitto. Si chiama Karim Khan, ed è il procuratore generale del Tribunale Internazionale Penale dell’Onu. L’acronimo è ICC, ed è nato a Roma, nel 1995, sull’onda del tribunali ad hoc sulla ex Jugoslavia e sul Ruanda. C’è chi considera il Tribunale dell’Aja una scatola vuota, chi un organismo che fa troppo poco e troppo in ritardo (come si dice della giustizia italiana). Io ci sono affezionata, proprio dai tempi della ex Jugoslavia e dalla grande lezione che Antonio Cassese diede al mondo scrivendo le regole di quei tribunali ad hoc, oltre Norimberga, e difendendo i diritti degli imputati. Vedere criminali come Ratko Mladic, Radovan Karadzic, Slobodan Milosevic alla sbarra non mi ha dato alcuna gioia, ma il senso profondo di una giustizia che agisce sì.
L’uomo arrivato a Rafah, Karim Khan, ha parlato proprio di “giustizia in azione”, di “giustizia sul fronte”, quel giorno, ed è un uomo che si è formato proprio sui crimini commessi in ex Jugoslavia. Ha aperto le indagini, e anche Israele – che come gli Stati Uniti, la Russia e altri paesi non ha aderito al Tribunale – è nella giurisdizione dello ICC, per quello che sta commettendo. Crimini di guerra li ha commessi Hamas. Crimini di guerra li sta commettendo Israele: non sono solo io a dirlo, sono giuristi e organizzazioni internazionali. Il genocidio è una definizione ben precisa: saranno i giuristi a dirlo. C’è chi già la usa. Io credo che sia già bastante quello a cui assistiamo per rimanere attoniti: il bombardamento a tappeto, indiscriminato, le bombe su ospedali, chiese, moschee, scuole dell’Onu, trasferimento forzato di popolazione, chiusura dei ‘rubinetti’ di acqua elettricità carburante. Non è già abbastanza? Solo chi non è mai stato a Gaza può pensare che una strategia militare che voglia cancellare Hamas non stia, nei fatti, cancellando Gaza. Gaza è (era?) un continuum di palazzi, edifici, cittadine e città per tutta la sua superficie, il posto più densamente popolato e costruito del mondo.
Perché la comunità internazionale non sta riuscendo a fermare una guerra che rischia di allargarsi, e chi potrebbe farlo? L’Onu? Gli Stati Uniti? La Cina? L’Europa? L’Arabia Saudita? Questa crisi, forse anche più di quella ucraina, sembra fotografare un mondo tragicamente fuori controllo.
La comunità globale degli Stati ha perso da un pezzo innocenza, dignità e saldezza morale. Il doppio standard è, ahimè, il peccato originale che ci accomuna. E questa nostra a-moralità perbenista viene descritta al contrario: siamo i portatori dei valori e della democrazia. A guardarla da questa parte, l’impressione è tutta un’altra, e non assolve certo i paesi arabi. È come se guardassimo gli Stati giocare su una cartina di Risiko ormai vetusta, il cartone ormai consumato e stinto. E invece dei carri armati e dei soldati ci fossero i civili, come vittime protagonisti trofei obiettivi. Sono gli ultimi fuochi, o meglio rigurgiti, del cosiddetto ordine di Westfalia, degli Stati nazionali. Ormai, però, siamo nel disordine post-Westfalia da molto tempo. E invece di confini dovremmo parlare di alberi, della storia raccontata dagli alberi, anche qui. Di come noi umani abbiamo sradicato alberi per segnare la terra con le matite, invece di ascoltare ciò che gli alberi (gli uccelli, la terra, i vulcani) avevano da dirci.

Gaza prima e dopo il bombardamento israeliano.
Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, i popoli di alcuni stati europei, fino ad allora in guerra, si sono in effetti riscoperti fratelli. Cosa potrebbe riavvicinare israeliani e palestinesi?
Sai che l’Europa del dopoguerra è uno dei modelli per una possibile soluzione di pace in dignità e rispetto per Israele/Palestina? Non parlo della soluzione dei Due Stati immaginata nel processo di Oslo, morta da anni perché troppo graduale, senza sanzioni per chi ne violava la lettera e il contenuto. Parlo di quello che, dietro le quinte, si sta sviluppando in gruppi, soprattutto di base, che affrontano la questione dai suoi elementi fondanti. Fine dell’occupazione israeliana del Territorio palestinese occupato, che dura da 56 anni e di cui tutti fanno finta di dimenticarsi. Riconoscimento reciproco, non solo dello Stato di Israele ma, allo stesso modo, dello Stato di Palestina. Rifugiati palestinesi e coloni israeliani. Gerusalemme capitale dei due Stati. Un esempio, il più visionario a mio parere, è quello di A Land for All, immaginato da Meron Rapoport e Awni al Mahshi. Due Stati, una terra, una patria aperta a tutti.
Un’alternativa all’idea di “due popoli due stati” è, se non capisco male, quella allora di uno stato per due popoli con diritti uguali per tutti. Mi chiedo però come due popoli in guerra tra di loro, e con idee di governo diverse, e con cultura e religioni diverse, potrebbero mettere da parte l’odio e ridurre le proprie differenze per dare vita a un unico stato.
Hai ragione. La questione degli “uguali diritti per tutti” è centrale: rende impossibile la soluzione di Uno Stato, ma è anche un nodo che ci deve interrogare, non tanto sulle idee di governo diverse, ma sulle basi stesse della convivenza. L’uguaglianza è un problema? Uguali diritti per ciascuno è un problema? Parliamone, dunque, perché è qui che alligna il nostro doppio standard: pensare che un palestinese non aneli a diritti, cittadinanza, democrazia, felicità. È vero, però, che non si può pensare, da anime belle, che l’odio nutrito anche dalla nostra indifferenza (europea) sia possibile superarlo, o che ci sia bisogno di un lavacro di sangue, com’è accaduto a noi, per capire quanto fosse folle. La confederazione è il massimo cui possono aspirare, credo.
In una situazione così drammatica, in quali condizioni riesce ad andare avanti una città come Gerusalemme? Tu ci hai vissuto per dieci anni.
Stavolta la “mia” Gerusalemme la vedo dall’altra parte. Lo sai che da certe parti di Amman la puoi intuire con lo sguardo? Sono alla stessa altitudine, poco più di ottocento metri sul livello del mare, e certe volte, dalla finestra, confondo il panorama di alcune parti di Amman con quello di Gerusalemme: stessa pietra bianca, stessi cipressi. Ci sono solo settanta chilometri di distanza, un valico che affonda nella storia come quello di Allenby, la più profonda depressione della crosta terrestre come il Mar Morto. E la Storia recente, i confini che io chiamo “le matite sulla terra”. Gerusalemme sta male, sta molto male già da prima del 7 ottobre. È uno dei cuori della questione. Anzi, il cuore. Descritta come città unificata da Israele dopo la conquista nella Guerra dei Sei Giorni (1967), è invece una città spaccata, per metà occupata, in cui vivono israeliani (il 60% della popolazione) e palestinesi (circa il 40%). È a Gerusalemme che, non solo simbolicamente, la questione israelo-palestinese è vita quotidiana. Ancora di più in queste settimane, in cui la tensione è altissima.
Come stai tu? Qual è il tuo stato d’animo, in questi giorni?
Grazie. È una domanda inattesa, perché quello che le giornaliste e i giornalisti debbono fare è nascondere bene tutto ciò che è dentro di loro. Come gli attori. L’importante sono i fatti, non noi. L’esibizione del dolore è il contrario di quello che ci è chiesto di fare, per dovere deontologico: le cose sono già drammatiche di per sé, non hanno bisogno delle nostre emozioni. Come sto? Sto come quelli che non hanno tempo per pensare a emozioni, cuore e stomaco perché c’è altro da fare. È quello che ha provato, e prova, Filippo, mio marito, che in questi giorni ricorda spesso Sarajevo, dov’era come inviato della Rai nell’assedio. Incombono giorni presenti e futuri durissimi, come se vedessimo uno tsunami arrivare, sovrastante. Bisogna tenere duro e informare, mantenere l’equilibrio, fornire ciò che ognuno di noi può dare in termini di conoscenza della storia, dei luoghi e delle persone. Se dovessi spiegare cosa provo, dopo ore passate a scrivere e a spiegare ogni giorno, ti direi: la tristezza di Cassandra.
Lo sapevamo, in tanti, lo abbiamo scritto in tutte le salse, per molti anni, ma non è diventato patrimonio di un’informazione allargata. Il vuoto informativo della storia di Israele/Palestina per almeno quindici anni, e chi lo ha scientemente perseguito in Europa, è la nostra vera colpa. Mi ricorda le sensazioni provate al Cairo, nel marzo 2003, mentre vedevamo arrivare la marea montante dell’invasione anglo-americana dell’Iraq. Stessa nausea, stessa malinconia: ci riunimmo una sera, in qualche decina di amici, di “internazionali”, tra funzionari e giornalisti e “umanitari”. Ognuno portò il piatto che amava di più. Era l’ultima cena del tempo di pace.
“Il vuoto informativo della storia di Israele/Palestina per almeno quindici anni, e chi lo ha scientemente perseguito in Europa, è la nostra vera colpa”.
Ti chiedo infine una bibliografia. Consigli di lettura (e di ascolto e di visione) per addentrarci meglio in un mondo di cui sappiamo poco.
Susan Abulhawa, Nel blu fra il cielo e il mare (Feltrinelli), Adania Shibli, Un dettaglio minore (Nave di Teseo), Ibtisam Azem, Il libro della scomparsa (hopefulmonster), Sahar Khalifah, Una primavera di fuoco (Giunti), Suad Amiry, Storia di un abito inglese e di una mucca ebrea (Mondadori). Raja Shehadeh, Dove sta il limite (Einaudi). Poi tutte le poesie di Mahmoud Darwish e quelle di Najwan Darwish, nessuna parentela.
Una mostra è in corso alla Fondazione Merz, molto bella, di un artista palestinese della Cisgiordania, Khalil Rabah, Palestinian Museum of Natural History and Humankind.
Sami Michael, nato a Baghdad, fuggito dall’Iraq e riparato in Israele. Lingua madre l’arabo, lingua acquisita l’ebraico, esponente degli ebrei di Baghdad, capo di una delle più importanti associazioni per i diritti civili in Israele. Fondamentale il suo Victoria (Giuntina), e il suo Rifugio (sempre Giuntina), in cui riprende il filo da dove lo ha lasciato uno dei più importanti intellettuali palestinesi, Ghassan Kanafani, con il suo Ritorno a Haifa (edizioni Lavoro).
Edward Said, tutto pubblicato da Feltrinelli, e il suo amico caro Daniel Barenboim, nel loro libro insieme, Paralleli e paradossi. Pensieri sulla musica, la politica e la società (il Saggiatore).
Per David Grossman, il suo fondamentale Il Vento Giallo (Mondadori), e per Amos Oz un testo meno considerato e invece altrettanto fondamentale, Michael mio (Feltrinelli).
Saggistica, impossibile da trovare in italiano, e invece importante, molto importante, quella di parte palestinese. Rashid Khalidi, lo storico più importante sull’identità nazionale. E soprattutto, ora, Noura Erakat, giurista, attivista: sarebbe da pubblicare in italiano il suo Justice for some.
Un solo film, e tu ne conoscerai moltissimi altri. Elia Suleiman, Il tempo che rimane. C’è già tutto lì.
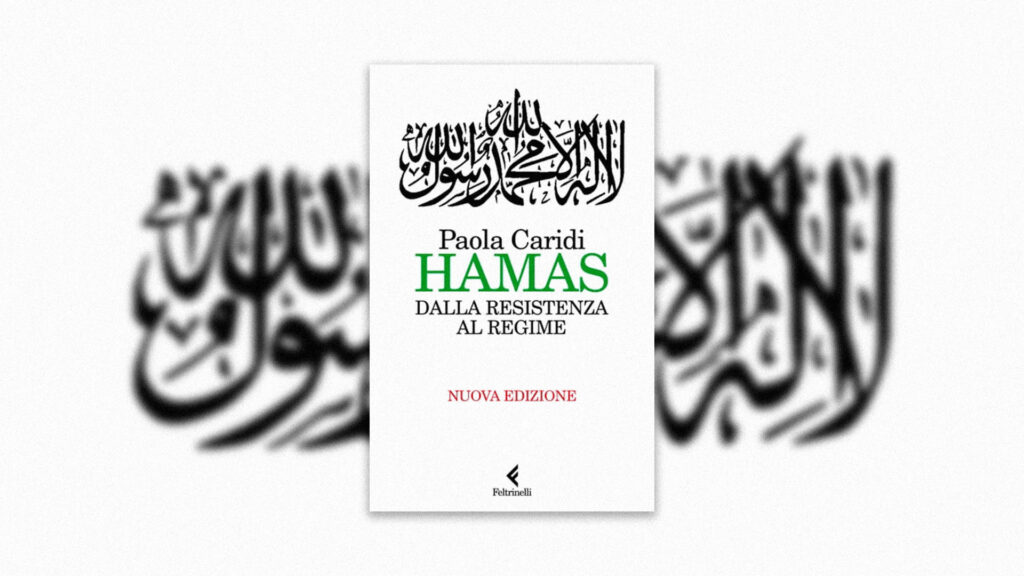
Nicola Lagioia
Nicola Lagioia è scrittore, sceneggiatore, conduttore radiofonico e direttore editoriale di Lucy. Il suo ultimo libro è La città dei vivi (Einaudi, 2020).
newsletter
Le vite degli altri
Le vite degli altri è una newsletter che racconta di vite che non sono la nostra: vite straordinarie, bizzarre o comunque interessanti.
La scriviamo noi della redazione di Lucy e arriva nella tua mail la domenica, prima di pranzo o dopo il secondo caffè – dipende dalle tue abitudini.
Contenuti correlati