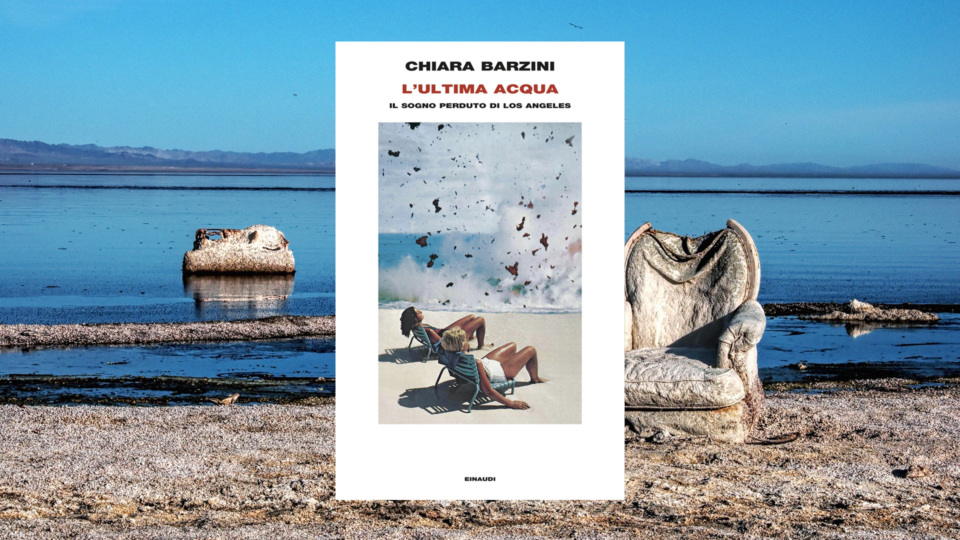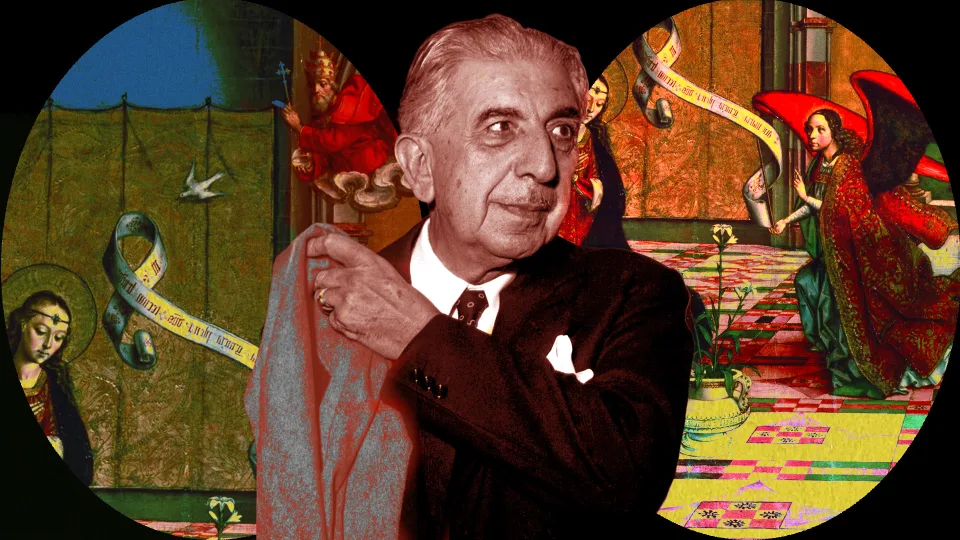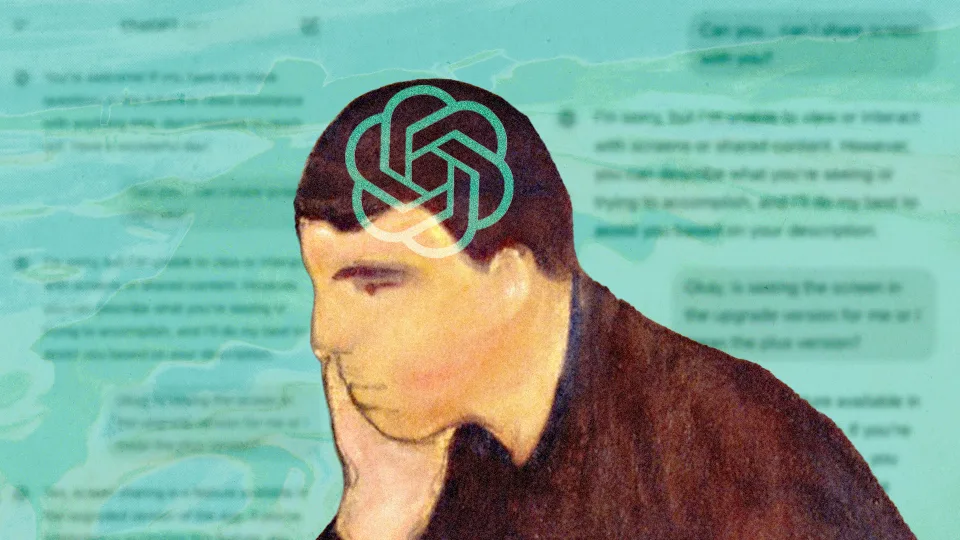Nell'ultimo lavoro della scrittrice si dipanano i destini di tre distinte disillusioni di dimensioni molto diverse ma accomunate tutte dal tono lieve che le racconta.
Ne Il labirinto della solitudine Octavio Paz, poeta e scrittore messicano, premio Nobel per la letteratura nel 1990, raccoglie alcune riflessioni elaborate attorno al 1950 durante una serie di soggiorni in giro per il mondo che hanno al proprio centro il Messico, il carattere dei suoi abitanti e le peculiarità dei loro riti – anche quelli di chi si era sradicato, come i “pachuco”, giovani messicani emigrati negli Stati Uniti, condannati a una dimensione spettrale, segnata dall’allontanamento dalla propria terra e dal rifiuto della nuova cultura.
L’esplorazione di Paz, che a una prima occhiata parrebbe non destinata a suscitare la curiosità di un lettore italiano nel 2025, come sempre avviene con le esplorazioni descrittive degli uomini e delle donne intelligenti, rivela delle intuizioni di carattere mi viene da dire metodologico (cosa si sceglie di osservare della realtà per descriverla nella sua essenza?) e dunque eterne sul modo di guardare a un popolo e alla sua cultura. È l’autore stesso a stupirsi della sua scelta di scrivere del Messico e della sua alienazione – e quindi di sé, della sua alienazione. Nelle prime pagine dice:
“La preoccupazione per il senso delle particolarità del mio paese, che condivido con molti, mi sembrava tempo fa superflua e pericolosa. Invece di interrogare noi stessi, non sarebbe meglio creare, agire su una realtà che non si consegna a colui che la contempla, ma a chi è capace di immergersi in essa? Ciò che può distinguerci dagli altri popoli non è la sempre dubbia originalità del nostro carattere, probabilmente sempre frutto di circostanze mutevoli, ma quella delle nostre creazioni. Ritenevo che un’opera d’arte o un’azione concreta definissero il messicano – non solo perché lo esprimono, ma anche perché, esprimendolo, lo ricreano – meglio della più penetrante delle descrizioni”.
E invece il Labirinto è proprio questo, una penetrante descrizione che nel suo tentativo, amorevole e amaro assieme, di osservare il solitario naufragio del Messico attraverso le storie di alcuni dei suoi abitanti e dei loro usi, riesce a tracciare la storia più vasta di un popolo e delle sue illusioni.
È stato questo intento descrittivo, così umano e malinconico, piccolo ma universale, lontano dal romanzo classico, ad affiorare alla mia mente mentre leggevo L’ultima acqua, di Chiara Barzini (Einaudi). Barzini è scrittrice e sceneggiatrice, sospesa tra un’infanzia italiana e un’adolescenza e giovinezza californiana, che culmina con il ritorno in Italia in età adulta. Al pari del Labirinto, anche L’ultima acqua non potrebbe esistere senza un allontamento dai luoghi che racconta; solo da lontano i contorni delle cose si definiscono.
Ed è un bel problema, aggiungo io, quando sono i luoghi a scandire le età della vita, perché la memoria si confonde e si tende a credere che sia la geografia e non lo scorrere del tempo a determinare la propria identità, e che dunque basti tornare nel luogo in cui si è stati giovani e speranzosi per ritrovare l’euforia inviolata dei vent’anni.
E così L’ultima acqua mescola il ricordo nostalgico di un’età trascorsa al viaggio geografico attraverso la California e le sue illusioni grandiose – oggi percorse da ragnature di crepe che si allungano sul marmo finto di Las Vegas, sul fondo delle piscine vuote di California City, e che infine sono bruciate assieme ai muri delle architetture sofisticate che le accoglievano negli incendi losangelini. Ed è anche il percorso di disincanto di Barzini stessa, che insegue la chimera del successo hollywoodiano, rappresentato da un celebre regista interessato a produrre un film dal suo precedente romanzo, che si ritrae ogni volta che le pare vicino. La sua ambizione di sfondare nel mondo del cinema evapora man mano che ci si addentra nella pagine del libro, come le acque dei laghi artificiali del deserto, i cui alvei melmosi svelano resti umani, appartenuti a uomini e donne che hanno vissuto il miraggio delle promesse della West Coast ben prima che queste presentassero loro il conto.
Barzini racconta dunque una California molto diversa da quella che ha conosciuto in gioventù – e che abbiamo conosciuto noi attraverso i film e i libri di un’America che un tempo ci appariva vicinissima, sorella, vitale –, e lo fa descrivendo i luoghi che attraversa e ascoltando le voci soffocate di coloro che nel corso del XX secolo avevano provato a fermare la speculazione idrica e abitativa di un luogo che è riuscito a camuffarsi da utopia meravigliosa, ricca, florida, abbeverata da un’acqua cristallina e abbondante che non gli è mai davvero appartenuta. Da sempre gli uomini e le civiltà, accecati da caduci periodi di ricchezza, da repentini apogei, sfidano i luoghi più impervi, nel tentativo struggente di ingannare la natura, di fermare la morte. Viene in mente The Line, la città verticale lunga 170 chilometri che dovrebbe attraversare il deserto dell’Arabia Saudita, i cui rendering, al pari delle fantasie californiane, mostrano giardini sospesi dissetati da grandi quantità di acqua turchese. Di queste grandi imprese edilizie di solito rimangono solo i resti fossili delle ambizioni che le hanno generate.
“Barzini racconta dunque una California molto diversa da quella che ha conosciuto in gioventù – e che abbiamo conosciuto noi attraverso i film e i libri di un’America che un tempo ci appariva vicinissima, sorella, vitale”.
Ma il destino dell’America non appartiene a lei e basta, è un destino che ha riguardato anche l’Europa, essendo stata costruita e abitata per la prima metà del Novecento da europei squattrinati che si sono reinventati e hanno reinventato anche i luoghi di origine, trasponendoli nel cinema e nei romanzi. Attualmente l’Europa – e la sua cultura – è molto meno presente negli Stati Uniti, come dimostra il disprezzo di Trump e del suo entourage. Chi arriva in America oggi è più simile ai pachuco di Paz, e con gli italiani di inizio Novecento ha poco in comune eccezion fatta per il razzismo che li accoglie. L’America si è allontana dall’Europa e da se stessa, e a noi non resta che guardarne incuriositi e spaventati la rivoluzione che la attraversa.
Parallelamente al percorso di decadenza della California, scorre quello più intimo della scrittrice. Qui il passo è dinoccolato, un po’ goffo, ma forse proprio in virtù di queste imperfezioni, adorabile. Barzini racconta, senza soffermarcisi troppo, quasi di sfuggita, del suo corpo e di quello delle amiche: un tempo giovane, tonico, ora si sfalda lentamente dopo aver nutrito quello dei figli. Tutto il libro è punteggiato di piccole disillusioni personali, come quando Barzini vede una cinghiala con i cuccioli con la quale crede di instaurare un tacito e incantato accordo di sorellanza, per poi venirne attaccata non appena l’animale la nota. Tante minime credenze in frantumi, raccontate da una voce naif e sincera che intenerisce per il candore.
Non c’è però solo il fallimento intimo, quello fisico, materno, che tanto è stato raccontato dalle scrittrici. C’è soprattutto, come detto, quello professionale, che forse oggi è il più difficile da raccontare. Così attenti alle vite altrui e ai piccoli successi accuratamente selezionati da mostrare sui social per ricamare una versione di noi stessi molto lontana da quella reale, il fallimento – che esiste, anche se la retorica comune vorrebbe altrimenti – è un serpente arrotolato sul fondo dello stomaco, che morde non appena si resta da soli. In questo senso il coraggio di Barzini è affrontarlo, soffermandosi sulla gioia arrogante che precede la vittoria apparentemente dietro l’angolo, sullo stato di negazione che prelude a un finale che faremmo di tutto pur di schivare. Dopo il fallimento non c’è granché: non una rivincita, non una ribalta, non un insegnamento fondamentale che rende migliori. C’è, nel caso di Barzini, questo curioso libro profondo e dal passo deliziosamente dondolante, che senza alcuna superbia riesce a raccontare qualcosa di molto più grande di sé.