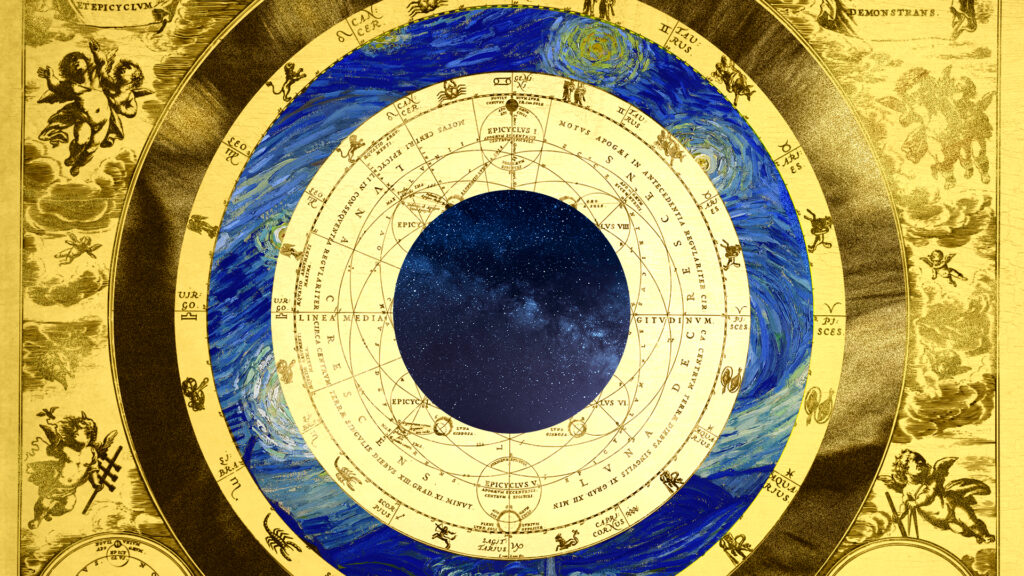Fabio Deotto
La nostra dipendenza dal petrolio è anche culturale

I combustibili fossili sono la droga dell'umanità. Dal punto di vista energetico ed economico, ma anche da quello psicologico e culturale: siamo dipendenti dalla crescita e dall’accumulo. In epoca di crisi climatica abbiamo bisogno, però, di un cambiamento radicale. Riusciremo a disintossicarci?
Da un po’ di tempo mi trovo a pensare che le conversazioni da bar godano di un’ingiusta nomea. Tutto è cominciato qualche mese fa: stavo prendendo un caffè dalle parti di Lorenteggio, c’era un televisore appeso a un angolo, al telegiornale si parlava di come il governo italiano stesse insistendo in sede UE per includere i biocarburanti tra le alternative sostenibili per i veicoli privati. La persona accanto a me, un signore sulla sessantina con uno schnauzer al guinzaglio e un quotidiano sottobraccio, ha aspettato che il servizio finisse e ha decretato: “Ecco, ovunque cercano un modo per disintossicarsi, e noi ancora crediamo al metadone”.
Ora, non saprei dire se quell’uomo fosse effettivamente ferrato in politiche energetiche o se avesse solo cavato di tasca una battuta insieme agli spicci per il caffè, fatto sta che il parallelo era tutt’altro che campato per aria.
I biocarburanti – ossia i combustibili ottenuti a partire da prodotti e scarti di origine vegetale e animale – rappresentano una finta alternativa: se è vero che consentono una riduzione di emissioni rispetto ai combustibili tradizionali, è anche vero che per ottenere la quota di biodiesel e bioetanolo consumata nella sola UE dobbiamo sfruttare un’area coltivata delle dimensioni della Grecia. Se poi consideriamo l’aumento della deforestazione diretta e indiretta, il maggiore consumo di suolo e di acqua, la perdita di biodiversità e di nutrienti organici, l’impatto complessivo in termini di emissioni e degrado ambientale diventa pari se non superiore a quello dei combustibili fossili. In uno scenario di progressiva elettrificazione e decentralizzazione dell’approvvigionamento energetico, insistere sui biocarburanti, di fatto, serve a far sì che il settore automobilistico resti almeno in parte legato a una forma di energia centralizzabile, la cui produzione e distribuzione possa essere gestita e controllata da pochi. In un certo senso è il tentativo di sostituire una dipendenza con un’altra.
“Se dal punto di vista energetico siamo dipendenti dagli idrocarburi, psicologicamente siamo dipendenti dall’idea di mondo che il loro sfruttamento ha plasmato, l’idea che il progresso sia una linea che si impenna”.
Ma la frase del tizio con lo schnauzer mi ha colpito anche perché proponeva un orizzonte di riflessione più ampio, che fino a quel momento non avevo considerato, e cioè: se la dipendenza che nei secoli abbiamo sviluppato nei confronti del sistema fossile non fosse solo energetica ed economica, ma anche psicologica e culturale, come faremmo a liberarcene davvero? Basterà una decarbonizzazione a disintossicarci?
Tabagisti, alcolisti e fossilisti
Di recente ho recuperato Dune – Parte Due, e mentre guardavo Timothée Chalamet arpionare vermi ipertrofici mi sono reso conto di una cosa che nel primo film mi era sfuggita, ovvero che buona parte del film e del suo universo narrativo ruotano intorno a una sostanza psicotropa – la spezia Melange – i cui effetti sull’individuo però non vengono quasi mostrati, fatta eccezione per le premonizioni che induce nel protagonista. La storia della fantascienza abbonda di droghe inventate, in molti casi sono l’espediente per esplorare orizzonti interiori e a emergere è il potere che esercitano sull’individuo; il caso di Dune, però, è diverso: qui il punto focale è il potere che questa sostanza esercita sulla realtà esterna. La spezia del resto è molto più di una droga allucinogena: ha la capacità di allungare la vita di chi la assume, è in grado di conferire maggior vigore e consapevolezza, ma soprattutto, permette ad alcuni individui di sviluppare abilità di preveggenza fondamentali per pilotare navicelle a una velocità superiore a quella della luce – rappresenta quindi la conditio sine qua non per i viaggi interstellari.
“Chi controlla la spezia controlla l’universo”, la frase che Denis Villeneuve ha mutuato dal film di David Lynch del 1984 per usarla come esergo, si adatta più facilmente a descrivere una risorsa scarsa assurta a strumento di potere – come appunto il pepe del XVI secolo e altre spezie – rispetto a una sostanza psicotropa. Per la Melange si combattono guerre e si colonizzano pianeti, per estrarla si devastano interi ecosistemi, le oscillazioni nella sua produzione finiscono per ingolfare intere economie: non è un caso che molta critica l’abbia intesa come una metafora del petrolio. Come non è un caso che oggi il sottotesto ecologico di Dune assuma una rilevanza maggiore di quando il primo libro è stato pubblicato: se fossimo degli alieni in arrivo sulla Terra, probabilmente l’umanità di oggi apparirebbe come una specie che ha fondato un’intera civiltà sull’estrazione e lo sfruttamento di combustibili fossili, una fonte di energia in via di esaurimento, il cui utilizzo ha causato un’emergenza climatica per certi versi irreversibile, e che pure continua ad alimentare scontri geopolitici e fantasie di crescita illimitata.
Già nel 2013, l’economista americano Steven Suranovic aveva applicato i modelli comportamentali della dipendenza da sigarette allo studio dei consumi fossili, individuando paralleli interessanti: in entrambi i casi abbiamo a che fare con il consumo di un prodotto vantaggioso nell’immediato che causa effetti dannosi nel futuro, e in entrambi i casi la presa di coscienza del problema e la dichiarata volontà di smettere spesso non si traducono in un’effettiva interruzione della dipendenza.
Per quanto incomplete, queste analogie possono tornare utili, soprattutto se vogliamo indagare i limiti cognitivi e culturali che stanno rallentando la decarbonizzazione, ma bisogna stare attenti all’uso che ne facciamo. Prendiamo per esempio Hersh Shefrin, professore di Economia comportamentale alla Santa Clara University: a suo avviso la dipendenza dai fossili sarebbe simile all’alcolismo, e buona parte dell’umanità sarebbe accostabile a una torma di disperati che bascula tra l’ubriacatura e i postumi. Shefrin è talmente convinto di questo parallelo che si spinge a dire che abbiamo già a disposizione una via d’uscita dalla dipendenza: “Siamo tutti al corrente del fatto che i prodotti con ingredienti costosi tendano a essere più cari; e noi tendiamo a ridurne l’acquisto”. Dice Shefrin: “Se riconosciamo e trattiamo le emissioni di anidride carbonica come un ingrediente di un prodotto, possiamo rendere il prodotto più costoso tassando il carbonio.”

Il che però è vero solo in parte. Tralasciando il fatto che il consumo virtuoso che Shefrin auspica è in buona parte appannaggio di una minoranza benestante della popolazione, anche nell’improbabile caso in cui dall’oggi al domani riducessimo al minimo la nostra impronta di carbonio il problema non sarebbe risolto. Innanzitutto perché i consumi individuali rappresentano una fetta minoritaria delle emissioni globali e il petrolio è una componente strutturale del nostro sistema economico e produttivo; ma soprattutto perché la nostra dipendenza dai fossili è più collettiva che individuale.
Un’idea di mondo accelerata
Quand’ero piccolo la parola “progresso” da sola bastava ad accendermi una scintilla negli occhi. Leggevo avidamente tutte le riviste scientifiche che mi capitavano a tiro, ritagliavo le sezioni con le nuove scoperte e le nuove invenzioni, nel frattempo divoravo i romanzi di Herbert G. Wells e le antologie di Isaac Asimov, storie che spesso promettevano un’evoluzione scientifica e tecnologica esponenziale. Il futuro era un’ascesa priva di interruzioni, un percorso costellato di scrigni pieni di sorprese rivoluzionarie ad appannaggio di un’umanità che io, animato da un ottimismo privilegiato, immaginavo destinata a un perpetuo miglioramento.
Quando mi chiedevano cosa avrei voluto fare da grande, rispondevo senza esitazione “lo scienziato”, anche se in realtà avrei voluto rispondere “l’inventore”: non volevo davvero studiare, volevo una parte attiva nel progresso. Sognavo ancora il futuro che la fantascienza aveva imposto all’orizzonte ben prima che io nascessi, un orizzonte fatto di auto volanti, basi lunari e teletrasporto.
Poi sono diventato adulto, il futuro è arrivato e non assomigliava per niente a quello che ci era stato promesso. Ci ritroviamo ad abitare un futuro tascabile, più a forma di smartphone che di auto volante, in cui i salti di qualità che avevamo preconizzato sembrano ogni giorno più lontani. Se abbiamo sbagliato le previsioni è in parte colpa della tendenza umana a tratteggiare il futuro con il pennarello grosso, ma è anche dovuto al fatto che l’idea di progresso che ci hanno venduto (e che qualcuno si ostina a spacciare ancora oggi) non contemplava la possibilità che a un certo punto avremmo cominciato a rallentare.
Si parla di Grande Accelerazione per indicare il periodo, cominciato negli anni Cinquanta del Novecento, in cui si è registrato un ripido e costante aumento dell’attività umana su diversi fronti, un’impennata resa possibile da un’ampia disponibilità di combustibili fossili come carbone, petrolio e gas. Parliamo di un periodo unico nella storia dell’umanità, caratterizzato da un’espansione economica e produttiva senza precedenti, una crescita apparentemente inarrestabile che ha plasmato la nostra cultura, il nostro immaginario e, inevitabilmente, il nostro modo di guardare al futuro. L’utilizzo sregolato di combustibili facilmente trasportabili e stoccabili, con un’elevata densità energetica, ci ha portato a superare tantissimi limiti, ma anche a sviluppare aspettative distorte, proiezioni accelerate di un mondo abituato a correre.
“Di fronte alla reale prospettiva di disintossicarci collettivamente, troviamo ogni scusa possibile per scansare la sobrietà, ci ostiniamo a cercare potenziali surrogati degli idrocarburi. Siamo persino disposti a negare la realtà”.
Ma come nel caso della spezia di Dune, anche queste sono allucinazioni. A conti fatti, la maggior parte delle curve di crescita che hanno cullato i nostri sogni di progresso si stanno ingobbendo verso un plateau. L’economia globale sta rallentando, come sta rallentando la crescita demografica (con buona pace di chi sventola ancora le problematiche teorie di Paul e Anne Ehrlich sulla sovrappopolazione per giustificare un pigro fatalismo), per quanto possa suonarci strano sta rallentando il progresso tecnologico, e in molte nazioni persino il consumo energetico pro capite; eppure noi ci ostiniamo a voler correre. Questo perché abbiamo un sistema economico che è incardinato ai combustibili fossili e alla crescita, certo, ma anche perché, è il caso di prenderne atto, siamo un po’ tutti fossilisti.
Una dipendenza collettiva
La nostra droga non è una spezia defecata da gargantueschi vermi spaziali, ma è ugualmente potente. Se dal punto di vista energetico siamo dipendenti dagli idrocarburi, psicologicamente siamo dipendenti dall’idea di mondo che il loro sfruttamento ha plasmato, l’idea che il progresso sia una linea che si impenna, che il controllo umano sulla Natura sia solo una questione tecnologica, e che non esistano traguardi che non possano essere raggiunti.
La dipendenza del resto è il prodotto di un processo di apprendimento, il nostro circuito del piacere viene progressivamente educato a rilasciare dopamina in associazione a specifiche sostanze, ma anche a specifici comportamenti e accadimenti. Ed è interessante ragionare su quali tipi di comportamenti e accadimenti vengano premiati: dall’infanzia fino all’età adulta riceviamo una gratificazione esterna quando superiamo un nostro limite, quando prendiamo un voto superiore alla media, quando vinciamo una gara, quando otteniamo un aumento di stipendio o uno scatto di carriera; insomma: quando riusciamo a distinguerci dalla massa; per contro riceviamo poche gratificazioni per aver mantenuto una situazione stabile, o per esserci dedicati alla cura e alla manutenzione. È anche per questo che oggi la crescita ci risulta più appetibile della stasi.
Questa dipendenza dalla crescita e dall’accumulo si declina sia a livello individuale che collettivo. Come individui accettiamo a fatica l’idea di limite, e anche se nel corso della vita arriviamo a guadagnare poco più di quello che ci serve per vivere, troviamo lo stesso sbagliato, per non dire osceno, negare ad altri la possibilità di accumulare enormi quantità di denaro o di consumare in modo eccessivo e dannoso per il pianeta. Come società non ci comportiamo tanto diversamente: ancora fatichiamo a concentrare i nostri sforzi verso la cura e la tutela della ricchezza naturale esistente, preferendo orientare le scelte politiche ed economiche alla massimizzazione e all’accumulo di una ricchezza fittizia come quella monetaria.
Dal punto di vista del capitalismo fossile l’emergenza climatica rischia di sembrare un’equazione particolarmente difficile da risolvere, un dosso particolarmente ostico superato il quale potremo tornare ad accelerare. Ma basta tenere conto di come abbiamo già superato la maggior parte dei limiti planetari oltre i quali l’ambiente potrebbe non essere più in grado di autoregolarsi, per capire che l’emergenza climatica non è un dosso, bensì una battuta d’arresto.
La situazione emergenziale in cui ci troviamo, infatti, non è determinata soltanto dalle emissioni di gas serra, ma anche da uno sregolato consumo di suolo, acqua e altre risorse, dal degrado forestale, dalla perdita di biodiversità, dall’accumulo di inquinanti nell’ambiente, dalla modifica dei cicli biochimici dell’azoto e del fosforo: tutti problemi riconducibili all’attività umana e spesso slegati dalla questione energetica.
Di conseguenza, un processo di disintossicazione collettivo non potrà esaurirsi in una semplice decarbonizzazione del comparto energetico e produttivo: l’eliminazione degli idrocarburi non neutralizzerebbe la nostra dipendenza dall’idea di mondo che hanno alimentato. Amitav Ghosh l’ha spiegato bene ne La maledizione della noce moscata: “Cinque secoli di storia hanno dato ai paesi più ‘progrediti’ del mondo un interesse strategico a perpetuare il regime globale dei combustibili fossili”.
Se anche domani trovassimo un surrogato del petrolio pulito, inesauribile, economico e ugualmente centralizzabile, più che una soluzione avremmo trovato una solida stampella per un sistema insostenibile.
Una disintossicazione trasversale
Chiunque abbia letto il graphic novel Metax (Add, 2024), avrà individuato diversi punti di contatto tra le tavole di Antoine Cossé e le pagine di Frank Herbert. Come in Dune, anche la civiltà raccontata da Cossé ha basato la propria prosperità su una sostanza che viene utilizzata praticamente per tutto: il Metax serve ad alimentare il sistema economico e produttivo, ha proprietà terapeutiche, allucinogene e metamorfiche, è difficilmente reperibile e le sue riserve sono custodite da un popolo ribelle. Tra le due opere però c’è una differenza fondamentale: se Dune racconta il tentativo di controllare (o sostituire) una sostanza scarseggiante, Metax racconta il tentativo di liberarsene. Di fatto, è la storia di una disintossicazione collettiva.
Nel fumetto di Cossé questa disintossicazione avviene tramite un’insurrezione armata e la distruzione delle riserve di Metax. La Grande Disintossicazione dal sistema fossile in cui siamo nati e cresciuti sarà auspicabilmente meno violenta, ma sicuramente più complicata.
In un saggio del 2010, riflettendo sulla crisi economica che aveva stravolto il mondo pochi anni prima, il sociologo Gunther Teubner sosteneva che quel disastroso passaggio fosse stato il prodotto collaterale di una dipendenza collettiva; nello specifico: di un’assuefazione allucinata all’idea della crescita infinita.
“Nemmeno Alan Greenspan immaginava che organizzazioni così razionali potessero agire in modo tanto irrazionale, e contro i loro stessi interessi”, scrive Teubner. “Per comprendere le crisi sociali dovremmo andare oltre l’analisi dei singoli fattori e individuare le pulsioni di crescita autodistruttive dei flussi di informazione; in altre parole, i fenomeni di dipendenza collettiva”.
Teubner si riferiva alla crisi finanziaria, ma il discorso si potrebbe applicare anche a quella climatica. Anche in questo caso, infatti, la politica e gli altri attori coinvolti stanno ignorando le avvisaglie della crisi, aspettando che questa si manifesti in modo incontrovertibile. Il problema è che siamo poco equipaggiati a inquadrare un problema tanto complesso e distribuito nello spazio e nel tempo come la crisi climatica.
C’è dunque bisogno di prendere atto di questa nostra cecità selettiva e giocare d’anticipo. Oltre a predisporre un abbandono dei fossili, sarebbe utile trovare un punto di fuga diverso dalla crescita. Tornando nella metafora della dipendenza: serve uno scopo di vita che consenta di tenerci alla larga dalle ricadute e da qualsivoglia metadone. Ma prima ancora è necessario predisporre delle trasformazioni strutturali dei meccanismi che rendono il sistema intrinsecamente tossico. Teubner ne individua diverse: una riforma monetaria che sottragga le valute all’imperativo della crescita, ad esempio, l’abbandono del PIL come parametro di riferimento, o l’introduzione nelle carte costituzionali del diritto fondamentale ad un ambiente sostenibile.

Alcune di queste prospettive ci paiono utopistiche, ideologiche, lontane dalla realtà. Ci dovrà pur essere un’altra soluzione, ci dice una vocina nel retro del cranio, ci dovrà pur essere un modo per risolvere il problema senza dover ribaltare tutto. Un autentico cambio di paradigma, del resto, non è solo economicamente complicato, è anche faticoso da immaginare. Perché l’evoluzione ci ha dato in eredità un ingombrante bias dello status quo, certo, ma soprattutto perché abbiamo imparato a subordinare il nostro appagamento personale e sociale a un sistema tossico.
E qui che torniamo al discorso dell’uomo con lo schnauzer: di fronte alla reale prospettiva di disintossicarci collettivamente, troviamo ogni scusa possibile per scansare la sobrietà, ci ostiniamo a cercare potenziali surrogati degli idrocarburi, sistemi per catturare l’anidride carbonica in eccesso, prospettive geoingenieristiche per ridurre artificialmente le ricadute della crisi climatica. Siamo persino disposti a negare la realtà.
Lo scorso 21 novembre il CEO dell’azienda petrolifera Adnoc, Sultan Al Jaber, ha dichiarato che “non esiste alcuna evidenza scientifica, né alcuna proiezione, che mostri come l’eliminazione graduale dei combustibili fossili sia ciò che permetterà di mantenerci al di sotto degli 1,5°C”. Una frase platealmente falsa, in totale contraddizione con quanto la comunità scientifica mostra compatta ormai da decenni.
Poteva tranquillamente essere la battuta distratta di una conversazione da bar. A pronunciarla invece era la stessa persona che di lì a poche settimane avrebbe presieduto i lavori di COP28, il tavolo internazionale più importante per la lotta alla crisi climatica.
Sarei curioso di tornare in quel bar a Lorenteggio, parlare di nuovo con quel tizio, incalzarlo sulla presidenza COP28. Me lo immagino a tracciare un parallelo con quei pusher che si infiltrano di soppiatto nelle cliniche di disintossicazione in cerca di clienti. Anche in questo caso il parallelo sarebbe meno campato per aria di quanto potrebbe sembrare.
Fabio Deotto
Fabio Deotto è scrittore e giornalista. Il suo ultimo libro è L’altro mondo. La vita in un pianeta che cambia (Bompiani, 2021).
newsletter
Le vite degli altri
Le vite degli altri è una newsletter che racconta di vite che non sono la nostra: vite straordinarie, bizzarre o comunque interessanti.
La scriviamo noi della redazione di Lucy e arriva nella tua mail la domenica, prima di pranzo o dopo il secondo caffè – dipende dalle tue abitudini.
Contenuti correlati